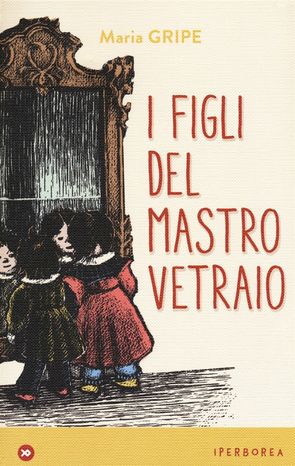Maria Gripe, I figli del mastro vetraio, Iperborea, da 9 anni.
Una bottega di vetraio, due giovani sposi e i loro bambini. Comincia in atmosfere domestiche e quotidiane questo romanzo di grande forza simbolica, che poi conduce il lettore in terre fantastiche, dove una Sovrana si ammala perché non ha più nulla da desiderare, dove un Sovrano per guarirla le porta due bambini, dove aleggia l’inquietudine di strani e intensi personaggi. Uscito nel 1964 in Svezia, dalla fervida penna di Maria Gripe (1923-2007) e illustrato dal marito Harald, I figli del mastro vetraio torna ora a disposizione dei lettori di lingua italiana (era uscito da Mondadori trent’anni fa), grazie all’editore Iperborea e alla sua bella collana per ragazzi I Miniborei (una vera collana, progettata con un disegno editoriale, con l’evidente intento di selezionare libri di qualità e farne traduzioni – come questa di Laura Cangemi – di altrettanta qualità).
Il lettore è ammaliato da questa storia, la quale sotto la levità di una fiaba fa trasparire temi archetipici, che affondano nel patrimonio mitico di tutti noi. La prima scena ci presenta la famigliola di Alberto, il mastro vetraio. I vetri di Alberto sono bellissimi ma il suo bimbo già intuisce «che ciò che è più bello» è anche «più fragile». Una fragilità che avverte anche Sofia, la mamma, tormentata dal senso di colpa per aver detto in un momento di stanchezza che i bambini le erano di impiccio: «Non pensava affatto quello che aveva detto – nessuna mamma può pensarlo – e si pentì subito. Proprio lei che era così orgogliosa e contenta dei suoi figli! L’aveva detto solo perché gli insidiosi pensieri che le frullavano in testa avevano preso per un attimo il sopravvento».
La fragilità di ognuno di noi, l’impossibilità di proteggere appieno chi amiamo, ma soprattutto il saper vedere e accettare le luci e le ombre del nostro animo, sono solo alcune delle chiavi di questo romanzo. Ce ne sono molte di più: c’è ad esempio, come dicevamo, una Sovrana depressa (o ancor meglio: «senza desideri») e c’è una vecchia misteriosa e saggia con un corvo ancora più saggio. Più saggio perché ha due occhi speciali, uno per vedere «la luce, la gioia di vivere, i pensieri allegri, il bene». L’altro per vedere «le ombre e il dolore». Solo così, solo integrando le ombre, si può davvero sconfiggere il male.
Le paroline magiche, collana «Piccini Picciò», De Agostini, da 18 mesi.
È un librotto quadrato semplicissimo, senza pretese. Eppure può avere un suo senso preciso nell’essere proposto a bimbi che iniziano a scoprire il linguaggio e le relazioni sociali. In contesti in cui ogni bambino può identificarsi, i personaggi si salutano, dicono grazie, per favore, prego, scusa, e tutte quelle esclamazioni o espressioni di cortesia che dovrebbero, al di là di ogni moralismo, stare alla base di ogni comportamento quotidiano. Perché la cortesia non è una mera formalità, è un riconoscere l’altro. Riconoscimento e riconoscenza: due termini che fondano la nostra esistenza. Il mio io si esprime nel riconoscimento dell’altro da me. Il mio io assume il fatto che non tutto gli è dovuto.
Spesso ai bambini viene concesso di non salutare, di non ringraziare, di non entrare con rispetto nelle vite degli altri, perché si sa sono bambini. Ma è proprio perché sono bambini che andrebbe loro offerta – con leggerezza e senza pedanteria – l’opportunità di comprendere l’importanza del rivolgersi al mondo con gentilezza. E questi personaggi, disegnati dall’illustratrice e grafica bolognese Beatrice Tinarelli ne sono un simpatico esempio. Tanto più che i loro dialoghi non si limitano alle citate formule di cortesia, ma vanno più a fondo, e più al cuore degli interlocutori. C’è ad esempio la solidarietà e la condivisione: Posso aiutarti?, chiede una bimba a un’altra bimba; o l’espressione di un affetto, Ti voglio bene! dice un bimbo abbracciando la nonna.