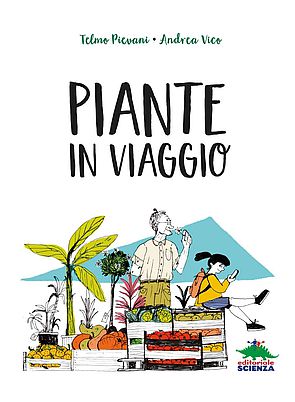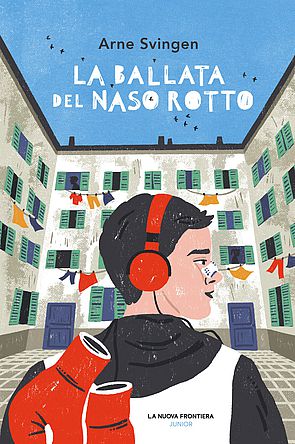Telmo Pievani-Andrea Vico, Piante in viaggio, Editoriale Scienza. Da 9 anni.
È un racconto ma è soprattutto un piacevolissimo libro scientifico, o meglio è un libro scientifico divulgativo in forma di narrazione, secondo la migliore tradizione della casa editrice triestina Editoriale Scienza.
Il tema, non frequente nei libri per ragazzi, è legato alla produzione vegetale, ossia all’interazione uomo-piante. La storia dell’agricoltura, quali piante ci nutrono, e quali loro parti, come ne eliminiamo l’eventuale tossicità, o le «domestichiamo» selezionandole nel corso della loro lunga evoluzione, l’importanza dei semi, le varietà di cereali, i legumi, le spezie, e soprattutto i viaggi che ha compiuto nel corso della storia tutto ciò che ci arriva sul tavolo. Non pensiamo ai prodotti ovviamente esotici, come la banana, o il caffè, o il cioccolato, ma a quelli che hanno un’aria molto «di casa nostra», eppure... Le mele, ad esempio. Vengono dalle nostre campagne, certo, ma il progenitore del melo (Malus domestica) viene dalle regioni montuose tra il Kazakistan e la Cina, e le mele sono state domesticate in Cina tra il secondo e il terzo millennio prima di Cristo. Così anche per il pomodoro, che viene dalle Americhe, prima che dall’orto dietro casa. Moltissime altre piante sono «migranti», perché, come si dice nel libro, le piante hanno radici ma si spostano molto!
Il filo narrativo, su cui agganciare le tante informazioni scientifiche, racconta di una giornata al mercato di un nonno e della sua nipotina. Il nonno è biologo, sa tante cose, ma molte altre vengono integrate dalle persone che incontrano tra le bancarelle: per lo più venditori di varie regioni culturali e geografiche, che porteranno la giovane Giulia a organizzare una cena «planetaria», con tanto di ricette a fine volume.
Un libro interessante, realizzato in collaborazione con l’Università di Padova e con il suo orto botanico (il più antico orto universitario al mondo)e scritto da Telmo Pievani, evoluzionista e docente di Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova, e Andrea Vico, giornalista scientifico.
Arne Svingen, La ballata del naso rotto, La Nuova Frontiera Junior. Da 11 anni.
Giusto per inquadrare il contesto: Bart ha tredici anni, vive in una casa popolare (sulle cui scale può capitare di incontrare disperati e borderline), ha una mamma obesa, incline all’alcol e forse depressa che si ripromette ogni giorno di trovarsi un lavoro stabile ma fa quello che può, il papà non l’ha mai visto (anche se vorrebbe tanto trovarlo), a scuola non è proprio collocato tra il peggio degli sfigati ma di certo neanche tra quelli popolari, e frequenta (su precisa richiesta della mamma) una palestra di boxe, sport che non ama particolarmente e in cui non eccelle. Ce ne sarebbe abbastanza per mettere al tappeto anche il più forte dei temperamenti, ma non Bart. Lui (che deve il suo nome ai Simpson, serie amata dalla madre, troppo spesso spiaggiata sul divano) ha una pacata energia interiore che, unita a un coraggioso ottimismo, lo rende un piccolo eroe del quotidiano. La scala del caseggiato è indecorosa, sporca com’è e piena di siringhe e rifiuti? Lui affigge un cartello in cui propone una giornata di collaborazione condominiale per ripulirla. Gli stracciano il cartello? Lui non si arrende e lo appende di nuovo. Dei compagni di scuola bulli lo prendono in giro? Lui resiste e non cede.
Oltre alla sua forza interiore gli sono d’aiuto l’amicizia con Ada, una sua coetanea di ben diversa estrazione sociale ma in grado di capirlo (anche se non sa tenere i segreti), la presenza discreta della nonna e la grande passione per la musica lirica. Una passione che Bart ha sempre tenuto nascosta, ma che finalmente «tirerà fuori»: anzi, è proprio a quel letterale e simbolico «tirare fuori» la voce (voce narrativa dell’io narrante e voce cantante) che si dovrà la svolta del romanzo, con il riscatto del suo protagonista, che diventa grande. Una storia norvegese di crescita e di resistenza.