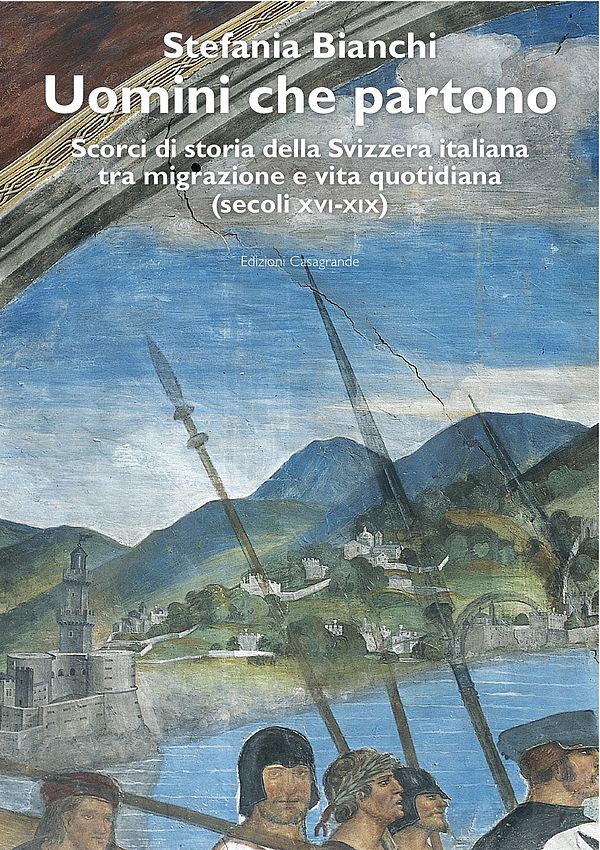Una mobilità da capogiro, molto lontana dall’idea un po’ statica che abbiamo del passato, una intraprendenza e una curiosità difficili da immaginare. L’hanno vissuta uomini e donne della Svizzera italiana tra il XVI e il XIX secolo, accomunati dall’esperienza dell’emigrazione. La storica e archivista Stefania Bianchi di Mendrisio ne prende in considerazione a decine nel suo appassionante saggio Uomini che partono. Scorci di storia della Svizzera italiana tra migrazione e vita quotidiana (secoli XVI-XIX) uscito per le Edizioni Casagrande, Bellinzona, di prossima ristampa. Piccoli numeri in rapporto alle proporzioni di quell’umanità che si mette in cammino, affrontando con coraggio «un’avventura faticosa e appagante». La complessità del fenomeno dell’emigrazione è nota, la densità di dati da interpretare pure, i personaggi numerosi, i rapporti di parentela intricati, ma non si corre il rischio di perdersi in quello che può sembrare, inizialmente, un insidioso labirinto: con abilità, brio e naturalezza, complice una prosa accattivante, l’autrice ci accompagna alla meta, facendoci capire i contesti ma anche l’intimità quotidiana di questo impressionante andirivieni di partenze, assenze, ritorni, alleanze familiari e di bottega.
I ticinesi sono sempre partiti e determinante ai fini della comprensione dell’insieme è il «peso delle assenze» evidenziato dal catalogo dei cittadini che rimangono nella Comunità di Lugano ordinato dal nuovo Governo della Svizzera italiana all’inizio del 1798, quando si conclude la tutela dei Sovrani elvetici. Nella minuziosa ricerca storica tutto si riconduce a fonti inoppugnabili, atti notarili, lettere, ed è sottoposto a verifiche, confronti, prove e controprove, per dare una risposta attendibile ai tanti interrogativi. Stefania Bianchi mette così in luce fatti, circostanze, motivi delle decisioni, strategie messe in atto nella patria d’adozione e nel paese natio dai migranti per mantenervi la propria identità, affermarsi e integrarsi, sia sul lavoro come nella vita quotidiana. Le tematiche trattate nel libro, attraverso una scelta di saggi recenti dell’autrice, concernono i percorsi dell’aristocrazia dell’emigrazione, quella dei mestieri d’arte, relativa in particolare al Sottoceneri.
Le storie raccontate appaiono in una luce nuova ogni volta che Stefania Bianchi, indagando approfonditamente, conferma indizi che si allontanano dai tracciati tradizionali della ricerca storiografica del passato, sovvertendo di fatto percezioni che sembravano consolidate fino a non pochi anni fa. Gli studi più recenti hanno infatti evidenziato i limiti del modello classico degli uomini che partono e poi rientrano in patria e delle donne immobili che attendono il loro ritorno a casa. Da questo punto di vista la lettura diventa ricca di esiti non scontati, a volte per noi sorprendenti. Un esempio tra i tanti, la figura di Anna Fontana (Muggio 1769-1846), svelata da un fondo di 250 lettere, che segue a Genova suo marito l’architetto ingegnere Gaetano Cantoni (Genova 1745 – Muggio 1827): una donna artefice del proprio destino, attiva nella vita privata e in quella pubblica che fa molto per integrarsi, e che comunque, alla fine della sua esistenza si ritira con i suoi ricordi nella casa di famiglia. Una storia singolare ma non eccezionale.
Quattro i temi principali trattati nel volume, Mete e professioni, Donne e migrazione, Identità e quotidianità, Contesti e destini, questi ultimi seguendo le tracce di Francesco Castelli di Bissone (Borromini) diventato famoso a Roma, degli Adamini di Bigogno d’Agra attivi in Russia, dei Guidini di Barbengo che troviamo a Novara, Venezia, Torino, Algeri e Milano, nonché dei Fontana, in particolare di Carlo, di Rancate che fa fortuna a Roma. Essendo l’istruzione «il sale del fenomeno migratorio», ne consegue l’importanza del ruolo della bottega, dove ogni aspetto è regolamentato: i Cantoni di Cabbio si distinguono per esempio come formatori a Genova tra Cinque e Seicento nella veste di architetti, a metà del Settecento come stuccatori e specialisti dell’ornato, e ancora nella prima metà dell’Ottocento per aver frequentato l’Accademia d’arte a Genova, come Gaetano Cantoni, che poi la dirigerà. Nuovi percorsi formativi, questi ultimi, sviluppatisi in seguito anche con la frequentazione dei Politecnici che porteranno a nuovi destini per chi parte a imparare l’arte. Nei decenni si acquisiscono successo e un alto grado di specializzazione. Al termine della carriera, ma non sempre è scontato, si rientra in patria, con una famiglia non di rado nuova, con accresciute competenze e capitali.
Sulla mobilità delle donne e i ruoli femminili resta ancora molto da indagare. Anche se non è loro preclusa la possibilità di scelta, la grande maggioranza rimane in patria e diventa il polo dei rapporti affettivi e non nei luoghi natii, gestisce le proprietà a casa con l’aiuto di personale che arriva dalle alte valli della Svizzera italiana e dall’Italia: un processo osmotico tra chi parte e chi arriva in Ticino che ha origini antiche e si struttura dal Cinquecento. Per queste donne non era rara l’esposizione al rischio di diventare oggetto delle malizie degli uomini come raccontano le storie di Anastasia Provino di Meride, a processo nel 1678, per aver avuto rapporti con diversi uomini, morta sola e in povertà, di Giovanna Bianchi di Stabio, nel 1795 alla sbarra perché incinta, vittima della seduzione dell’avvocato di casa che le nega la paternità, e di Cecilia Fontana Cantoni, cresciuta nella famiglia più ricca del paese, che la costringe a lasciare Cabbio nel 1695 per seguire il suo compagno, un umile carbonaio.
Bibliografia
Stefania Bianchi, Uomini che partono. Scorci di storia della Svizzera italiana tra migrazione e vita quotidiana (secoli XVI-XIX), Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2018, 207 pp.