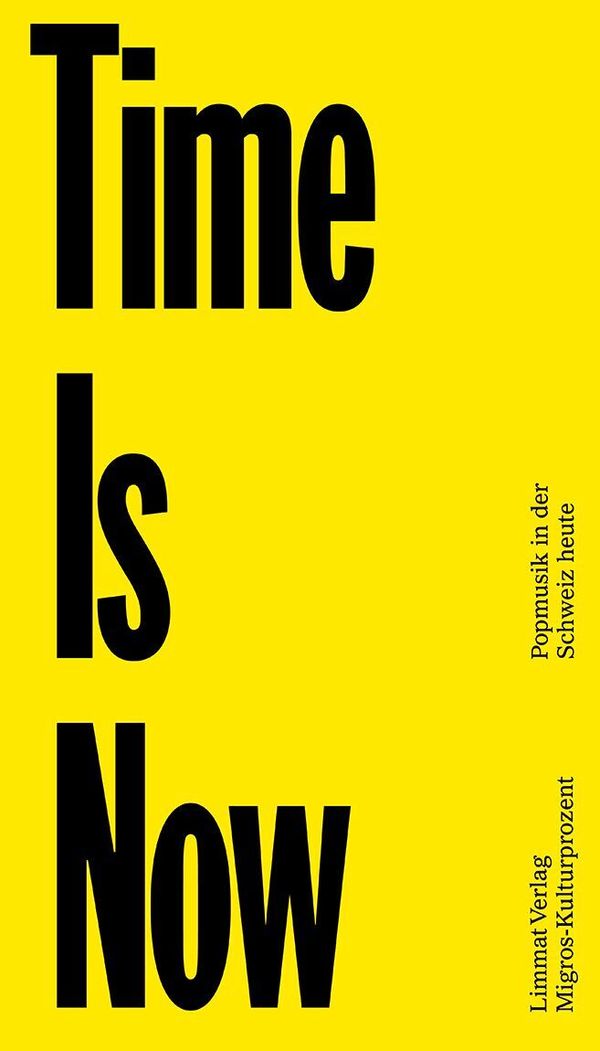La Migros è un passo avanti a tutti. Lanciato così – senza alcuna premessa, come piace ai comunicatori da barricata – lo slogan non può che apparire vacuo corporativismo. Se però lo si cala in un contesto preciso – come quello della ricezione culturale del fenomeno popular music – lo stesso slogan si fa portatore di una disarmante verità: nessuna istituzione svizzera è arrivata prima della Migros (e del suo visionario Percento culturale) ad affermare la dignità culturale dei generi che vanno dal pop al rock; e nessuna istituzione è stata capace come Migros di realizzarvi un puntuale programma di sostegno e affiancamento.
Quello che ai più può sembrare un’ovvietà – e cioè che De André, i Sex Pistols o Sophie Hunger abbiano fatto e ancora facciano cultura punto – per le istituzioni preposte è stato lungamente un tabù. E per molte lo è ancora, dal momento che al loro interno i generi musicali popular godono forse sì di una considerazione formale e di facciata, ma di certo non di un equo trattamento per quel che riguarda gli spazi, i budget produttivi e le misure sussidiarie.
Ma per fortuna qui e oggi non stiamo parlando di gravi inefficienze o colpe (anche se prima o poi qualcuno dovrà prendersi la briga di farlo) bensì di inconfutabili meriti e virtù.
«La musica pop è ormai arrivata nel pieno centro della nostra società: risuona dalla camera dei bimbi, riempie i luoghi dello svago e ha raggiunto persino le case per anziani. Ha pervaso gli stadi, gli ascensori, le auto, le cuffiette, i club, i salotti, i negozi, gli studi. La si ascolta in inglese, in dialetto oppure in Bum-tz-bum-tz. Se già non è in qualche posto, ce la portiamo pure con lo smartphone. E curiosamente – malgrado tutto – continuiamo ad amarla». Questa lucida disamina socio-logistica è opera di Philippe Schnyder von Wartensee – sì, proprio la persona che vent’anni fa creò per Migros il festival pop M4Music – e si trova ad aprire la recente pubblicazione Time Is Now – Popmusik in der Schweiz heute.
Data alle stampe da Limmat Verlag e Percento culturale Migros (ma disponibile anche all’indirizzo www.timeisnow.ch), si tratta di un’agile raccolta di saggi che presentano un ampio ventaglio di temi attorno alla musica pop svizzera: che cos’è stata, che cos’è, chi la fa, come la fa, dove la fa, quanta ce n’è, quanto costa e quanto guadagna. Tutto quello che avreste voluto sapere sul swiss-pop ma non avete mai osato chiedere.
«Il 20% della popolazione svizzera suona uno strumento musicale, mentre il 16% dichiara di cantare. La SUISA – Società svizzera degli autori di musica – è composta da 35’000 membri, mentre la cifra d’affari nazionale del mercato musicale è di 1,8 miliardi di franchi l’anno». Questi sono i numeri da cui partire, per provare magari a raccontare come le prove di un gruppo musicale siano ormai diventate attività di svago e socializzazione al pari delle partite a Jass. O per cercare di capire perché diversi creativi della nostra musica scelgono di spostarsi a Berlino. O per affermare che la vita musicale svizzera potrebbe solo giovare da una più profonda fiducia nei propri mezzi e nei propri valori.
Quello che alcuni musicisti sono riusciti a fare nella Svizzera romanda dove, rispetto a un bacino potenziale ristretto a neanche due milioni di persone, sono riusciti a costruire una solida scena locale e a esportarla con buoni risultati all’estero.
E la Svizzera italiana? Nel libro non è neanche citata. Forse per negligenza dei redattori – che pure hanno più volte riconosciuto all’M4Music il valore di realtà come On the Camper Records – ma ancor di più perché lo scatto mentale che in Romandia sono riusciti a fare, da noi non l’ha mai voluto tentare nessuno. Non di certo le istituzioni, ma nemmeno i musicisti. Come se avessimo paura ad affermare che il pop è cultura, che il pop rappresenta noi.