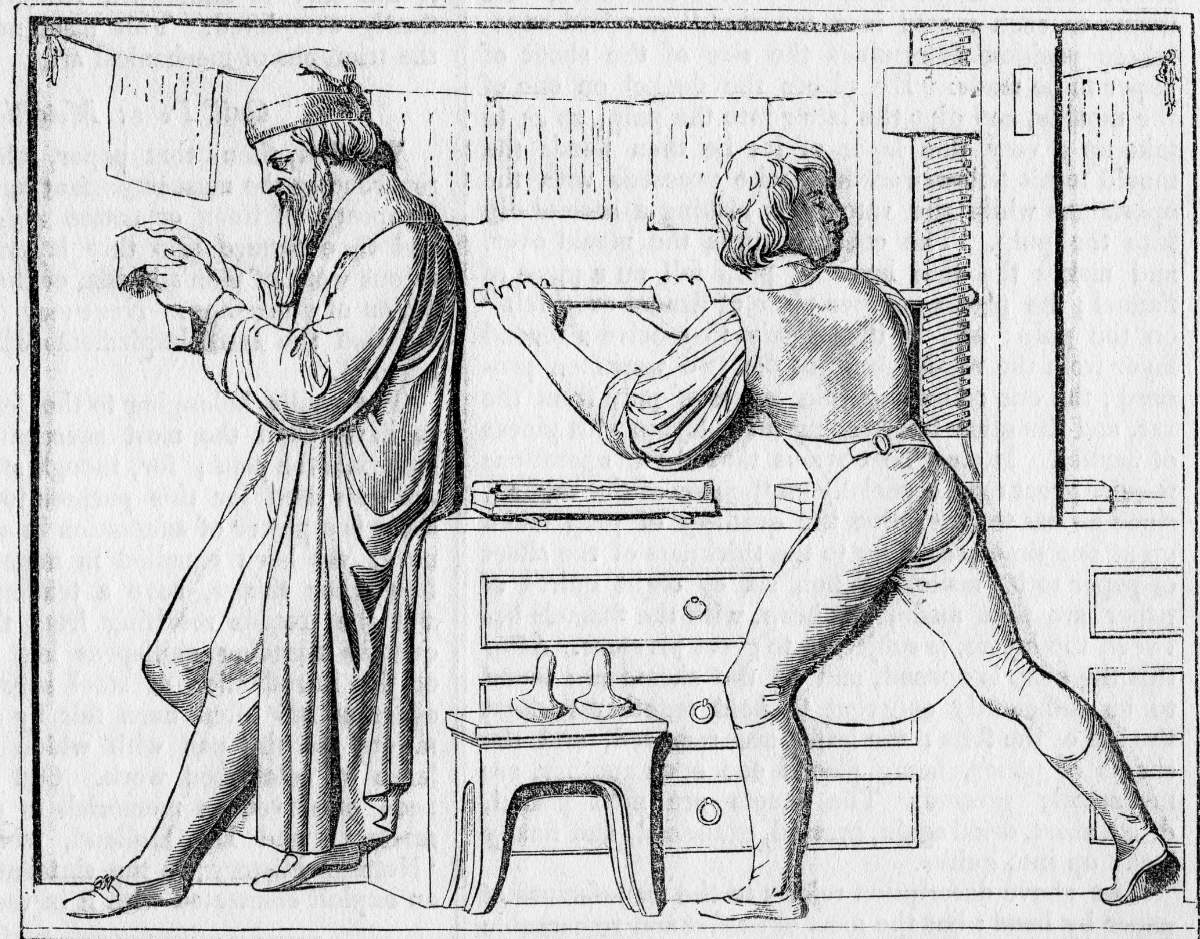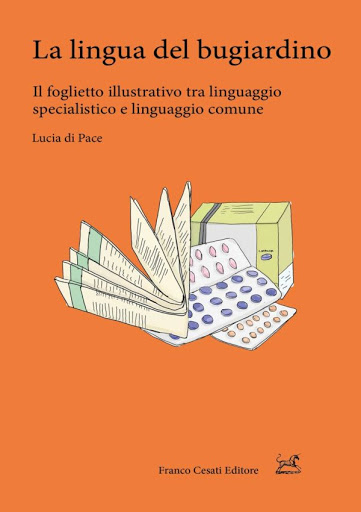La mia generazione ha vissuto sull’arco della seconda metà del Novecento un incredibile passaggio epocale. Quello dal «duro» (hard) al «morbido» (soft) o, se preferite, dall’analogico al digitale (o numerico che dir si voglia). Tutto ciò dopo che per circa mezzo millennio (caratteri mobili di Gutemberg, 1450 circa) nel campo delle «arti grafiche» nulla o quasi era mutato fino circa agli anni Cinquanta. Perciò mi sono detto che forse anche una testimonianza come la mia avrebbe potuto essere di un certo interesse storico.
In questa puntata cercherò dunque di iniziare a raccontare la grafica, anche perché quella che ho imparato e praticato io per più di mezzo secolo di vita (Orio Galli – 50 anni di graphic design, Poncioni, 2015), è ormai morta da circa un ventennio. O, perlomeno, è entrata in «catalessi» da quando l’uso sempre più diffuso del computer (completato poi dall’arrivo di internet) ha preso il sopravvento sulla manualità. Insomma, con quel digitale che ha ormai in gran parte cambiato non solo il modo di progettare e di realizzare qualsiasi cosa, ma addirittura di guardare e vedere la realtà che ci circonda. Sconvolgendo pure il modo di riflettere, sentire, amare, pensare… e con ciò modificando tutta la nostra vita.
Io mi limiterò al solo ambito della comunicazione. E, nel caso particolare, a quella di tipo plastico-visivo; e solo a quella statica (non cinetica) e bidimensionale, sebbene oggi stia sempre più prendendo piede la multimedialità.
Per cominciare qualche spiegazione sul significato di alcuni termini. Anche perché «grafica» e «grafico» possono voler dire cose diverse.
Per «grafica» può innanzi tutto intendersi l’opera grafica o, meglio ancora, calcografica, legata a un artista disegnatore, pittore o incisore. Trattasi normalmente d’immagini eseguite con tecniche e su supporti diversi (punta secca, acquatinta, acquaforte, xilografia, litografia, serigrafia…). Lavori riportati poi da una matrice in legno o metallo quasi sempre su carte speciali. Con riproduzioni tirate (stampate) a mano in non molti esemplari: solitamente da poche decine a un centinaio di copie, singolarmente numerate e firmate dall’artista. Opere soprattutto realizzate in bianco e nero. Più raramente in due o più passaggi/colori. Come si può ben capire ci troviamo di fronte a un tema vastissimo, da una storia millenaria. Riguardo a questo argomento è fondamentale il libro dello svizzero Felix Brunner: Manuel de la gravure, Arthur Niggli, 1962.
Per «industria grafica» si definisce invece tutta quell’attività che si occupa di stampati commerciali, dal biglietto da visita alle gigantografie, dall’etichetta al francobollo, dalla t-shirt al manifesto stradale, dal libro al giornale, dal depliant all’imballaggio. Immagini bidimensionali, e soprattutto realizzate su supporti cartacei. Anche se recentemente comincia a farsi strada la stampa tridimensionale, 3D.
Con la denominazione di «grafico» vengono pure definiti quegli schemi-diagrammi atti a rappresentare sotto varie forme (con sviluppi orizzontali, circolari, ortogonali…) rilevamenti di dati statistici di varia natura (economici, sociologici, linguistici…). Interessante come in questo campo vada da non molto affermandosi una nuova professione: quella dell’information designer. Si osservino al proposito le intriganti grandi tavole realizzate su diversi temi scientifici che appaiono settimanalmente nell’inserto La lettura del «Corriere della Sera».
Ma veniamo a ciò che maggiormente ci interessa. Con «grafica», e «grafico», ci si riferisce o, almeno, ci si riferiva fino a non molto tempo fa, anche all’attività legata alla progettazione di ogni forma visiva che normalmente viene poi realizzata dall’industria grafica in serie. Il grafico è comunque colui che si occupa principalmente della progettazione (schizzi, maquette…) e dei disegni definitivi (esecutivi) pronti per la riproduzione. Una professione questa chiamata oggi anche graphic designer (disegnatore grafico) per distinguerla da altri designer (di oggetti, abbigliamento, macchine, mobili…), così come da infografico o da web designer, professionisti che nacquero a fine Novecento quando il computer sostituì in gran parte il lavoro umano. Si tratta comunque di attività basate sulla progettazione di qualcosa che verrà successivamente prodotto con delle macchine in serie. Tutto l’opposto dell’artigiano che esegue ogni singolo pezzo, almeno in parte, a mano. (Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibiltà tecnica,1936).