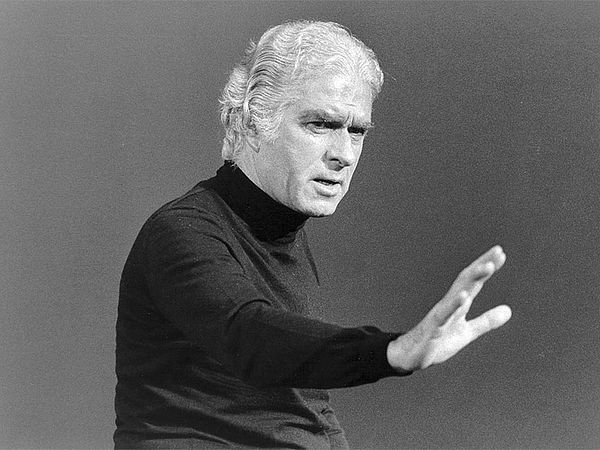Una mostra al Palazzo Reale di Milano (aperta fino al 24 marzo) porta un titolo ironico che non sarebbe dispiaciuto a Lina Wertmüller, Senza un pazzo come me, immodestamente un poeta dell’organizzazione. Frase (auto)descrittiva che cerca di riassumere una delle figure più importanti e singolari della vita teatrale italiana del secondo dopoguerra, Paolo Grassi (1919-1981), di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Fotografie, lettere, manifesti compaiono anche nel ricco catalogo pubblicato da Skira (272 pp., a cura di Fabio Francione), che ripercorre la vita-lavoro del vulcanico organizzatore culturale prima ancora dell’avventura principale, la fondazione del Piccolo Teatro di Milano, aperto nella storica prima sede di via Rovello, dove, durante gli anni della Repubblica Sociale Italiana c’era stato un luogo di tortura e sofferenza. Grassi muove i primi passi come regista e inizia subito l’attività di critico «drammatico», mentre la scrittura e i libri rimarranno sempre amatissimi passatempi: le due mai sopite e predominanti passioni convergeranno nel Piccolo, di cui fu co-fondatore e guida per venticinque anni, quasi tutti passati in coabitazione con il genio creativo di Giorgio Strehler, l’altro co-fondatore, non certo meno veemente e motivato del primo.
Una diarchia, quella Strehler/Grassi (1947-68), che in realtà fu un triumvirato, poiché mantenuto in equilibro dall’insostituibile azione diplomatica della guida amministrativa del Piccolo, Nina Vinchi. Triumvirato che ha fatto la storia del teatro italiano del dopoguerra, aprendo le scene italiane alla produzione europea negletta durante il ventennio fascista, un titolo e un nome su tutti, Bertolt Brecht e la sua Opera da tre soldi, passata con successo leggendario dal fascino sofferto di Milly a quello più dirompente di Milva; non dimenticando il più nobile teatro dialettale, come per El Nost Milan di Bertolazzi e il maggior drammaturgo italiano allora vivente, Eduardo (La Grande Magia); oppure rileggendo i classici, da Shakespeare alle commedie di Carlo Goldoni, i luminosi spaccati umani delle Baruffe chiozzotte e del Campiello; l’Arlecchino servitore di due padroni, diventato ammirato biglietto da visita della compagnia del Piccolo in tutto il mondo.
La convivenza fra il direttore Grassi e il regista stabile Strehler fu tanto fertile quanto difficile. «Caro Giorgio», scriveva Grassi a Strehler, «ricevo il tuo espresso. Drammatico come sempre. Inutilmente drammatico. Inutilmente suicida. Dal 1939 ricevo lettere tue tragiche e annuncianti catastrofi e sofferenze estreme, dal 1939 il nostro carteggio porta da parte tua sempre tristezze senza pari, disperazioni, esasperazioni, sfiducie, dissolvimenti, manie di persecuzione. Se non ti conoscessi da antica data e se non avessi sott’occhio centinaia di lettere sempre nere, sempre cariche di incubi, probabilmente mi spaventerei a quella di ieri. Non mi spavento perché gli incubi d’oggi sono quelli di ieri».
Poi nella vita di Grassi, dopo il doloroso distacco da Strehler e dal Piccolo, ci furono i successivi prestigiosi incarichi, primo la sovrintendenza del Teatro alla Scala (1972-77), che per anni era stato l’asso pigliatutto nelle sovvenzioni comunale e statali, rappresentando una sorta di «rivale» o di scomodo «compagno di viaggio» per quello che era diventato il più importante teatro stabile italiano. Grassi irrompeva nel mondo dell’opera proclamando la necessità di rendere la macchina organizzativa più produttiva ed efficiente, ma dovette passare anche lui tante forche caudine fra contestazioni e rivendicazioni sindacali. Lottò però sempre perché anche la Scala fosse conscia, non solo del prestigio passato, ma del suo ruolo attuale, organizzando un ufficio per la promozione culturale (retto per decenni dalla figura di Silvestro Severgnini), sicuro che il melodramma, come il teatro, andava conosciuto da tutti gli strati della società civile. Questo non volle dire che nella serata di Sant’Ambrogio entrasse il quarto stato: da autentico socialista credeva nella capacità della cultura di migliorare la vita dei «lavoratori» indossando alle prime un elegante smoking.
Dopo il quinquennio alla Scala ci fu la «promozione» alla presidenza della Rai (1977-80), affrontata con lo stesso piglio leonino. Lontano non solo geograficamente dall’organizzazione meneghina, il lottizzatissimo colosso radiotelevisivo di Stato si rivelò poco «governabile», nonostante le linee guida di Grassi e il suo senso della qualità si possano leggere nelle scelte coraggiose, come in alcuni kolossal realizzati in quella stagione, per esempio, il celebre Gesù di Nazareth affidato a Franco Zeffirelli.
A Roma come in precedenza a Milano, Paolo Grassi tenne sempre alta l’idea del teatro come luogo di incontro e fondamento della società civile.