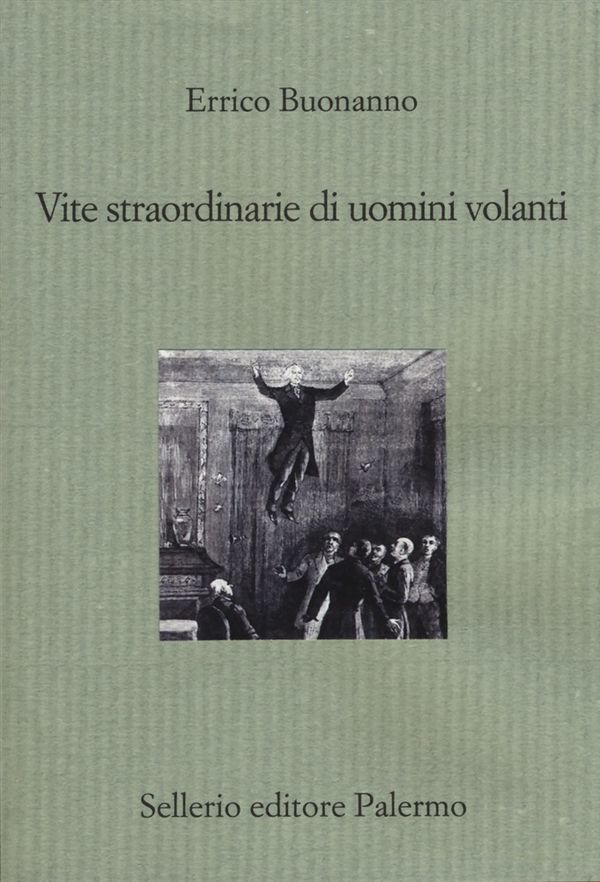«Forse s’avess’io l’ale / da volar su le nubi / e noverar le stelle ad una ad una, / o come il tuono errar di giogo in giogo, / più felice sarei, dolce mia greggia, / più felice sarei, candida luna». Così canta il leopardiano pastore errante dell’Asia. Desiderio e immagini di volo accompagnano da sempre gli esseri umani, che guardano con invidia il variegato popolo degli uccelli, capaci di staccarsi dal suolo e muoversi agevolmente nell’aria, osservando dall’alto il labirintico pianeta dove Anthropos apteros (Uomo senz’ali) – perplesso personaggio di una poesia di Auden – si aggira ponendosi domande per loro incomprensibili.
Nel libro Vite straordinarie di uomini volanti, Errico Buonanno ci parla inizialmente di personaggi, realmente esistiti o leggendari, che secoli or sono hanno tentato il volo con strumenti diversi. A cominciare dallo scienziato berbero Abbas ibn Firnas, che nel IX secolo si lanciò con una macchina di sua invenzione da una torre di Cordova, riportando ferite non gravi durante il brusco atterraggio. Finì invece tragicamente, nel 1002 o 1008, il tentativo di volo del lessicografo turco Ismail ibn Hammad al-Jawhari, che dopo essersi incollato delle penne di gallo sulle braccia cosparse di pece si lanciò dal minareto di una moschea di Nishapur. Meno grave fu la conclusione dell’esperimento «ufficiale» di Giovan Battista Danti – inventore di una macchina con cui eseguiva dei voli planati – che nel 1498, a Perugia, cadde sul tetto della chiesa di Santa Maria spezzandosi una gamba. Se le ruppe invece tutte e due il monaco benedettino e astronomo inglese Eilmer di Malmesbury, lanciandosi con delle ali artificiali – probabilmente nella prima decade del secolo XI – dalla torre dell’abbazia.
Ma sono gli «uomini volanti» gli eroi del libro di Buonanno: «gente capace di librarsi senza strumenti e senz’ali, senza un autentico perché», cioè senza volerlo e senza uno scopo da raggiungere. «Circa duecento, solo quelli attestati. Duecento, fra principi, villani, dottori di chiesa o miscredenti, che solcarono i cieli di un’Europa bambina». L’uomo volante di cui Buonanno ci racconta più diffusamente la storia è Giuseppe Maria Desa, nato a Copertino, vicino a Lecce, il 17 giugno 1603. Negli anni della fanciullezza, una grave malattia lo costrinse per lungo tempo a letto, impedendogli di ricevere un’istruzione. Rimase ritardato. I compaesani, malignamente, lo definivano «idioto», e vedendolo spesso «imbambolato, lo sguardo perso chissà dove», lo soprannominarono «Boccaperta». A diciassette anni, poiché desiderava farsi frate, fu accolto come confratello laico dai Cappuccini di Martina Franca, che trovandolo ben presto «inetto a qualsiasi mansione», e giudicandolo «stolido di mente», lo cacciarono dal convento. Dopo un anno trascorso girovagando in solitudine nella campagna, fu preso come sguattero dai Francescani del piccolo convento adiacente alla chiesa di Santa Maria della Grottella, dove con enorme fatica si preparò all’esame (che superò quasi per miracolo) necessario per prendere i voti ed entrare a far parte dell’Ordine dei frati minori conventuali.
Il 4 ottobre 1630, durante la celebrazione della festa di San Francesco, Giuseppe si alzò improvvisamente da terra e sorvolando i fedeli andò a posarsi sul bordo del pulpito. «Da quel momento, svolazzò di continuo. Duecento volte. Grossomodo. Volava seduto o ginocchioni. In verticale e orizzontale. […] Volava davvero, non levitava soltanto. Non gli bastava sollevarsi in aria – dai tre ai dieci metri – , ma compiva dei tratti», anche di trenta metri, portando a volte con sé la persona che gli stava accanto. Bastava una forte emozione, un’occasione di stupore, un’immagine (soprattutto quella della Madonna, a cui si rivolgeva dicendo «bella Maria!») a provocare il subitaneo decollo.
Com’era prevedibile, la fama dei suoi voli estatici (e dei miracoli che gli venivano attribuiti) richiamò l’attenzione del Sant’Uffizio. Sospettato di abuso della credulità popolare, dovette affrontare due processi. Assolto, venne però relegato in conventi sempre più isolati, l’ultimo dei quali a Osimo, non lontano da Ancona, dove morì il 18 settembre 1663. Beatificato da papa Benedetto XIV nel 1753, proclamato santo da papa Clemente XIII nel 1767, i cattolici lo venerano come protettore dei piloti e dei passeggeri di aerei, degli astronauti, degli studenti e degli esaminandi.
Dotati di una levitas spirituale che è l’opposto della gravitas di chi sta «coi piedi piantati per terra», gli eroi del libro di Buonanno (in mezzo a loro ci sono anche alcune donne: Teresa d’Avila, ad esempio) «erano in bilico, sospesi, sul baratro della modernità». Tre anni dopo la morte di Giuseppe da Copertino, Isaac Newton «vedeva cadere la sua mela. Il mondo, ad un tratto, si scopriva pesante. Scopriva la propria gravità. Iniziava l’età della Ragione, dell’empirismo, della materia, dei Lumi. […] Nessuno pensava che si potesse volare. Nasceva la scienza, e si estingueva una razza che il desiderio di volare aveva saputo soddisfarlo davvero».