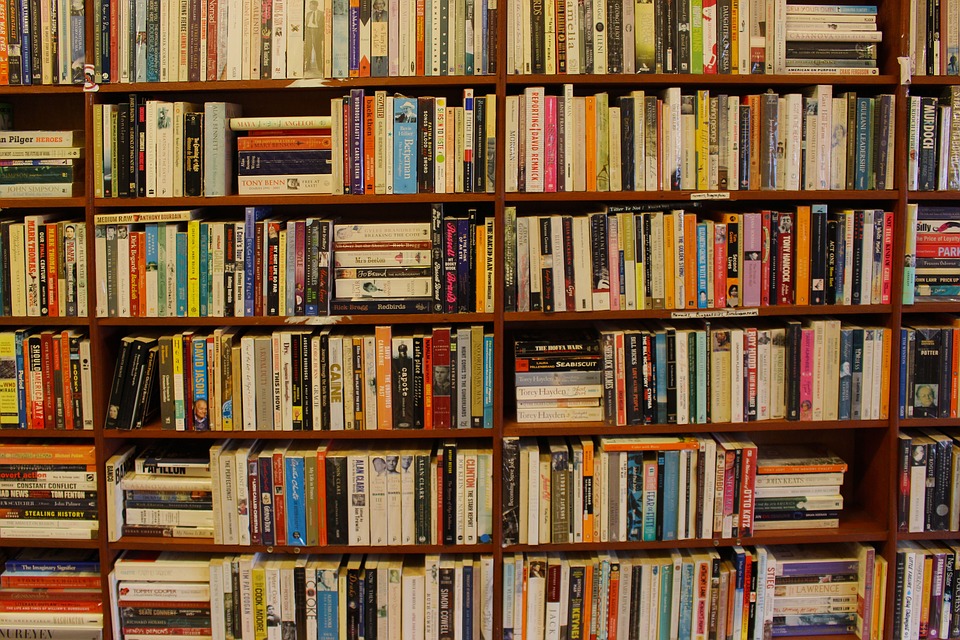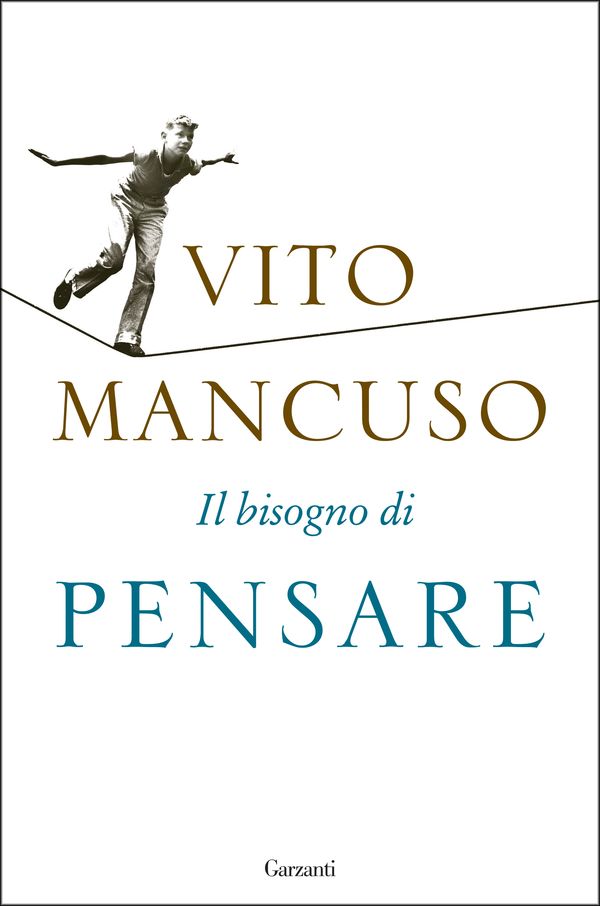Abbiamo questa convinzione: che la ragione, quando esercitata autonomamente, con distacco, porti al disincanto, al disamoramento rispetto alle ragioni della vita a favore di una visione dell’esistenza nichilistica quando non cinica. Se potessimo riassumere in un solo punto uno dei motivi per cui vale la pena leggere, quando non addirittura rileggere e meditare, le pagine che compongono l’ultimo e denso saggio del teologo e filosofo Vito Mancuso, Il bisogno di pensare (Garzanti) quel punto starebbe proprio nella capacità delle stesse pagine di persuaderci in direzione contraria a quella che ostinatamente seguiremmo rintracciando lo «Zeitgeist», che associa la bontà alla menzogna e la verità al cinismo.
Mancuso, che ha una valigia degli attrezzi particolarmente ricca e che sa spaziare dalla filosofia e dalla teologia alla storia della scienza (leggerlo è un piacere, si scoprono cose nuove e si mettono a fuoco concetti che già si conoscevano), ritiene che il mondo non si divida fra credenti e non credenti, bensì fra pensanti e non. Perché pensare, questa attività misteriosa, che – sottolinea il teologo – ci distinguerebbe dalle altre creature viventi specie quando volta all’autoriflessione, questa lunga contrattazione fra istanze opposte che ha luogo nelle nostre menti e che fonda la nostra identità (e quindi di riflesso anche la nostra idea del mondo e le nostre scelte), per essere esercitata con serietà e pienezza deve in primis liberarsi dalle secche del dogmatismo e dell’ideologia.
Pensando, e accogliendo nel flusso del pensiero anche le sensazioni e le percezioni che formano il primo stadio dell’attività riflessiva, ci si può accorgere che l’istinto di sopravvivenza, quel sì alla vita fiducioso e denso di gioia, può essere supportato dai dati della scienza. Il fatto, per esempio, che la probabilità che l’universo accada sia pari – come sottolinea lo scienziato Roger Penrose – a uno diviso dieci elevato alla potenza di dieci e poi alla potenza di 123, una cifra incommensurabilmente e inspiegabilmente piccola, può confortarci nell’idea che alla base della vita ci sia una tendenza all’organizzazione e che il caso sia un’ipotesi meno convincente di quanto ci aspetteremmo. Questo non significa che la vita sia solo costruzione ed evoluzione, che la teleologia – ovvero l’idea che ogni cosa sia determinata dal suo scopo – sia l’unica matrice dell’esistenza. Quella appena esposta sarebbe una visione ingenua, di parte, in lotta con le ragioni del raziocinio: ma accogliendo tutti gli elementi che compongono la nostra percezione del reale, ci si accorge che esistono elementi a suffragio dell’idea del bene, pur nell’entropia, pur nella tendenza della materia alla distruzione. Secondo Mancuso, il mondo è sorretto da qualcosa di invisibile e misterioso che tende alla realizzazione, allo sviluppo, al miglioramento. La sua fede, lo dichiara lui stesso, è quella di chi aderisce alla vita pur avendone saggiato i lati negativi.
Il libro, ricchissimo di spunti e di suggerimenti, si apre con un’esortazione al lettore quasi socratica: conosci te stesso, i tuoi desideri, le tue aspirazioni. Ma per farlo bisogna grattare la superficie, andare oltre, capire veramente qual è la vera voce, quella autentica, da seguire. Trattasi di un esercizio, di una pratica da continuare a mettere in atto, perché non esistono risultati definitivi. Pensare è pesante, come suggerisce l’etimologia stessa della parola, è faticoso, ma è di questa fatica che si compongono le migliori conquiste umane, anche quelle relative alla nostra interiorità. «Ognuno di noi è, e diventa, ciò che guarda, ciò che desidera, ciò che pensa». Mancuso chiude rivolgendosi ancora al lettore, suggerendogli una serie di pratiche che aiutano a plasmare artigianalmente la vita di tutti i giorni in modo che essa diventi la migliore possibile. Fra queste: leggere e studiare, sottolineare le cose più importanti, trascriverle, meditare, provare sensazioni, ridere, fare attenzione al proprio tono di voce. Un libro fuori dal tempo, questo, che entra nel nostro tempo forse perché ne abbiamo bisogno tutti, credenti e non.