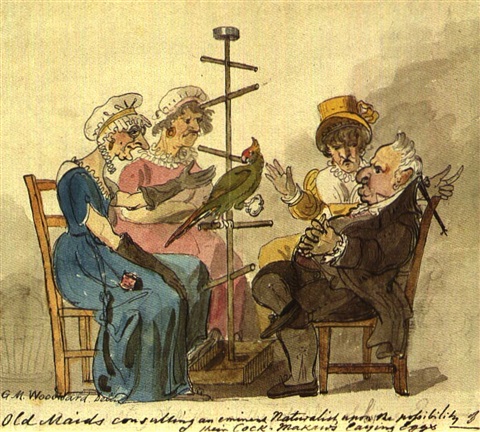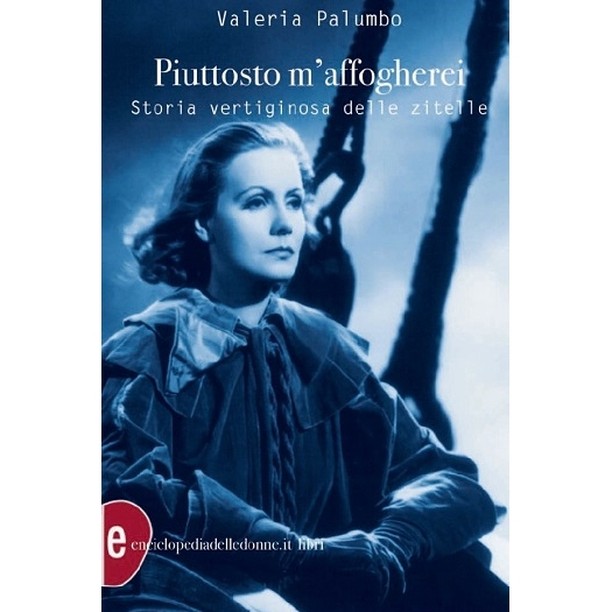«Rimaritarmi eh? Più tosto mi affogherei che sottopormi più ad uomo alcuno». Così risponde Leonora all’amica Adriana che la esorta a cercare un nuovo marito dopo la morte del primo, infatti «è peccato, che voi non vi rimaritate, essendo così giovene e così bella». Siamo nel Cinquecento, a Venezia, sette donne di diversa età si ritrovano a far conversazione tra loro. Parlano di musica, di letteratura, ma anche delle loro vite. Lontano dagli uomini, in santa pace, secondo l’idea ben chiarita da Lucrezia: «se noi vogliamo poi dire il vero, noi non stiamo mai bene se non sole e beata veramente quella donna che può vivere senza la compagnia de verun’uomo».
Questi dialoghi sono raccolti da una di loro, Moderata Fonte, pseudonimo di Modesta Pozzo de’ Zorzi, nel libro Il merito delle donne. Il matrimonio è visto come una gabbia che mortifica ogni velleità della donna, esser vedova o non sposata è un primo passo verso la libertà. Potremmo pensare che oggi, forse, qualcuno può percepire l’essere single come una conquista, dopo Sex and the City nessuno si azzarderebbe a negare che le donne da sole si divertono tantissimo e che i dolori vengono tutti dal rapporto coi maschi. Poi qui bisognerebbe chiedersi se le donne tra loro stanno bene proprio perché parlano degli uomini, li maledicono, si consolano a vicenda e poi rinfrancate tornano tra le loro braccia. Io perlomeno la penso così, come penso che certa goliardia da spogliatoio sia così appagante per uomini di tutte le età proprio perché vissuta come pausa rispetto alla presenza femminile.
Espresso questo illuminante e forse anche banale pensiero, vorrei porre l’attenzione su un altro aspetto in genere poco considerato, ossia il ritorno di figure di donne felici e non sposate in tutte le epoche della storia. Insomma il trionfo delle zitelle dalla mitologia omerica alle suffragette, dalle vestali alle ragazze di Manhattan. Valeria Palumbo, che alla storia delle donne ha dedicato numerosi e godibili libri, percorre per noi una «storia vertiginosa delle zitelle», intitolata proprio Piuttosto m’affogherei (enciclopediadelledonne.it, Milano 2018, pagg. 284, € 16,00), con l’espressione che abbiamo letto sopra appartenere alla giovane vedova veneziana. Ciò che emerge è un’idea di matrimonio come di compravendita: esclusi in pressoché tutte le epoche i matrimoni d’amore, il contratto prevede la cessione da parte della donna di ogni forma di libera disposizione di sé, e l’acquisto da parte dell’uomo del corpo, del tempo, della mente, dei sentimenti della donna. Ben strano contratto, dove è una sola delle due parti che s’arricchisce, mentre l’altra paga – magari con l’aggiunta della dote – e perde.
Gli uomini potrebbero insorgere: anche loro si legano, anche loro danno qualcosa in cambio con il loro corpo, protezione, sicurezza, mantenimento… discorsi troppo contemporanei, la storia che racconta Palumbo è impietosa. E sembra andare in due direzioni opposte, infatti da un lato l’avanzare della storia ha portato avanzamenti anche alla libertà delle donne, per esempio c’è forse una prima laureata nel Quattrocento, di sicuro una prima o seconda a fine Seicento e poi a poco a poco, a partire soprattutto dai primi decenni del Novecento, le università si riempiono di donne. E così in molti altri campi in cui anche le femmine si autodeterminano sempre più.
Però c’è anche un retrocedere, per esempio nel diffondersi della necessità di una dote per contrarre matrimonio, nella borghese e ipocrita ricerca di un partito «all’altezza» soprattutto economica, che ha creato il sottobosco delle zitelle intese in senso deteriore, le ragazze povere che si devono mantenere con lavori non certo dirigenziali e che si vestono di grigio, tutte ufficio e gestione dei parenti anziani. Potremmo continuare dicendo dell’esponenziale crescita degli assassinii di donne e della violenza sulle compagne, ma qui avremmo sempre il dubbio legato a ogni forma di delinquenza nella società globalizzata: sono tanti e fanno impressione perché sappiamo che avvengono, e lo sappiamo subito, con tutti i particolari più efferati, oppure perché effettivamente se ne compiono di più? Chi un secolo fa avrebbe saputo di ragazze segregate, mogli cadute – ma senza intenzione di cadere – dalla finestra, violenze nell’oscurità di camerette o corridoi scolastici? Espresso ancora un altro pensiero banale ma illuminante, abbandoniamo il sentiero dei dubbi e lasciamoci portare per mano da Valeria Palumbo in questa storia, a tratti divertente a tratti angosciante, delle zitelle. Che poi è sostantivo derivato da «zita», che ancora in molti dialetti significa fidanzata o ragazza da sposare, insomma donna non maritata, senza connotazione maligna.
Le prime che incontriamo sono ninfe, amazzoni, dee come Atena o Minerva. Donne potenti, gelose della loro verginità o comunque della gestione del loro corpo, però mitologiche, lontanissime dalla quotidianità della donna greca, indegna anche dell’amore di uno sposo che era più rispettato se si dedicava ai giovinetti piuttosto che alla moglie o alle donne in generale. A Roma, dove le leggi consentono qualche autonomia economica e dove una volta onorata la patria non erano molti gli onori di cui tener conto, troviamo le vestali, che si potevano sposare ma ormai tardi, dopo i trent’anni. Vestale era la madre di Romolo e Remo, violata da Marte e per questo condannata a morire murata viva. La punizione per lo stupro subìto ha radici lontane.
Il medioevo apre alle donne una nuova via di fuga, quel monastero dove si poteva persino imparare a leggere e scrivere, a dipingere, a essere indipendenti dai maschi sotto molti aspetti. Sappiamo di monache coltissime e potenti, tra tutte Ildegarda di Bingen. Prima che le monacazioni forzate fossero garanzia di stabilità economica per le famiglie nobili (cosa che accadde soprattutto dal Seicento), le forme di vita comune tra donne garantivano una certa autonomia: evitavano la prostituzione alle ragazze povere, insegnavano la musica o un mestiere, addirittura racconta Palumbo che quando la Riforma abolì i monasteri, le donne a poco a poco ricostruirono delle comunità religiose.
Ma lo scopo è ancora la fuga e la protezione, non è ancora tempo per donne libere e colte. Non lo sarà per tanti secoli: astronomi e matematici che hanno fatto proprie le scoperte di sorelle e colleghe sono vissuti anche nel secolo scorso (dobbiamo ricordare che Einstein arrivò alla relatività grazie ai calcoli della prima moglie?). Nobel rubati, pari grado considerate come segretarie, e ancora nel Duemila si dà del dottore al primo che passa, della signora (o signorina!) a parlamentari e professori femmine. E non sarà certo il cambio di una vocale, da sindaco a sindaca, a cambiare le cose. Ma è un inizio.