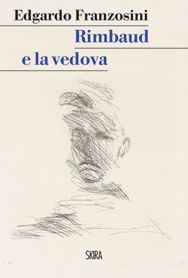«Forse in Vittorio Sereni operava la suggestione delle parole di Cocteau quando, dopo essersi domandato se Arthur avesse mai parlato a Lugano “con un ferroviere, o col cameriere di un ristorante”, se ci fosse mai stato qualcuno che potesse dire di avere scambiato qualche parola con lui, concludeva rassegnato che era “come voler dare un nome a un’impronta rimasta sulle pareti di una catacomba”».
Ecco – evviva! – Rimbaud e la vedova, ennesimo e benvenuto saggio-romanzo con la riconosciuta vicenda biografica di ispirazione letteraria di Edgardo Franzosini; spesso fatti non secondari ma nemmeno troppo di primo piano che riguardano scrittori o romanzi e attorno, a connettere il tutto, una serie quasi enciclopedica di spunti, piste di approfondimento, curiosità. Qui la storia è semplice; e riguarda uno dei due viaggi in Italia di Arthur Rimbaud, nella primavera del 1875, quando fu brevemente ospite di una signora, una vedova sembra, in un appartamento che dava direttamente su Piazza Duomo.
Non si sa molto di quella visita, né della misteriosa ospite; tanto che, sbrigata qualche documentata ma vana ricerca su materiale d’epoca, Franzosini rinuncia un po’ a definire i fatti nello specifico e promuove, accanto a molto gustose ipotesi, parecchi elementi di contorno di luminoso interesse. A partire dalla concretezza di quel viaggio, simile a quello che seguirà poi tre anni dopo, e che transita, superato il Passo del Gottardo, anche dal Canton Ticino, continuando poi «dal piacevole Lago di Lugano al piacevole Lago di Como». Dice: «ho dormito nel cuore del Canton Ticino, in un fienile solitario dove ruminava una vacca ossuta che ha acconsentito a cedermi un po’ di paglia».
Se è vero, poi, come dice Isabelle Rimbaud, che il viaggio in Italia sarebbe dovuto servire più che altro a imparare una lingua (conosceva Rimbaud l’inglese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo, ma anche lo svedese, l’olandese e il russo, e sapeva esprimersi, pare, anche in arabo e nelle due maggiori lingue dell’Etiopia), è fonte di divertito profitto sapere come egli imparasse le lingue, trascrivendo cioè liste infinite di parole, anche da sottocodici tecnici e scientifici. Secondo Paul Verlaine, gli bastò un mese per imparare a Milano la nostra lingua.
Sembra che da quel soggiorno Rimbaud non avesse spedito alcuna lettera alla madre; abitudine tanto marcata da brillare per la sua assenza e concentrare su quella «vedova molto civile» l’attenzione sospettosa e il gossip dell’entourage. Nulla sapremo, poi, di eventuali contatti con la società culturale e letteraria milanese del tempo. E potremo solo immaginare il giovane nostro muoversi nel tessuto ampio e generoso dei teatri, delle biblioteche e dei salotti, che pure abbondavano in quella città e che questo libro ci elenca con sistematicità. L’apparato è generoso: ci dice molto sul Rimbaud reale, al di là dell’immagine un po’ pastorizzata che la letteratura e le canzonette ci hanno consegnato di lui; e ci dice però anche delle canzonette, di Patti Smith e Allen Ginsberg.
È ormai un genere, insomma, quello avviato da Edgardo Franzosini con i suoi libri. C’è, a pagina 55 di questo memorabile Rimbaud e la vedova, un breve accenno ai destini delle esistenze e alla realtà e alle eventuali leggende che le biografie degli uomini (illustri o no) ci consegnano. Gli uomini lasciano ampie e mai uguali tracce nella memoria di altri uomini, tanto che è la memoria e non la loro vita ciò che essenzialmente conta. «C’è – lo dice Victor Hugo – uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. Ma c’è uno spettacolo più grande del cielo ed è il segreto della coscienza di un uomo».
«Bisognava aver conosciuto Rimbaud per comprendere il fascino che esercitava. Il suo era un fascino sia morale che fisico. Arthur possedeva tutte le seduzioni a un grado inaudito. La sua lingua di diamante era forte e vivificante come l’aria pure. Il suo cuore era senza tare né volgarità».