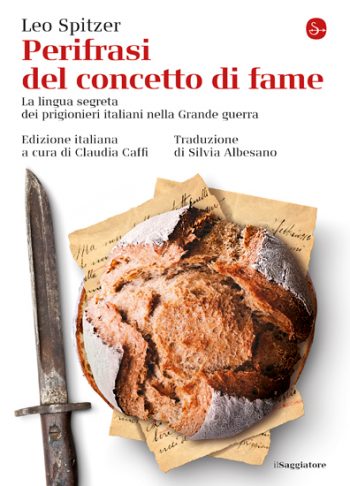«Sotto il nome “questione della lingua” si indicano tutte le discussioni e le polemiche svoltesi da Dante ai nostri tempi relative alla norma linguistica e ai temi connessi. La storia della lingua non può prescindere da questi dibattiti, per i loro rapporti con il divenire reale della forma linguistica».
L’italiano è stato «in questione» da subito, praticamente da quanto si è cominciato a dare un nome alla nostra lingua. Certo, le discussioni hanno assunto forme e modalità nei secoli anche profondamente diverse; e pure gli argomenti a proposito dei quali queste polemiche ebbero combustioni improvvise e virulente non furono sempre gli stessi. Se nel Medioevo una prospettiva di tipo quasi sociolinguistico vide a lungo gli autori agitarsi in merito a quanto terreno potesse guadagnare, nello scritto ma anche nelle situazioni comunicative, il volgare di fronte al latino, via via si affacciarono i dibattiti sulle figure letterarie da prendere a modello, sulla promozione delle varietà locali cittadine, sul valore nazionale della lingua dopo l’Unità. E se si vuole ancora, in prospettiva, la politica linguistica del Ventennio, l’amministrazione linguistica delle zone di frontiera, la gestione delle minoranze linguistiche storiche e delle geografie di contatto linguistico.
Insomma, dice bene Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, in questo suo Breve storia della questione della lingua quando dice che seppur non tracciata per intero da una questione della lingua, la storia della lingua italiana ne fu (forse addirittura virtuosamente) abitata in modo significativo. E ciò da una certa prospettiva non priva di qualche grado di stranezza, perché nel confronto con altre realtà nazionali, all’Italia è spesso rimproverata poca attenzione al proprio patrimonio linguistico: là dove Spagna, Gran Bretagna e Francia brillano per la tradizione delle loro accademie e dei loro istituti nazionali (per non parlare dei moderni certificati linguistici), l’Italia pare ai più piuttosto restia nel riconoscere alla propria lingua il valore di un patrimonio nazionale.
Il libro di Marazzini (che, va detto, riprende spunti e contenuti di sue opere precedenti, ma aumentandoli e aggiornandoli) ha un bel capitolo finale dedicato alle attuali «questioni» che animano il dibattito attuale; allo stesso Marazzini va dato atto di una certa sagacia nel leggere certi fenomeni in corso d’opera e nel prevederne il probabile significato storico. Oggi, la nostra lingua ha qualche match non secondario in corso, il quale, senza rappresentare un pericolo per la sopravvivenza concreta della nostra lingua, ne configura però qualche pericolo sul piano della considerazione sulla scena internazionale. I campi non sono secondari, e sono tra gli altri quello della ricerca o quello dell’importanza relativa negli organi istituzionali per esempio europei.
Rileva giustamente il presidente della Crusca le esemplari (anche nello stile testuale, vale la pena di andare a leggerle) sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale in merito al più clamoroso dei temi, quello dell’insegnamento esclusivo in inglese in taluni corsi di laurea. Questi fatti «travalicano ormai il confine dell’uso linguistico nella scuola e nell’università, e si trasformano in una scelta di campo nella politica linguistica, con effetti sociali e civili di vasta portata».
Il discorso è insomma ormai chiarissimo nei suoi termini principali: concedere insegnamenti universitari, pubblicazioni scientifiche e vocabolari specialistici al potere spesso anche solo di costume modaiolo dell’inglese potrebbe avere conseguenze sui repertori linguistici a disposizione della società per comunicare in ambiti primari per la comunità: le scienze, la medicina, l’ambiente. Non si tratta insomma di una questione di qualche parola usata a sproposito. Questa, per l’italiano, è una questione.