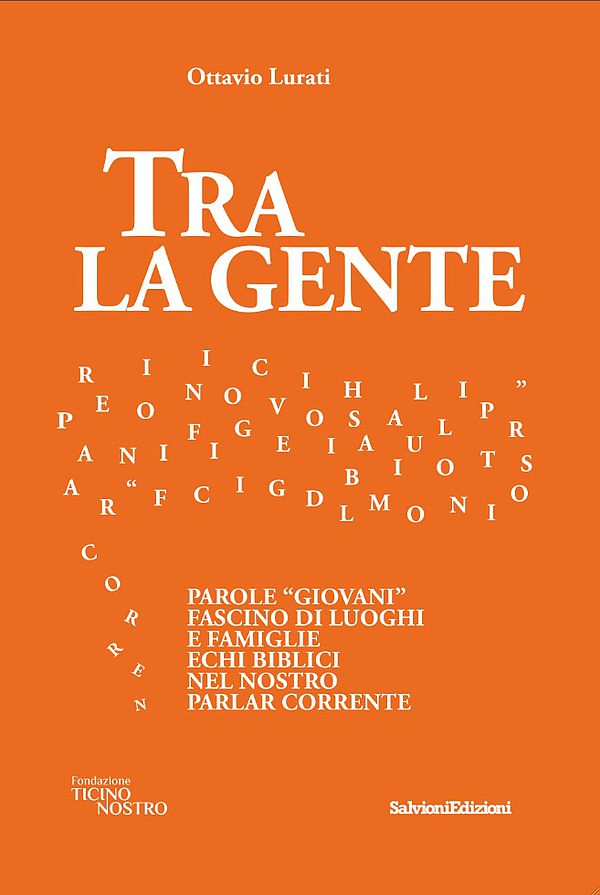Le esplorazioni linguistiche cui ci introduce Ottavio Lurati nel suo ultimo libro si arricchiscono di riflessioni e proposte nuove sull’origine di termini ed espressioni del nostro parlar corrente. Con spirito curioso, l’autore procede per sondaggi, distanziandosi dalla toponimia dei professori (l’antico studio dei nomi di luogo), per lasciare spazio alla toponimia vera, quella entrata nel dna della gente: l’orizzonte aperto sul vissuto della comunità affina la ricerca, lo studioso scarta vie intraprese e ne sceglie altre più convincenti.
L’importante è rendersi conto che non c’è mai la verità su un nome ma diverse interpretazioni derivanti da ricerche spesso costruite su indizi. Le piste da seguire sono sempre tante, non si stanca di annotare Ottavio Lurati, e vanno percorse per capire dove si insidiano eventuali errori, fantasie, ipotesi pittoresche, mode. Le verifiche del linguista affonderanno le radici nel passato e nel presente. Nell’evoluzione dei nomi si potranno così via via cogliere tracce di storia longobarda, germanica, latina, denominazioni e contaminazioni regionali, legami con il territorio, derivazioni gergali, il peso dell’ufficialità o della tradizione orale.
Per capire e scoprire, ci si deve guardare attorno. L’autore rivolge quest’invito soprattutto ai giovani. E pure ad alcuni modi dire del loro gergo Lurati rivolge la sua attenzione, per rivelarci ad esempio che l’espressione sei un povero gaggio cioè un pidocchioso, un buono a nulla, un impacciato, deriva da gaggia, l’italiano regionale che sta per pidocchio, termine legato al mondo contadino. Mentre fare il bullo è lo sviluppo fonetico del germanico bald, impavido, pronto all’azione.
Vi sono parole svizzere che hanno fatto fortuna in Italia. L’origine del termine mucca si lega a vicende connesse alla storia economica. Inizia a circolare nel Settecento tra mercanti svizzeri e acquirenti italiani alla Fiera di Lugano del bestiame, d’importanza europea; deriva dalla voce colloquiale svizzera tedesca Mugg, Muchi e da quella svittese Mucheli, Muggeli con cui il proprietario chiama affettuosamente la sua bestia. La parola indicherà per secoli la giovenca da latte svittese di importazione nell’Italia centrale.
Nel contesto della lingua parlata Lurati si interessa anche agli echi biblici di parole correnti. Due esempi significativi: cronaca e carattere. San Gerolamo (347-419 d.C) ricorre al termine cronaca nel tradurre dall’ebraico le due storie del «Libro degli avvenimenti del giorno» (III secolo a. C.). Carattere designa il segno del battesimo nel latino dei primi cristiani. Nel Medioevo la parola è usata in modo estensivo. Dal Trecento, in certi manoscritti, indica il segno che l’inchiostro lascia sulla carta. Soprattutto nel Cinquecento e nel Seicento comincia anche a essere applicata all’uomo e al suo modo di essere.
Non pochi i nomi di luogo ripresi, rifatti, reinterpretati. Serravalle e Giornico, indica l’autore, vanno insieme anche se l’involucro alfabetico e fonico diverso li allontana. In entrambi veniva resa giustizia. A Serravalle per secoli c’è lo stanziamento longobardo, la sala vallis. Diventata Sara vallis. Caso analogo Giornico che significa luogo dove i giudici rendono giustizia. In un’altra regione, a Tegna, fa stato la denominazione di luogo assegnata dalla comunità: il nome allude alle terre brulle rovinate dalle piene, da tigna, malattia della pelle che lascia chiazze prive di capelli; zona con scarsa vegetazione.
Indagando nell’universo dei cognomi, cui Ottavio Lurati dedica una parte importante del volume, si impara che non sempre c’è una spiegazione o certezza sull’origine. A volte, ci dice lo studioso, anche un indizio locale o un’indicazione dell’uomo comune possono essere utili per l’interpretazione. Botta, Bottini, Botticelli e Bottani hanno in comune l’origine longobarda (da bott, con cui dall’VIII secolo i longobardi indicano il rampollo che arricchisce una stirpe).
Non mancano, ancora, i riferimenti alle specificità naturali del territorio. L’origine dei Balmelli è Comologno: il nome deriva dal celtico balm, roccia sporgente. I cognomi Scerpella e Piezzi si collegano ai terreni scoscesi, quelli dei Franscini e dei Regazzi alle rocce dirupate (dal participio passato latino fracta). Dalla storia dei cognomi alla storia delle famiglie ticinesi in patria e all’estero il passo è breve. Lo studioso ascolta la gente, ci rende partecipi di queste esperienze arricchenti e il racconto si illumina.