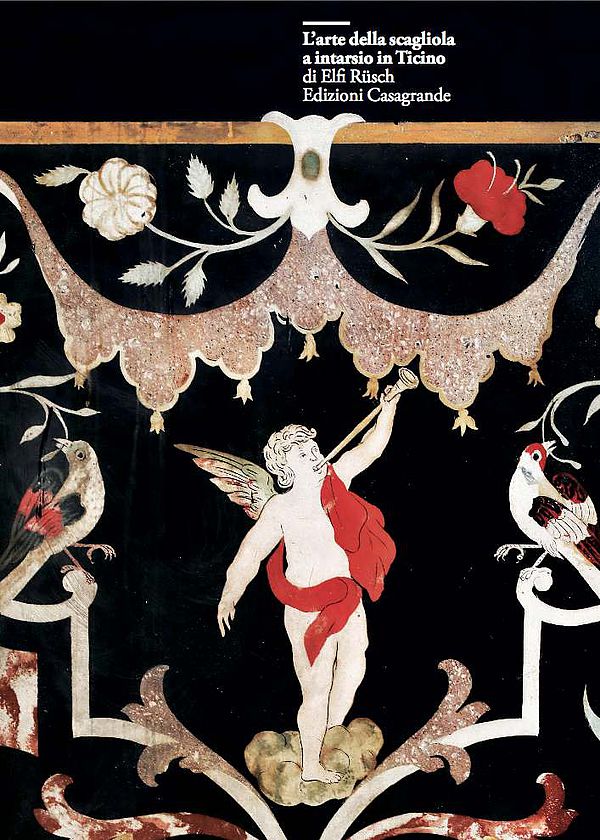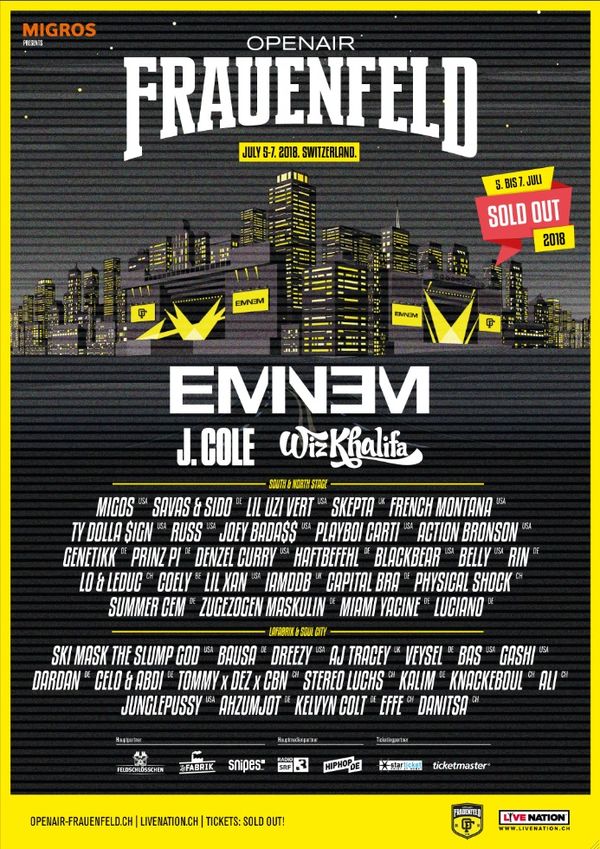Quello della natura è un tema sempre più attuale, anche se spesso ciò avviene non per scelta ma per necessità, ad esempio quando siamo a chiamati a tirare le somme di una catastrofe naturale in termini di vittime umane e di danno economico. La natura si guadagna giorno dopo giorno le copertine dei giornali e degli special televisivi, ma cosa accade all’interno della produzione letteraria globale? In quale modo l’impellenza ambientale entra nell’arte (che, per definizione, è anche portavoce del disagio, dell’urgenza) e più in particolare nella letteratura? A questo proposito l’indiano Amitav Ghosh (intervistato per «Azione» il 20.11.2017) ha scritto recentemente un libro-manifesto, in cui la denuncia dell’atteggiamento dei più è inequivocabile già nel titolo: La grande cecità. Gli Eventi letterari del Monte Verità quest’anno si occuperanno dell’Utopia della natura, affrontandola con approcci diversi. Niccolò Scaffai parlerà con Paolo Di Stefano del suo recente Letteratura ed ecologia, forme e temi di una relazione narrativa.
Niccolò Scaffai, nel suo libro analizza l’approccio all’ecologia da parte della letteratura. Come è strutturato questo lavoro?
Nel libro prendo in considerazione con un impianto comparatistico la presenza del tema ecologico nella letteratura, soprattutto in quella moderna e contemporanea. Esso si inserisce nel filone di studi dell’ecocritica, e offre almeno due nuovi tratti specifici. Il primo indaga come il tema sia organizzato all’interno della struttura dei testi, cioè come agisca con le forme narrative. L’altro aspetto è una ricostruzione storica di come il tema della natura si sia evoluto nella letteratura dall’antichità alla modernità, e in che modo il pensiero sulla natura sia diventato pensiero ecologico in senso maturo.
Oltre a un capitolo di discussione critico-teorica e uno di ricostruzione storica, il libro presenta due capitoli di approfondimento di due aree tematiche. La prima riguarda il tema dell’apocalisse, che naturalmente nella letteratura più recente si traduce in un’apocalisse anche ecologica, la seconda prende in considerazione il tema dei rifiuti e della spazzatura. Per quanto riguarda l’Italia pensiamo a Calvino, che a questo tema dedica uno dei racconti delle Città invisibili. Nella letteratura americana è un tema importante, come dimostra Underworld dello scrittore statunitense Don De Lillo, forse una delle «bibbie» della letteratura contemporanea americana, in cui il tema è di rilievo anche per la ricostruzione della storia americana del secolo scorso. L’ultimo capitolo del libro è una messa a fuoco sul caso italiano, su come sia stata portata avanti dagli scrittori italiani nell’arco del Novecento la riflessione attorno a natura, paesaggio ed ecologia. Mi soffermo su alcuni autori come il già citato Calvino, ma anche Pier Paolo Pasolini, Mario Rigoni Stern, Anna Maria Ortese e Paolo Volponi.
L’antropologo e scrittore indiano Amitav Ghosh lamenta come la letteratura si faccia troppo raramente portavoce dell’impellenza di un cambiamento di pensiero in ambito ecologico. Perché l’ecologia non rappresenta una forza ideologica?
La grande cecità di Gosh è un libro interessante che ho utilizzato anche per il mio lavoro. In particolar modo il romanzo è un genere che tradizionalmente tende a concentrarsi sulle vicende private individuali di un soggetto, mettendo in evidenza dei fatti relativi alla normalità del quotidiano borghese. Ghosh osserva come ci troviamo in un tempo in cui gli elementi di normalità del vivere quotidiano rischiano di essere condizionati e stravolti da eventi che superano la dimensione del singolo, poiché riguardano gli allarmi climatici di cui tutti noi sappiamo e leggiamo, e di cui, in parte, cominciamo a vivere le conseguenze anche qui in Europa.
È ora che la letteratura e il romanzo recepiscano questi cambiamenti e si concentrino su queste grandi svolte, e non più soltanto su elementi di ritmo normale della vita. L’invito di Ghosh è da accogliere anche da parte del critico letterario attraverso la riflessione e l’analisi dei libri che si occupano di questi temi. In alcuni casi gli allarmi sono raccontati con modalità indirette, che non rientrano nel solco del grande realismo del romanzo europeo, oggi infatti la letteratura può esprimere valori ecologici anche attraverso il genere fantastico.
Quali sono gli autori contemporanei particolarmente sensibili alle tematiche ambientali?
Tra gli autori importanti delle ultime generazioni possiamo citare Margaret Atwood che in alcuni saggi racconta la transazione climatica, spiegando come non si tratti solo di fantascienza, ma di un altro modo di narrare le urgenze del nostro presente. Ai già citati De Lillo e Ghosh si aggiunge il britannico Ian McEwan, sebbene in Solar si sia chinato sul tema in modo un po’ ambivalente, facendo ironia sugli eccessi ideologici di certo ecologismo. Un autore che mi preme citare come modello di nuova fantascienza basata su un’idea di ecologia è invece l’americano Jeff VanderMeer, di cui in italiano è stata tradotta la Trilogia dell’area x. Per quanto riguarda gli italiani contemporanei, sul versante apocalittico ci sono romanzi recenti come Le cose semplici di Luca Doninelli, o scrittori che ne parlano non come trasfigurazione distopica, vedi Violazione di Alessandra Sarchi, in cui si affronta il tema degli abusi edilizi che distruggono il paesaggio. Questo accade anche nella descrizione della Terra dei fuochi di Saviano.
I nomi che lei ha fatto però si contano sulle dita di una mano… riconosce un certo disinteresse da parte del mondo letterario?
Certo, ho questa sensazione. In quest’ambito la letteratura americana è forse la più sensibile. Purtroppo il tema ecologico è ancora vittima di un pregiudizio di naturalezza: si pensa troppo spesso che il tema della natura coincida con l’idillio, la rappresentazione del paesaggio ideale. Ma quando si parla di natura c’è anche l’altra faccia della medaglia, costituita da minacce, crisi e rischi. Purtroppo questo tema non è ancora universalmente accettato e diffuso, anche a causa di pregiudizi ideologici. L’interesse all’ecologia da alcuni viene ritenuto come un’evasione dall’ideologia in senso politico e sociale, ma in realtà non è così, perché i temi ecologici, la rappresentazione del rapporto tra l’io e le altre creature, tra il soggetto è l’altro, è anche una metafora politica.
Al Monte Verità di Ascona affronterà questo argomento?
In dialogo con Paolo Di Stefano torneremo su queste riflessioni, da un lato prendendo in considerazione il romanzo distopico, dall’altro analizzando l’utopia della natura vista come un idillio rispetto al quale l’ecologia deve agire. Spero che ciò possa aiutare ad accrescere la sensibilità… i riscontri ricevuti mi mostrano che qualcosa comincia a muoversi.
Lei indaga lungo altri filoni di ricerca?
Mi sono occupato di poesia moderna e contemporanea, concentrandomi in particolare su poeti italiani del 900 come Eugenio Montale, Vittorio Sereni e Giorgio Caproni. In anni recenti ho creato un polo di ricerca sull’italianità con la storica Nelly Valsangiacomo: cerchiamo di individuare gli stereotipi e i valori dell’italianità che si trovano nella letteratura o negli altri campi delle discipline sociali e umanistiche. Mi interessa anche il nesso tra letteratura e storia nel Novecento, in particolar modo Primo Levi, su cui da anni porto avanti delle ricerche.
Che tipo di ricerche?
Mi sono occupato dei suoi racconti fantastici o fantabiologici, cercando di dimostrare come non rappresentino soltanto una tendenza all’evasione rispetto al grande tema dell’opera di Primo Levi, ma siano un altro modo di rappresentare il tema della Shoah. Levi comprese presto come occorresse narrare in maniera non solo testimoniale ma anche fittiva, ricorrendo ad esempio perfino alla fantascienza per evitare il rischio dell’assuefazione al tema.
L’assuefazione è dunque uno dei rischi legati alla narrazione di un disagio che colpisce l’umanità?
Indubbiamente, e nel caso della Shoah questo è evidente. A partire dagli anni 90, con successi cinematografici (sebbene di indubbio valore) come Schindler’s List, il rischio dell’assuefazione o della stereotipizzazione diventa sempre più grande. Gli intellettuali dovrebbero riflettere su questo fatto.