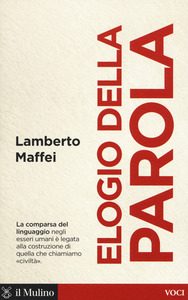«Le parole sono la mia memoria, la mia narrazione: io sono fatto di parole, magari silenziose; quel poco che so, sono parole, stringhe di eventi che ritornano nella loro sequenza non solo grammaticale e sintattica, ma nella logica razionale e irrazionale del ricordo, e mi rifanno il mondo e mi rinarrano».
La neurobiologia attenta al linguaggio vive certamente la sua stagione più florida. Grazie a strumentistiche scoperte qualche anno fa che permettono di letteralmente vedere il cervello mentre fa delle cose, produce frasi, genera pensieri, questa disciplina finisce per allargarsi un po’ e sondare in lungo e in largo la facoltà suprema che ci distingue dagli animali e fa di noi essere pensanti e sofferenti. Questo nuovo Elogio della parola, del neurobiologo normalista già presidente dell’Accademia dei Lincei Lamberto Maffei, ha il procedere affermativo e sicuro e pacificatorio di gran parte della saggistica scientifica divulgativa, o meglio di un genere di letteratura civile e democratica dove scienziati sensibili ai fatti culturali mettono a disposizione il loro sapere per raccontarci un po’ come va il mondo.
Il quadro si apre con la vicenda dell’affabulatrice Shahrazad, che salva se stessa e tutte le vergini sue sorelle esercitando il potere della parola e non lasciando requie al sultano, vincendo con le parole l’ingiustizia e la crudeltà del tiranno. E chiude il cerchio con la terapia contro il declino cognitivo che consiste nell’incoraggiare la produzione, anche esuberante, di parole e frasi: far parlare con brio e abbondanza per evitare la demenza senile, quasi che le parole fungessero da stimolante per il metabolismo e un vitalizzante afflusso di ossigeno al cervello. In mezzo, la vicenda della parola, quella biologica appunto, ma anche quella pedagogica, che va coltivata e sviluppata avendo cura di trasmetterla con rigore e dignità; la parola dei sapienti e quella sfatta e algida dei codici della globalizzazione e della nuova comunicazione digitale.
Questo genere di approccio scientifico sul linguaggio ha pure profondi sondaggi temporali di grande fascino; la scoperta di crani antichi, l’analisi di posture in tombe della notte dei tempi, fino all’osservazione di oggetti e strumenti reperiti accanto agli scheletri, concedono speculazioni di sicura seduzione. Siamo ai confini tra biologia, antropologia, medicina e molte altre discipline quando indaghiamo sul fatto che se la nascita della competenza sintattica si data presumibilmente attorno a 50’000 anni fa, la dotazione dei nostri apparati fonatori e nervosi che «preparano» la competenza linguistica sarebbe molto più antica, e ebbe luogo «in un punto imprecisato dell’Africa orientale, all’incirca dai 100’000 ai 50’000 anni fa».
Certo è che Maffei cede un po’ a qualche divagazione: l’immancabile ruolo dell’inglese, lo smartphone a scuola, il linguaggio dell’arte, la differenza tra vedere e guardare ecc. Ma questo genere saggistico è certamente impareggiabile quando, come spesso capita ai suoi autori, richiama per brevi cenni maestri e modelli: qui le parole così commoventi nella loro glaciale precisione di Lev Vygotskij, «il Mozart degli psicologi», e del suo capolavoro Pensiero e linguaggio: «Il pensiero dà significato alla parola che senza significato sarebbe un suono vuoto. Il pensiero potrebbe essere paragonato a una nuvola incombente che rovescia una pioggia di parole».
La competenza linguistica qualifica l’uomo rispetto all’animale e lo rende capace di civiltà, poesia, dolore e di tante altre zavorre culturali. Dell’autore di questo libro dice il grande linguista Luca Serianni nella presentazione: «l’ascoltatore o il lettore sono abituati a un suo stile inconfondibile: leggero senza essere mai corrivo e non di rado imprevedibilmente ironico». Ecco: è così.