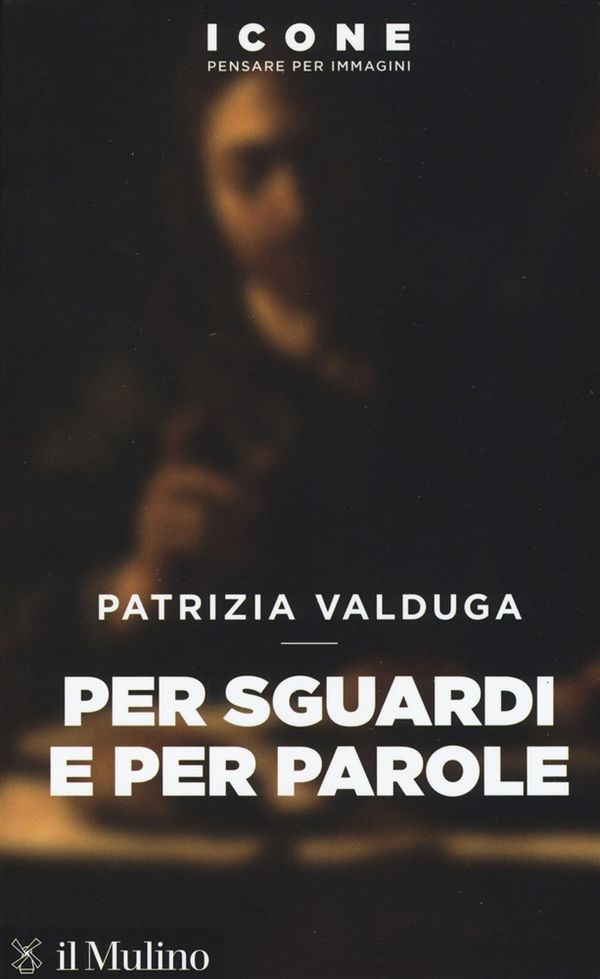«Le persone amate noi non le vediamo, di solito, se non dentro il sistema animato, il moto perpetuo della nostra incessante tenerezza, la quale, prima di lasciare che le immagini proiettate dai loro volti giungano sino a noi, le attrae nel proprio vortice, le fa ricadere su ciò che da sempre ne pensiamo, le fa aderire a questa idea, coincidere con essa. Ogni sguardo che nasce dall’abitudine è una negromanzia e ogni viso che amiamo è uno specchio del passato».
Diffidate delle raccolte di poesia senza un testo che le accompagni, un soffio di spiegazione del poeta o di qualcuno che lo conosce. E dunque non sbagliate, probabilmente, quando avete l’impressione o l’illusione che un poeta debba essere anche un critico; non osservatore della sola propria o altrui poesia, bensì indicatore delle cose della vita e del generico stare al mondo. Così è fortemente benvenuto questo libro non di poesie della poetessa Patrizia Valduga. Si chiama Per sguardi e per parole ed è sesto in una collana dell’editrice il Mulino curata da Massimo Cacciari, «Icone. Pensare per immagini», immagini che provocano pensieri e ragionamenti, per dirla alla grossa, affidati a filosofi, psicologi, scrittori.
Questo libro si apre (e si chiude) con la fotografia buia eppure così bella del Gesù a Emmaus di Caravaggio; del secondo, però, quello che sta alla Pinacoteca di Brera e porta la data di qualche anno posteriore rispetto al gemello che invece abita alla National Gallery di Londra, che è più colorato e dove Gesù è diverso, rubizzo, con tutta evidenza «bianco e rosso». Tutto, in questa meno recente rappresentazione concorre a renderla perdente se messa accanto alla versione milanese: la tavola disordinatamente apparecchiata, le vesti degli astanti, la loro disposizione e le loro posture. Eppure entrambi i quadri del Maestro ci trasmettono il mistero degli sguardi: dei personaggi di contorno, che guardano il Cristo anche se ancora, nell’attimo, non l’hanno riconosciuto, e di Gesù stesso, che non ha sguardo perché ha gli occhi chiusi e il volto rivolto verso il basso.
È da questo sguardo mancato eppure così potente che si incammina un saggio profondissimo e pieno di voci di ogni epoca sugli sguardi, sul loro potere, sugli aspetti della ragione e su quelli del sentimento, sullo sguardo dell’arte. Nel campionario di immagini coglieremo quella che più ci tocca, ci annichilisce, ci commuove. Qui le vertiginose descrizioni distribuite lungo tutto il testo a proposito degli occhi dell’autore, quelli letterali e concreti: «Proust aveva gli occhi neri, occhi neri che sembravano straripare e vedere anche ai lati, ed era sommamente intelligente, di un’intelligenza che splendeva nei suoi occhi stupendi». E così, per gli occhi di Buñuel («azzurri e sporgenti, il sinistro un po’ strabico, avevano un grande potere»); dello stesso Caravaggio («sappiamo bene come sono gli occhi di Caravaggio»); di Cartesio, che vediamo in coda al sedicesimo di carta patinata che sta al centro del libro.
Consumate le nemmeno centoventi pagine di questo Per sguardi e per parole, il lettore impreparato è vividamente sorpreso dall’illusione di averne letti a centinaia, tante e tanto varie sono le fonti chiamate a parlarci. È questo il mistero elevante della letteratura. Poi, ci procurano qualche brivido e molto conforto i versi che chiudono questo volumetto lasciandoci il desiderio di riaprirlo, ogni tanto. Sono i versi di un altro sistema di sguardi e non sguardi memorabile nella storia della cultura universale, il cenno d’amore pieno di grazia e luce di Beatrice alla fine del canto quarto del Paradiso, cui risponde l’immagine degli occhi bassi e imbarazzati del narratore Dante: «Beatrice mi guardò con li occhi pieni / di faville d’amor così divini, / che, vinta, mia virtute diè le reni, / e quasi mi perdei con li occhi chini».