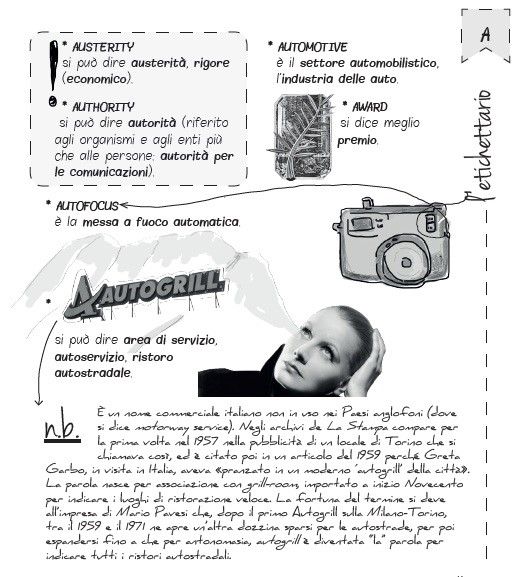«Siamo stati tutti innamorati. Quasi tutti, una volta o l’altra, siamo stati lasciati. E i più fortunati tra noi, a quel punto, dopo un’attesa breve o lunga hanno ritrovato l’amore. È una storia classica, universale, che non ci stanchiamo di ascoltare».
Precarietà e forza dei sentimenti sono, asciugato tutto il resto, i motori nucleari delle storie narrate nei libri. In questo senso, l’intervista alla scrittrice irlandese Catherine Dunne è esemplare della quarantina di medaglioni-chiacchierata dedicati ad altrettanti narratori, in questo Vivere per scrivere. 40 romanzieri si raccontano di Enrico Franceschini. Che sia spesso l’amore a mandare avanti una vicenda narrativa non è certo un mistero; lo sono per contro l’amore stesso e talune sue declinazioni: le età per volersi bene, il modo che hanno le donne di usare il linguaggio quando parlano con gli uomini, certa docile propensione all’eroismo che hanno le stesse donne quando amano.
Temi e parabole elementari da cui esplode, per l’incanto delle letterature, tutta la narrazione di ogni tempo e di ogni luogo e che, in un modo o nell’altro, anima il discorso di questi profili. Che hanno la forza della serie e della sua vertigine: quadretti che sono belli anche perché sono brevi e sono in successione nello stesso libro: finito un autore, l’energia passa a un altro, poi a quello successivo, fino alla fine.
Certa critica à la page prescrisse qualche decennio fa la necessità, per capire un’opera, di stare lontani dall’autore, che se era bravo poteva e doveva spostarsi sullo sfondo, silente e discreto, non interpellato sul senso della sua produzione letteraria. È vero che può capitare, molto più semplicemente, di incontrare un autore che parli di sé, di constatare un certo scarto rispetto ai libri che scrive e infine di esserne suo malgrado delusi. Per esempio, ma il gusto, sia concesso, è del tutto personale, la storia di J.K. Rowling può deludere, appiattita com’è su due fatti fondamentali: uno, che l’autrice si è arricchita con Harry Potter più della regina d’Inghilterra; due, che la sua sfida più grande sarebbe stata quella di scrivere un romanzo dopo aver concluso la saga del maghetto. Fin qui... più in là...
Poi uno sceglierà tra gli altri ritratti sue strade e sue vie. Il capitolo dedicato a Nick Hornby è interessante perché, lo sappiamo, l’illusione del lettore è spesso alimentata da una certa confusione tra l’autore e i suoi personaggi: Hornby potrebbe essere un suo personaggio anche quando parla di letteratura («i romanzi stendono al tappeto perfino il calcio») o quando ragiona sul rapporto tra libri tradizionali e libri elettronici o della lettura in generale. Qui conviene forse fermarsi un attimo perché le parole sono originali e rivelatrici in quest’epoca dove chi resiste non sa bene perché ma sa che deve resistere; dice Hornby che la voglia di leggere funziona circa come l’appetito e che nella selezione di generi e autori si fa più o meno come quando si ha voglia di pasta all’amatriciana piuttosto che polpettone della nonna o branzino al sale; che «leggere grossi libri è più difficile quando uno lavora»; che non è vero che la letteratura ci aiuta a vivere meglio; che non è peccato abbandonare la lettura di un libro che non ci piace anche dopo poche pagine; che «non c’è niente come la carta».
In questa rassegna si è fortunatissimi con alcuni autori e solo fortunati con altri. Si sa però che il libro che parla di libri è formula quasi sempre avvincente e così si arriva tutti interi a pagina 225, più o meno contenti, senza sbadigli e senza troppi disagi. Come nella buona letteratura.
«Mi pare che il libro di carta abbia numerosi vantaggi, hai una visione più netta dell’inizio e della fine, è maneggevole, non rischi di romperlo o scaricarne le batterie, puoi farci sopra tutti gli appunti e gli scarabocchi che vuoi, e poi per me è un bellissimo oggetto».