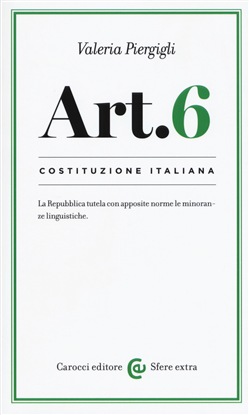«Un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato o comunque in posizione non dominante, i cui membri – essendo cittadini dello Stato – posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione, e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare le loro culture, tradizioni religiose, lingue».
Che la Costituzione italiana viva un momento di popolarità almeno come brand è sicuramente fuori di dubbio. Più che le operazioni, che pure si sono date in questi anni, di pubblicazione un po’ in tutti i modi del semplice suo testo, e anche più della serie di recite teatrali, non-stop televisive, letture di piazza e simili, più di tutto ciò insomma, è quindi sacrosanta e profittevole la serie che la collana delle «Sfere Carocci» dedica a un buon numero di suoi articoli, i primi. Come per esempio questo Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, curato dalla costituzionalista e docente di diritto pubblico Valeria Piergigli.
Il rinvio alla tutela delle minoranze linguistiche, oggi tanto di moda, è presenza piuttosto sporadica nei testi costituzionali internazionali fino alla metà del Novecento e l’articolo 6 può per certi aspetti essere considerato un’avanguardia. C’erano – è vero – il contesto storico e il milieu ideologico dell’immediato secondo dopoguerra, quando i confini a nord e a nord-est in particolare rappresentavano ancora emergenze fumanti da riordinare sul piano politico e legislativo, e le comunità tedesche dell’Alto Adige, slovena del confine a ridosso con la Iugoslavia e francese della Valle d’Aosta rappresentarono territori di autentiche rivendicazioni separatistiche. Tant’è: l’esercizio dei costituenti fu senza dubbio virtuoso e pose le basi per uno spirito di tutela ben generoso, tuttora in forte potenziale espansione.
Il testo della Piergigli è molto diffuso proprio sui travagli memorabili della Costituente e sugli Statuti regionali che, a loro volta, si trovarono a tutelare, a riordinare e a legiferare. Certo è, poi, che la Repubblica dovette attendere quasi cinquant’anni prima di disporre di un testo di applicazione del mandato costituzionale, una Legge nazionale del 1999 che anche i linguisti hanno studiato in lungo e in largo e che protegge e valorizza, oltre alle comunità linguistiche di quelle tre regioni originali, altre minoranze storiche: il sardo, il grecanico, le colonie albanesi del sud del Paese, il catalano di Alghero, il ladino, il friulano, le minoranze croate, franco-provenzali e occitane. La Legge enuncia all’articolo 1 l’italiano come lingua ufficiale della Repubblica; non l’aveva fatto la Costituzione, perché «il riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale dello Stato avrebbe potuto a suo tempo assumere un sapore nazionalistico, evocando regimi totalitari e repressivi nei confronti del pluralismo linguistico e culturale che il legislatore costituente ha voluto, invece, riconoscere e garantire».
In questo benvenuto volumetto viene data ai poveri linguisti anche qualche lezioncina sulla portata tutt’altro che circoscritta del mandato costituzionale; il quale apre alla tutela di comunità che alla Legge del 1999 era stato rimproverato (dai linguisti) di avere tralasciato: le lingue delle comunità rom e sinti, le lingue delle nuove immigrazioni, le stesse lingue tutelate a livello personale indipendentemente dall’insediamento di pertinenza storico. Quest’ultima nuance sembra secondaria, una semplice gradazione di colore legislativo: in effetti non è così, perché la normativa linguistica tende in questo modo a poter essere estesa ai parlanti una lingua tutelata anche fuori dal proprio territorio. Qualcuno, decenni fa, ci avrebbe potuto almeno pensare per l’italiano in Svizzera, anche quello nelle altre Svizzere. L’argomento è delicatissimo e infastidisce taluni: citus mutus, come si dice da noi, quindi.