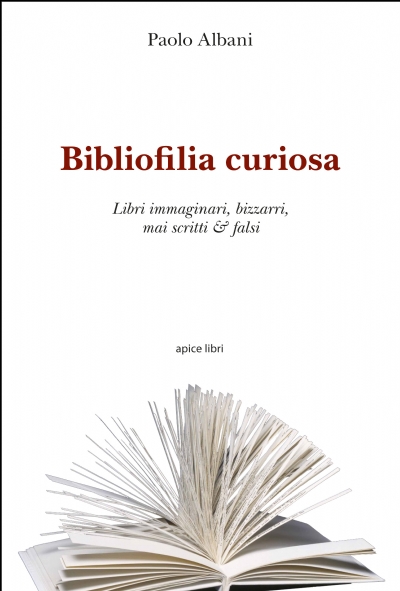«Perché non fare dei libri che si aprono come organetti macchine fotografiche ombrellini ventagli? Sarebbero oltremodo adatti per le parole in libertà. Io sono oltremodo entusiasta di quest’idea e tu mi dovresti accontentare perché anche tu sei arcistufo e nauseato delle forme bestiali dei libri comuni».
Dovendo definire Paolo Albani, si potrebbe dire che è uno studioso e divulgatore di libri; non uno che esercita nell’ambito della prosa, della narrativa e della lirica. Forse un saggista, ma un saggista particolare e non solo saggista; nel senso che i suoi saggi sembrano delle opere di narrativa, e, infine, narrano di quel particolare mondo che è il mondo dei libri. Nel risvolto di questo Bibliografia curiosa. Libri immaginari, bizzarri, mai scritti e falsi è descritto anche come «performer e poeta visivo»; e forse nelle performances in tema di libri, a vari livelli e secondo varie forme, può essere ricercato un possibile punto fermo delle sue varie attività. Si aggiungerà che Paolo Albani è anche curatore di repertori, di rassegne curiose e un po’ matte, nella cui vertigine entrano dizionari di lingue immaginarie e letterarie, un catalogo ragionato di libri introvabili, uno di scienze anomale, un’enciclopedia degli istituti anomali nel mondo, una rassegna di mattoidi italiani.
Anche qui, anche al centro di questa sua ultima opera, ci sono categorie di libri, o meglio di non-libri, di libri che, per vari motivi, non esistono, non sono mai esistiti o non esistono più; le categorie sono almeno sette: libri stampati e non pubblicati, libri inesistenti ma citati in bibliografie, libri cancellati dai cataloghi delle case editrici, libri annunciati ma non pubblicati, libri che risultano stampati ma che nessuno ha mai visto, libri inventati, «libri che l’autore non si rende conto di avere scritto».
Insieme ai libri annunciati o scomparsi, trovano spazio (la nozione di non-libro è declinabile in numerosi modi) i libri che stanno per scomparire, per esempio quelli condannati dalla bibliolitia, la distruzione di opere, e dalla bibliofagia, l’abitudine di mangiarle. In un testo del 1912, Nel mondo dei libri, Matteo Cuomo racconta di un editore tedesco che promette di produrre entro breve un giornale mangiabile, dove «invece della carta, egli userebbe una pasta nutritiva e gradevole che si presta assai all’impressione, e l’inchiostro sarebbe surrogato da uno sciroppo deliziosamente profumato».
Tra i non-libri, al confine della forma libro, quando un libro sta per finire di essere tale e tende a diventare qualcos’altro, ci sono i libri d’artista (dei quali tra l’altro Paolo Albani è conoscitore e produttore), qui chiamati «libro oggetto». Sono tante le definizioni di questa espressione artistica; una di queste fa riferimento ai sensi coinvolti: un libro oggetto è diverso dagli altri, perché oltre alla vista chiama molti altri sensi, il tatto, l’olfatto, il gusto, l’udito. Ma, viste da un’altra prospettiva, queste opere possono anche scegliere di prescindere dal testo: il libro con le pagine tutte di uno stesso colore e senza caratteri o le «invisibilissime pagine» del poeta maudit Ernesto Ragazzoni: «ognuno lavora come crede. Uno dei lavori più graditi, per me, dei più appassionanti, il lavoro dei lavori, è… non scrivere. Che gioia non annegare nel calamaio».
Il libro sui libri, l’iper-libro, seduce perché dichiara e tenta di descrivere il mistero antichissimo della lettura e ne percorre gli infiniti secoli, dove ha avuto i propri cantori tra gli autori più classici. È decisamente un genere, quello abitato da Paolo Albani in questo Bibliografia curiosa. Tenuto conto del fatto che Albani gode, con operazioni come queste, della buona compagnia di Borges, Rabelais, Cervantes, Calvino (Italo), Eco e molti altri nomi gloriosi, forse si potrebbe dire che, anzi, è questo di tutti i generi il più essenziale e supremo.