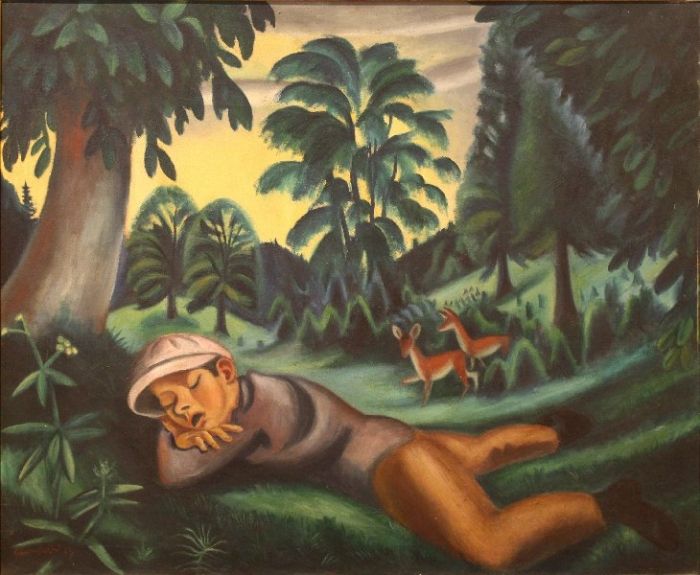Come l’uomo Friedrich Glauser sia diventato uno scrittore resta apparentemente un mistero. Le sue disavventure raccontano la storia di un picaro moderno incalzato dall’infelicità e proteso verso l’abisso che si scava con le proprie mani. Morfinomane tentò più volte il suicidio, conobbe il carcere e le cliniche psichiatriche, si arruolò per due anni, tra il 1921 e il 1923, nella Legione Straniera, esperienza da cui nacque il romanzo Gourrama, e fece lavori precari di ogni genere, compreso il minatore a Charleroi. Sullo sfondo si staglia la scrittura come forma di terapia: l’unico spazio di libertà, la distanza che gli permette di osservare con inesorabile franchezza la brutalità del mondo.
La perdita della madre a soli quattro anni segnò profondamente la sua turbolenta esistenza. Frequentò la scuola fino al ginnasio a Vienna, dov’era nato nel 1896, poi il padre svizzero, oppressivo e autoritario, lo spedì nel collegio rurale di Glarissegg sul lago di Costanza di cui egli tracciò un vivace ritratto che ora si può leggere nel volume edito dall’editore Casagrande nella bella versione di Gabriella de’ Grandi, Dada, Ascona e altri ricordi, che raccoglie resoconti autobiografici pubblicati su giornali e periodici svizzeri negli anni Trenta.
In realtà Glauser è noto per essere una specie di «Simenon svizzero» che utilizza il romanzo poliziesco, con al centro l’investigatore Studer, per uno studio d’ambiente proiettato nella profonda provincia in cui dominano miseria e paura. È un mondo stralunato dove si aggirano singolari e curiose figure di outsider, un po’ come qui, nelle sue pagine autobiografiche, dove la vicenda personale si innalza a tragica dimensione esistenziale, senza smarrire il gusto per la realtà. Non diversamente dal connazionale Robert Walser i cui personaggi – annotò lo scrittore Peter Bichsel – sono «sempre a un passo dal pianto e sempre a un passo dal riso».
Ma anche le figure che popolano i suoi ricordi si lasciano dietro una scia di curiosità e stravaganze: compagni disadattati come lui e docenti del collegio con una «piccola vena di pazzia», che vivevano in un «mondo apparente», in una specie di serra, dove per altro si recitavano Shakespeare e Grillparzer, e si leggeva un po’ di tutto, da Keller a Ibsen e Dostoevskij. Come già nelle prose del volume autobiografico Gli occhi di mia madre (Casagrande 2005) personaggi e atmosfere compongono piccole miniature d’epoca evocando la metafora di una vita come perenne segregazione, spazio da cui solo la mente permette di evadere. Allora era il personaggio del giovane Frédéric nel racconto Nel buio a conoscere fallimenti e disillusioni: da lavapiatti all’Hôtel Suisse di Parigi (dove sembra di essere tra le pagine kafkiane di America) a minatore, sempre in bilico fra il proprio riscatto e la sconfitta definitiva. Esperienze che hanno lasciato un segno profondo e riemergono anche in questo libro attraverso lo sguardo di chi ha conosciuto l’inferno e non è riuscito a scacciare la paura.
Ma poi lo scrittore prende il volo e la leggerezza avvolge miracolosamente le sue pagine: «Ci sono ricordi – egli dice – che sembrano bolle cangianti (…) non scoppiano per poi scomparire di nuovo nel nulla, ma abbagliano gli occhi chiusi». E allora il tono si fa tenue e ironico e mette al bando la disperazione. Come nei ritratti dei professori del collegio: Borstle, che insegnava storia e aveva la «bruttezza affascinante di un bulldog di razza» o Charly dal muso malinconico e il ciuffo alla Hitler. Per un attimo la vita pare sorridergli e gli spalanca le porte dell’avanguardia artistica. Conosce il pittore viennese Max Oppenheimer, detto Mopp, che gli parla dei fratelli Mann, di Wedekind e del suo amore per la Francia. Il giovane Friedrich diventa amico del rumeno Tzara, entra al Cabaret Voltaire, fa amicizia con Hugo Ball e Emmy Hennings mentre il pittore Hans Arp lo istruisce sui mistici medievali tedeschi. Intense e folgoranti sono le pagine che descrivono la nascita del dadaismo a Zurigo nell’ormai storica Spiegelgasse, in cui quasi inavvertitamente si trova coinvolto anche il ventenne Glauser: serate folli e piene d’entusiasmo con Ball al pianoforte che accompagna danze negre e lui, seduto lì accanto, che batte su un tamburello e prepara «insalate linguistiche» in tedesco e francese.
Poi ecco, la fuga in Ticino con la coppia Ball e le giornate passate in una cascina in Vallemaggia. Fughe senza fine che costellano la sua intera esistenza: ad Ascona, dove, scappato da una casa di cura, trova ad accoglierlo l’amico psichiatra Ludwig Binswanger e scopre gruppi e personaggi a dir poco originali: come gli Analitici che ogni mattina, tra caffè e pane imburrato, vagliano i sogni notturni alla ricerca di complessi, mentre sul Monte Verità sorge la roccaforte di Rudolf Steiner, l’antroposofo, e le sue discepole, le donne astrali, appassionate divulgatrici dell’euritmia. È un mondo magico in cui risplendono icone femminili, come la pittrice von Werefkin, che presenziò alla fondazione del Blauer Reiter a Monaco, e la sublime danzatrice Mary Wigman che appare sulla scena come una vera e propria visione.
Ma non basta quel mondo di immagini e di favolose promesse artistiche a ridare speranza alla vita: Glauser ha nostalgia della solitudine, proiettato verso il baratro e la propria distruzione. «Una parte di me aveva bisogno della sofferenza», ricorderà negli anni a venire, consapevole che proprio il dolore aveva affinato la sua conoscenza dell’animo umano proiettando nella scrittura un’intensità che non è mai disgiunta da un’incalzante euforia creativa. Così si leggono con rapimento anche le pagine sul suo soggiorno nella Legione straniera o le penose esperienze in miniera. Lo scrittore sembra non rinunciare a cogliere un briciolo di speranza anche nei momenti più bui, affidandosi alla letteratura. Ma la vita lo tradì sempre e comunque, fino al giorno della sua morte sulla Riviera ligure. Era la vigilia del matrimonio e forse l’inizio di un vero futuro.
Bibliografia
Friedrich Glauser, Dada, Ascona e altri ricordi, traduzione di Gabriella de’ Grandi, postfazione di Christa Baumberger, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2018, p. 133, € 18.–.