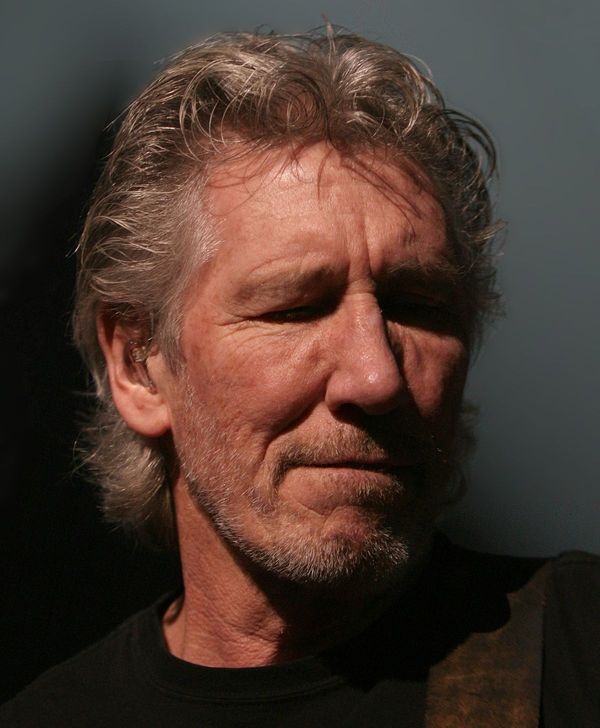Sebbene Jheronimus Bosch (1453-1516) sia un artista che ha avuto grande ascendente sulle generazioni di pittori che gli fecero seguito e i suoi dipinti, intessuti di suggestioni oniriche, abbiano saputo impressionare il pubblico in ogni epoca, le sue opere riconosciute all’unanimità come autografe sono soltanto venticinque. Esse ebbero grande circolazione attraverso l’Europa, sin dalla fine del XV secolo. Per chi desidera ammirare la produzione del pittore olandese, otto di esse si trovano in Spagna – qui egli era noto come «El Bosco» – dove, prima, Filippo il Bello e, in seguito, Filippo II ne furono entusiasti collezionisti. Mentre il secondo nucleo maggiore è nei musei di Venezia, dove un’ulteriore occasione di scoperta è offerta in questi giorni e fino al 4 giugno dalla mostra Jheronimus Bosch e Venezia.
Qui sono tre le opere – due trittici e una serie di quattro dipinti su tavola – che danno lo spunto per una mostra «narrativa», cioè improntata a ricostruire le vicende che determinarono l’arrivo e la fortuna di questi capolavori nella città lagunare. A Bernard Aikema, storico dell’arte e curatore dell’esposizione, abbiamo chiesto chi fu il personaggio che volle a Venezia le opere di Bosch: «Sappiamo da Marcantonio Michiel, forse il primo critico d’arte italiano, che nel 1521 il cardinale veneziano Domenico Grimani aveva nella sua collezione tre opere di Jheronimus Bosch, raffiguranti “sogni, incendi e mostriciattoli”. Figura poliedrica, Grimani era un raffinato collezionista e un umanista, con un dottorato ottenuto all’Università di Padova. Aveva un interesse diffuso che spaziava dal classicismo monumentale di Tiziano e Raffaello, fino all’esatto contrario, cioè all’anticlassicismo di Bosch. Alla sua morte nel 1523 egli lasciò tutte le sue raccolte alla Serenissima Repubblica Veneziana, compresi i dipinti di Bosch che rimasero dimenticati e nascosti in casse nei depositi di Palazzo Ducale fino alla metà del Seicento. Egli era anche appassionato di cultura ebraica: possedeva, per esempio, la biblioteca già appartenuta a Pico della Mirandola, una delle più importanti raccolte costituite nel secondo Quattrocento per quanto riguarda la scienza talmudica e la Cabala».
Qui compare il secondo personaggio chiave della vicenda: «Sì, il fiammingo Daniel van Bomberghen: egli fu fra i primissimi – se non il primo – editore di libri ebraici a Venezia ed era anche un mercante a livello internazionale di dipinti. I documenti che abbiamo reperito ci dicono che fu lui a mandare un suo associé nella bottega di Bosch, dopo la sua morte. Qui furono trovate alcune opere invendute che il socio di Bomberghen si premurò di “aggiustare” secondo il gusto del collezionista veneziano: furono occultati elementi troppo fiamminghi, aggiungendo invece figure caricaturali “alla Bosch”.
Le opere venivano così adattate al gusto del cardinal Grimani, che avrebbe acquisito queste tre opere, destinate così ad arrivare a Venezia. Bosch operava come un pittore religioso. La sua cultura e quella dei suoi committenti era in gran parte basata sulle aspettative spirituali dell’epoca, determinate fortemente dalla dialettica fra bene e male così come era stata delineata da Sant’Agostino. Ma ciò che interessava Grimani non erano tanto questi concetti, che pure egli senza dubbio conosceva, quanto piuttosto le modalità inedite trovate da Bosch per esprimerli».
Le opere veneziane di Bosch vengono oggi presentate al pubblico nella loro versione originale, così come l’artista olandese le concepì, a seguito del restauro avvenuto nell’ambito del Bosch Research and Conservation Project, un programma che a partire dal 2010 ha riunito studiosi e restauratori internazionali (portando anche alla compilazione del nuovo catalogo ragionato dell’autore) ed è ripercorso dal documentario Jheronimus Bosch – Unto dal diavolo del 2015.
Sempre Aikema spiega quale fu la fortuna di Bosch a Venezia: «Qui le opere di Bosch per cento anni non ebbero alcuna diffusione, essendo rimaste nei depositi di Palazzo Ducale. Esse non esercitarono quindi nessuna influenza sull’andamento dell’arte veneta e nord italiana. Fu invece un interesse per la figura di Bosch in quanto creatore di visioni oniriche e di scene infernali a farsi strada a metà Cinquecento grazie alla diffusione di stampe che presentavano motivi “alla Bosch”. Presentate in mostra, queste furono realizzate dai grandi autori del Cinquecento fiammingo, come Pieter Bruegel il Vecchio, che importarono queste stampe in Italia in grandissime quantità. Si tratta di un fatto poco noto, ma molto significativo. La figura di un artista non è infatti sempre da identificare con quello che ha realmente prodotto, ma spesso anche con quello che ne ricavano le generazioni successive».
Bosch fu poi oggetto di un ulteriore revival veneziano, con cui la mostra si conclude: «Fra 1660 e 1670, per quanto possa apparire strano, nel secolo cioè del Barocco più teatrale e monumentale, lontano dal mondo convulso di Bosch, un pittore tedesco è autore di una nuova stagione fortunata dell’opera di Bosch a Venezia, basata proprio sulla riscoperta della collezione Grimani. Questo pittore, di nome Joseph Heintz, si rifà a questi esempi che ormai non rispondono più al gusto raffinato umanistico del Cinquecento, ma invece incontrano l’interesse seicentesco per lo spettacolo della meraviglia e dello stupore».