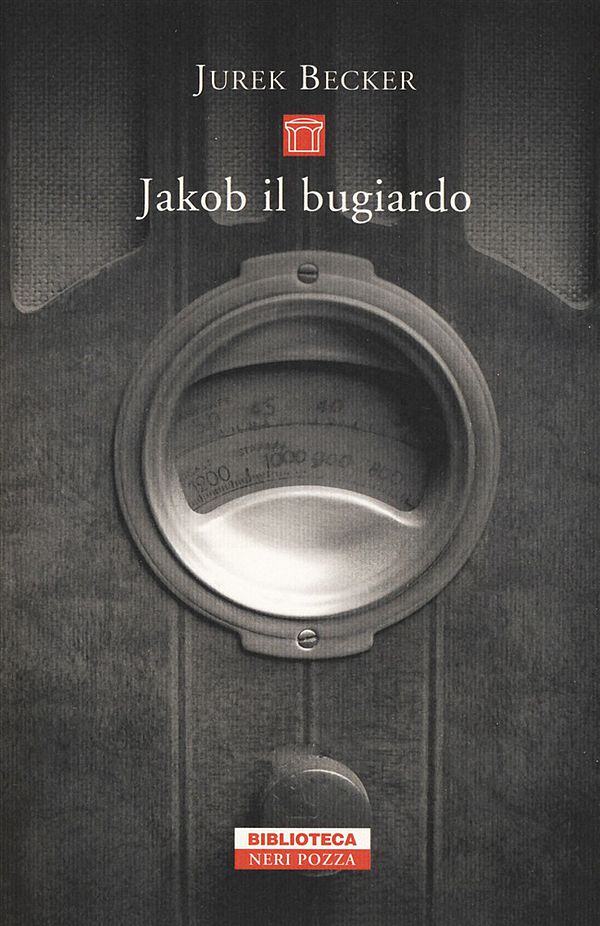Un buco nero inghiottì l’infanzia dello scrittore ebreo polacco Jurek Becker. Passò i primi anni di vita con i genitori nel ghetto di Lodz dov’era nato nel 1937. Poi fu deportato con la madre Anette nei lager di Ravenbruck e Sachsenhausen, mentre il padre finì ad Auschwitz. Un trauma spaventoso che il piccolo Jerzy confinò nell’oblio: l’amnesia totale fu la sua solida difesa di fronte all’orrore. Ci pensò il protagonista del suo primo fortunatissimo romanzo del 1969, Jakob il bugiardo, di cui esistono due versioni cinematografiche, a riattivare la memoria non senza una vena di umorismo intriso di disperazione. In Italia uscì nel 1976 presso gli Editori Riuniti nella bella versione di Mario Devena ora riproposta da Neri Pozza, che nulla ha perso del suo smalto e della sua efficacia.
È la storia di un abitante del ghetto, obbligato a lavorare per i tedeschi, che finge di avere una radio e inventa notizie incoraggianti per i propri compagni. Immagina che i russi stiano arrivando a liberarli, così come era successo realmente a Jerzy e a sua madre nell’aprile del 1945. Anette morì di lì a poco e il ragazzo fu rintracciato dal padre Max riemerso dall’inferno della Shoah. Decise poi di trasferirsi nella Germania orientale, cambiò nome a sé e a suo figlio che solo allora iniziò a imparare il tedesco, la lingua degli aguzzini. Gli servì in qualche modo per non sentirsi diverso in quella nuova, difficile realtà, non certo per riesumare un passato sprofondato nel buio.
«Non avere ricordi d’infanzia – annoterà ancora nel 1990 – è come essere condannati a trascinarsi sempre dietro una cassa della quale non conosci il contenuto». Una rimozione che nessuna scrittura avrebbe mai cancellato e tuttavia Becker, scomparso prematuramente nel 1997, attorno a quel terribile vuoto costruì tutta la sua carriera di scrittore e sceneggiatore per dare un senso e un’identità almeno al proprio futuro.
Non a caso nel romanzo Il pugile del 1976 il difficile rapporto fra un padre e un figlio rievoca drammaticamente i fantasmi dell’Olocausto in cui perirono la madre e altri due ragazzi. Dieci anni dopo Jurek diede alle stampe I figli di Bronstein, ambientato all’est ma scritto nella Repubblica federale tedesca dove si era trasferito. Un libro in cui si affacciano le nuove generazioni spesso insofferenti di fronte al pesante silenzio di quei padri perseguitati dal nazismo, che nascondeva traumi irrisolti. Come suo padre Max, assai reticente di fronte ai ricordi del lager.
Il presente non riesce dunque a sottrarsi alla violenza di un tempo che allunga la propria ombra riesumando paradossalmente le vittime nel ruolo di persecutori. Il giovane protagonista Hans scoprirà infatti che il genitore ha segregato con alcuni amici in una piccola dacia un ex carceriere di lager sottoponendolo a pesanti interrogatori e malmenandolo. Così il passato entra nella vita del giovane in modo traumatico e lui stesso finirà per isolarsi e tacere a sé e agli altri il proprio dramma privato. Forse quel silenzio permette ora di guardare avanti, lasciandosi alle spalle l’abisso in cui si è eclissato un intero mondo.
Così come la menzogna di Jakob vorrebbe risuscitare la speranza fra gli abitanti disorientati del ghetto. L’intenzione è buona ma le conseguenze disastrose. Come tenere a bada l’insistente curiosità di tanti disperati? E come evitare che le notizie passino di bocca in bocca e dilaghino dappertutto rischiando di finire alle orecchie della Gestapo? Jakob cerca inutilmente di correre ai ripari: si rallegra dapprima della mancanza temporanea di elettricità, poi dichiara che la radio si è rotta, sottrae frammenti di giornale a un guardiano e ogni tanto si lancia in nuove fantasie in attesa che alcuni grammi di notizie possano trasformarsi «in una tonnellata di speranze».
A sentir lui i russi non sono molto lontani da Lodz e forse già marciano verso la cittadina di Tobolin, anche se la battaglia sul Rudna è stata dura perché i tedeschi hanno fatto saltare un ponte. Che attore quel povero Jakob assediato dai compagni e vittima della propria generosità! Arriverà al punto di imitare per la piccola Lina, i cui genitori sono stati deportati, voci e suoni della radio che anche lei vorrebbe vedere. È una scena di grande comicità in cui l’inquietudine e l’astuzia della bambina hanno il sopravvento sugli ineffabili conati vocali dello speaker: di nascosto lei scopre dietro il paravento della cantina che la radio non è altro che lo stesso Jakob.
Utopie, speranze e sogni si confrontano nel ghetto di Lodz con il dolore quotidiano finendo per sgretolarsi poco a poco. Anche il barbiere Kowalski, grande amico del protagonista, corre verso un’impossibile libertà sull’onda delle notizie che Jakob ogni tanto gli snocciola per poi sentirsi dire, alla fine, che era tutta un’invenzione e, a quel punto, decidere di morire. Pensava che la capacità di sopportazione di un uomo fosse enorme, ma ha dovuto ricredersi perché le porte dell’inferno sono sbarrate.
Attraverso la testimonianza di un sopravvissuto del ghetto amico di Jakob, Jurek Becker ricostruisce con delicata sensibilità l’atmosfera di uno shtetl in cui echeggiano voci lontane e pagine di narratori ebraici. Figure come i giovani Mischa e Rosa all’alba del loro amore, e il padre di lei, l’attore Felix Frankfurter, lui sì proprietario di una radio che distruggerà per timore di essere scoperto, o il medico Kirschbaum, che si dà la morte pur di non dover curare il capo della Gestapo Hadtloff, e infine Herschel Schtamm ucciso da un guardiano perché si era avvicinato a un vagone ferroviario da cui provenivano voci umane, segnano con le loro tensioni e fobie, con la gioia per la vita e l’ansia per il futuro il confine fra la speranza e lo scoramento. E poi c’è Jakob, l’uomo che distribuisce come un folle e un disperato porzioni di temporanea felicità. Forse perché guardando il volto della piccola Lina la vita gli appare sconfinata e dolce. Come quel paesaggio di alberi là fuori, ontani betulle e pini, che addolciscono l’affanno, mentre nella notte il treno della morte trasporta tutti gli abitanti del ghetto verso il nulla.