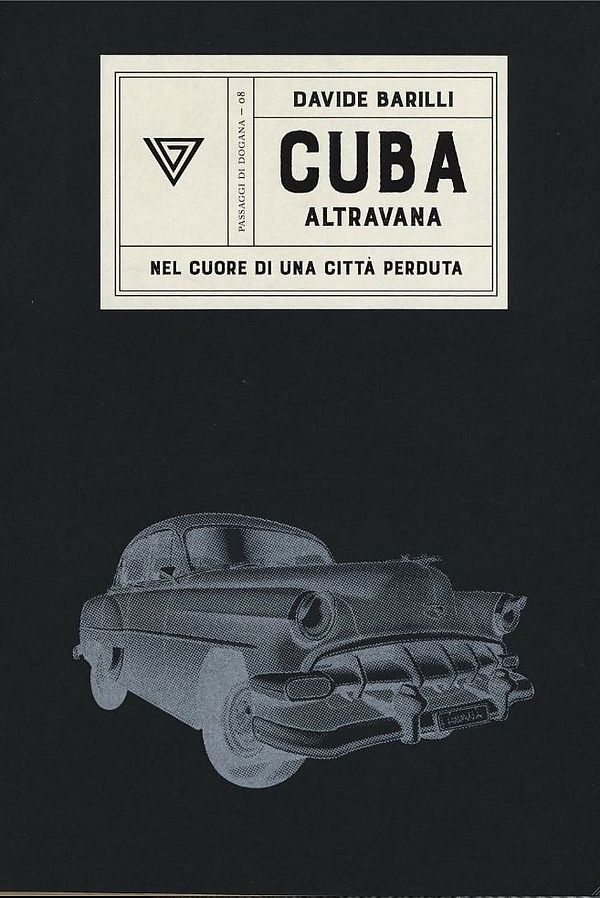Premessa a scanso d’equivoci: chi ritiene che un viaggio a Cuba debba prevedere tre giorni all’Avana, proseguire con un pacchetto di locations proposto da un’agenzia e concludersi con il tradizionale piatto forte, ovvero un villaggio vacanze in stile falso-tropicale, ignori questo articolo e passi oltre. I cliché su Cuba e l’Avana sono talmente noti che è quasi superfluo elencarli: il lungomare del Malecón, la spiaggia di Varadero, il mito del Che (e ora di Fidel), il rum a fiumi, le jineteras e le nonnine con il sigaro, i bar frequentati da Hemingway (in ognuno dei quali avrebbe scritto Il vecchio e il mare), le vetuste automobili americane, la musica nel sangue, poveri ma belli, il mojito e il daiquiri, l’ostinato rifiuto d’aprirsi ai gringos. Insomma, un’isola che forse più di qualunque altra galleggia sopra uno spesso strato di (nostri) preconcetti.
Ma oltre la massa del turismo mordi e fuggi, oltre le spiagge e lo stile festaiolo e massificante dei quartieri più battuti, esiste un’Avana quasi segreta, una città incredibile, grondante di una grandezza nostalgica e dai molti cuori pulsanti a dispetto dell’endemica crisi economica. Il recente volume di Davide Barilli è un’immersione affascinante nelle contraddizioni di questa gioiosa e malinconica metropoli caraibica.
Fatiscente e fastosa, spossata dall’embargo eppure palpitante di vita, ridondante di memorie architettoniche di un’epoca opulenta e scellerata, enigmatico palcoscenico esotico, metafora di un’utopia tradita, luogo di ogni nostalgia, l’Avana è la città dai giorni tutti uguali, ma in cui ognuno di essi può rivelarsi irripetibile.
Rosario Assunto, il filosofo del paesaggio, sosteneva che per capire intimamente lo spirito di una città occorresse visitarne i mercati, i tribunali e i giardini. È con questo spirito, nutrito di infinite letture, che l’autore ci conduce per mano nell’Avana più autentica, o almeno nei molti luoghi che ancora conservano «el espíritu de la cubanía», quel sentimento che raccoglie e amalgama sensibilità ed esistenze in continua ebollizione, mutabile comprensione e incessante scambio. Tra elenchi di bar de mala muerte (l’Avana ha più bar di Manhattan, benché polverosi e scassati), consigli su come contrattare il prezzo con i taxisti abusivi e comedores per cubani indigenti, non si può dire che questo sia un Baedecker per fricchettoni o viaggiatori con la puzza sotto il naso. Ma vuoi mettere la soddisfazione di vivere l’Avana dal di dentro? Se poi i motivi del viaggio sono d’ordine musicale o si è mossi dalla passione per i balli tropicali, allora il libro offre ulteriori piste per scoperte genuine tra son, rumba, guaracha e guaguancò.
La descrizione della visita a un anziano curandero per alleviare un fastidioso mal di stomaco è il perfetto compendio di un’Avana putrefatta e vitale, inaccessibile al turista frettoloso. Il «negromante» vive in un edificio «altissimo, traballante e moribondo come un antico ed elefantiaco candelabro, lugubre come una bocca sdentata, con finestre cieche simili a tombe. Il portone è un’enorme saracinesca grondante di ruggine, che nessuno apre da secoli. Perché si apra è necessario il grido di un vicino di casa, alcolizzato. Ci vuole pazienza, come sempre qui all’Avana. Poi, annunciato da un clangore sporco e stonato, nel fondo di un cavedio sgocciolante miasmi vegetali, si socchiude una porta grazie a un complicato gioco di carrucole che trainano corde avvolte come liane attorno a un corrimano. Al di là si arcua una scalinata che sembra un sentiero nel mezzo di una giungla polverizzata. Salire significa accettare la follia, gradino dopo gradino, di una parete ricoperta di alghe secche, enormi foglie appese come feticci che penzolano sinistramente nel vuoto, secchi ricolmi di brandelli di piante, ramaglie, radici, agavi annerite, bulbi misteriosi...» Al lettore il piacere di assaporare l’intruglio del fattucchiere (pag. 62).
La letteratura e l’arte cubane, come accade sempre in ogni luogo in cui la libertà d’espressione è limitata, risultano molto vive. Una schematizzazione manichea tende a dividere gli scrittori tra chi rimane a Cuba e la diaspora degli esiliati. In ogni caso un luogo in cui si respira un’aria di (parziale) libertà è la sede dell’Associazione scrittori e artisti cubani (UNEAC), una nobile dimora in stile coloniale con giardino tropicale e bar ben frequentato da scrittori, poeti e studiosi. Un luogo dove discorrere di letteratura, fare incontri significativi e in cui le celebrità nazionali sono a portata di mano. Come un tempo, in Europa, il Caffè Giubbe Rosse a Firenze o la Closerie des Lilas a Montparnasse. In questo affascinante luogo di aggregazione culturale, due volte alla settimana all’ombra delle palme dell’UNEAC si tengono peñas di rumba e bolero.
Ma il rullo compressore del turismo inizia a farsi sentire anche nei quartieri popolari dell’Avana. La gentrificazione si insinua anche a Cuba, frenata solo «grazie» al cinquantennale blocco statunitense.
Il cuore più autentico della città (e del libro) è Centro Habana, «luogo di visioni e fantasmi, di ruderi e palazzi che sembrano sospesi sull’orlo di un abisso, a picco sulle distese di vite inventate giorno per giorno». A Cuba, sbrigare una banale pratica amministrativa può rivelarsi un’esperienza memorabile: «Improbabili uffici dall’aspetto spettrale, kafkiane metafore tropicali di un sinistro immobilismo incarnato in cassettiere cigolanti, in fogli di grezza carta sovietica accatastati su tavoli unti di pollo, in attesa che il solerte funzionario finisca di mangiare il suo piatto di congri». Camminando per Centro Habana ci si sorprende d’imbattersi, incastonato tra palazzi che si sfarinano, nel sontuoso teatro lirico Campoamor, di inizio Novecento, dove si esibirono i più famosi cantanti dell’epoca. O meglio, ciò che resta del teatro, perché gli unici spettatori sono ormai le piante equatoriali che vi hanno preso dimora e gli uccelli tropicali che hanno nidificato nel loggione. Scenario folle che ricorda Fizcarraldo di Werner Herzog, è la cifra di questo quartiere dell’Avana, così autentico e al tempo stesso così assurdo.
La città, gigantesco lupanare dei tempi di Batista, conserva innumerevoli testimonianze polverose di quel periodo peccaminoso. Un esempio a parte, fulgido e fatiscente, sono i numerosi bar americani dell’epoca, molti dei quali fortunatamente rimasti intatti. Chi volesse rivederne due celebri, filmati appena prima della rivoluzione, cerchi Il nostro agente all’Avana, il film di Carol Reed del 1959. Teatri, bar e hotel, feticci dell’immaginario habanero, fastosi relitti di un’epoca remota, ma capaci di fermare il tempo di un’isola dalle mille identità. A Cuba si direbbe proprio che il tempo proceda come in certi film di Buñuel, dove il dopo non è detto che segua il prima. E un clamoroso caso di riavvolgimento temporale è stata la risurrezione/invenzione del gruppo musicale Buena Vista Social Club di Compay Segundo, come viene tratteggiato nel celebre documentario di Wim Wenders.
Il vero viaggiatore andrà così alla caccia dei tanti testimoni che ancora punteggiano l’Avana d’antan, fastosa e raccapricciante. Uno degli esempi più illustri, purtroppo ultimamente ammodernato malamente, è l’hotel Lincoln, rutilante monumento costruito nel 1926, quando la mafia spadroneggiava sull’isola. Questo inverosimile albergo ha (o meglio, aveva) un suo irresistibile fascino dato dall’anticaglia polverosa che, chissà fino a quando, lo contraddistingue: enormi lampadari veneziani, porte con mezzelune dai vetri colorati, piastrelle portoghesi, cameriere straripanti su tacchi altissimi, la stanza-museo dove Manuel Fangio fu sequestrato dai barbudos nel 1958...
Ma il viaggiatore letterario, con la carica di feticismo che lo contraddistingue, ha ancora un desiderio da esaudire: vedere di persona i luoghi, le vie, le case in cui soggiornarono. Con consumata sapienza, Davide Barilli guida il lettore dentro i vicoli più nascosti e gli dà l’illusione di entrare nelle case di Gutiérrez, di Piñera, di Lezama Lima o di Padura Fuentes. Dove magari, in fondo a un intrico di viuzze, invece dello spirito dello scrittore, si assapora il profumo di fagioli bolliti.