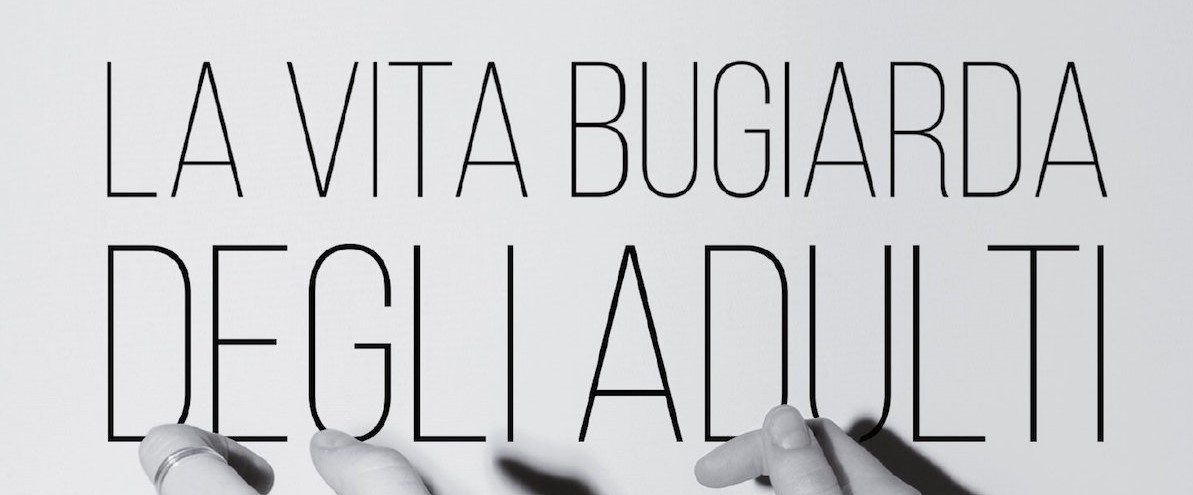Sono strane le strade della censura: se non sono infinite come quelle della Provvidenza, di certo sono contorte. Parlare di censura rispetto all’ultimo romanzo di Elena Ferrante sembra un’assurdità, eppure…
La vita bugiarda degli adulti, l’ultimo libro edito da E/O della più celebre scrittrice italiana vivente, ha suscitato un gran polverone, ma questo era piuttosto scontato. Non solo infatti si tratta dell’opera di una delle autrici italiane più letta e tradotta di sempre, c’è anche di mezzo la questione dell’identità, del nome della scrittrice che, come di dominio pubblico, non è mai stato reso ufficialmente noto, anche se a seguito dell’inchiesta del 2016 a opera di Claudio Gatti per «Il Sole 24 ore» sembra ormai quasi certo si tratti della traduttrice Anita Raja.
La curiosità però sarà pure un peccato, ma non è un delitto, la censura sì. L’attenzione destata da Ferrante in generale e da quest’ultimo romanzo in particolare hanno infatti reso palese un atteggiamento che da qualche tempo circonda i romanzi dell’autrice: lo sprezzo intellettuale. Per chi ha una formazione culturale e letteraria solide o ancor di più per chi si occupa di scrittura per mestiere disprezzare la Ferrante è spesso un imperativo categorico. In occasione di quest’ultima pubblicazione tra questi «intellettuali» coloro che hanno il vizio di polemizzare sui social network hanno portato avanti una caccia alla streghe: vietato dire bene del romanzo, pena essere accusati di essere servi del sistema.
A parte pochi scarni commenti quali: «non mi è piaciuto», «non mi ha preso», non è facile ottenere una sola buona ragione per questo disprezzo dei romanzi di Ferrante da parte dei più colti. La risposta che si dovrebbe riservare a questo antipatico pregiudizio, a cui tutti coloro che ambiscono essere considerati fra chi «se ne intende» sottostanno, è simile a quella che si dovrebbe dare per rispondere al più castrante dei salutismi. Chi disprezza Ferrante a monte, perché mainstream, ricorda un po’ chi non mangia mai un fritto perché fa male, chi ripudia il burro perché è grasso, chi ha abolito l’aglio e la cipolla dalla propria cucina, perché sono pesanti… Tutte privazioni che, seppur all’apparenza benefiche, sono solo in fin dei conti castranti.
Leggere i romanzi di Elena Ferrante significa incontrare una romanziera e questo a sua volta permette di essere trasportati nell’altrove letterario, come se ogni lettore avesse la leggerezza di una pagina e fosse facilissimo farlo spostare, conducendolo nel mezzo della storia narrata. Il piacere di questa esperienza equivale, per restare sulla metafora culinaria in questi tempi di gran moda, a potersi saziare delle prelibatezze più golose, senza effetti collaterali né sul peso né sulla salute.
La vita bugiarda degli adulti non fa eccezione. La storia di Giovanna che è anche Giannì è quella di una ragazzina figlia di una coppia di intellettuali, che cresce adorando in particolare suo padre, che si rivelerà presto come uno «degli adulti, persone ragionevolissime nei loro corpi pieni di sapere. Cosa li riduce ad animali tra i più inaffidabili, peggio dei rettili?». Quest’uomo odia la sorella e la grettezza del sottoproletariato napoletano da cui lui stesso proviene, ma zia Vittoria pare essere invece la persona della famiglia a cui Giovanna assomiglia di più. Ed è bruttissima.
All’interno di una storia densa di personaggi, di particolari, di emozioni e pensieri, attraverso il personaggio di Giannina Ferrante racconta la banalità devastante del percepirsi brutta per una ragazzina. Una delle esperienze che si danno per scontato, a cui poche sono rimaste indenni. E ancora l’evidenza mai del tutto sopportabile che ciò che viviamo da bambini in casa influenzerà la nostra vita per sempre, perché ci scorre nelle vene un sangue che assomiglia troppo a quello di coloro che ci hanno procreato e se ci capita la sventura che questi si dimostrino degli esseri indegni, quella pecca ci perseguiterà.
Come sempre Ferrante non dimentica la differenza di classe, fonda ogni sua storia sulla differenza di genere, perché i racconti di donne e uomini, le storie d’amore, sono anche storie di disparità, e di ingiustizie.
La filosofa Adriana Cavarero sostiene che la letteratura non ignora l’universale, come vorrebbe la vulgata, ma lo racconta attraverso il particolare. Ferrante fa questo e a dispetto di tutti i magri censori in circolazione fa della letteratura e la fa gustosissima.