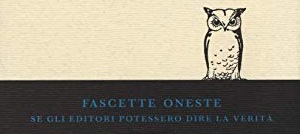«La fascetta è, per usare le metafore dell’abbigliamento, una specie di mini-giacca ridotta al terzo inferiore dell’altezza del libro, i cui mezzi di espressione sono in generale puramente verbali, anche se sembra avanzare l’abitudine di introdurvi un’illustrazione, o un ritratto dell’autore».
In quel sistema complesso che è un libro cartaceo, la fascetta ha la sua funzione esclusiva, che la rende unica nella famiglia di soglie di accesso al nudo testo portato dal volume. È «una striscia di carta sovrapposta trasversalmente alla copertina delle novità librarie, su cui gli editori sogliono stampare poche parole»; si tratta di «piccoli urli di carta arrotolati attorno al libro, strilli pubblicitari con ambizioni critiche che quasi sempre la sparano grossa, la sparano enorme».
L’editore Marco Cassini, direttore della casa editrice SUR, dedica alla fascetta un nuovo breve volume (Fascette oneste. Se gli editori potessero dire la verità), che si apre con quella che si potrebbe definire gustosa introduzione, con la storia e la definizione del piccolo supporto, seguita da una specie di stupidario che raccoglie fascette di tipo inusuale, risultato di un notturno gioco tra amici di creazione di una serie aperta di blurb con la patente di onestà (cose del tipo «È una pizza e costa meno di una pizza», «In tutti i cestoni degli Autogrill, dopo il Toblerone», «Avrete sicuramente letto di peggio»).
Ora, ci perdonerà Cassini se indirizziamo il lettore verso la lettura puntuale nella sua abbondante rassegna e ci soffermiamo sull’attenzione per il piccolo supporto. Perché parlare di queste materie ci richiama, con struggente operazione di memoria, le stagioni della critica letteraria del tempo che fu, che ancora oggi muovono qualche sentimento. E così, nella memorabile schiera dei Roland Barthes, dei Claude Lévi-Strauss, dei Foucault, dei Roman Jakobson, dei Lacan e di molti altri, il posto a capotavola degli studi sul paratesto spetta a Gérard Genette.
Di lui può succedere di tornare a leggere e apprezzare quanto disse a proposito delle bandes, delle jaquettes, delle liseuses (qui l’originale francese, con rispetto per la traduzione italiana d’autore affidata a Camilla Cederna, si impone con determinazione metaforica impareggiabile), illuminandone il carattere virtuosamente precario, episodico ed effimero (la fascetta dura il tempo della novità in libreria). E quando disse, richiamando quel fascino argomentativo, che tutto questo materiale ha un carattere di transizione (tra testo e fuori testo) ma anche, e forse ancora di più, di transazione, «luogo privilegiato di una pragmatica e di una strategia, di un’azione sul pubblico al servizio di una migliore accoglienza del testo e di una lettura più pertinente, agli occhi dell’autore e dei suoi alleati». Dunque, tra i pregi del libro di Cassini c’è quello di costringerci ad avvicinarci alla libreria di casa, prelevare quelle antiche letture e infondere in noi un po’ di nostalgia.
Un libro dedicato al costume di avvolgere i libri in fascette non poteva non portare su di sé una fascetta; questo libro, in omaggio al suo carattere «metalibrario» (il libro che parla di libri), ha una fascetta stampata e non effimera che dichiara il titolo sulla prima di copertina e allude, nella quarta, alle pagine intonse tipiche della casa editrice che lo ospita. In una mirabolante vertigine di rinvii di primo, secondo, enne livello, l’editore si chiama Italo Svevo e accoglie raffinati scritti sull’amore per la lettura. Alle pagine intonse, si accompagnano pregi in grande numero: la carta Fabriano Palatina dell’interno, la Fabriano Palatina Brizzato della copertina, il carattere ITC New Baskerville, una direzione artistica, uno studio grafico per impaginazione e redazione, date e luoghi separati per la stampa (novembre 2019, a Vicenza) e la pubblicazione (dicembre 2019, a Trieste). Evviva. Evviva, il libro di carta.