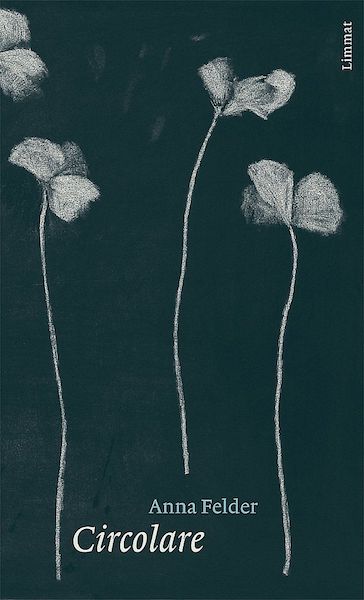«Non che siano tutte bionde, tu le trovi anche more, anche rosse, ce n’è per tutti i gusti, anche smorfiose che guai a guardargli la punta dei piedi, senti che dicono “cinch” cogli occhi brutti alle altre, che vuol dire “italiano” nella loro lingua. Ma tu un complimento alle belle lo fai lo stesso, un complimento mica è peccato [...]. Oh non credere che si stia sul tetto tutto il santo giorno a fischiare alle ragazze, per chi mi prendi, lavorare si lavora, e sodo, c’è il capo che controlla, ma una pausa, via, un momento di sosta ci vuole, siamo cristiani, lo dice anche il capo».
Anna Felder esordiva così, venticinque anni prima del Treno delle italiane di Giovanni Orelli (1995), nel pieno di quella temperie culturale segnata dal dibattito sulla temuta Überfremdung della Svizzera e così ben sintetizzata nella sentenza-lampo di Max Frisch: «Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen» («Cercavamo braccia, sono arrivati uomini»). Pubblicato a puntate sulla «Neue Zürcher Zeitung» nella traduzione tedesca di Federico Hindermann, agli albori di un sodalizio che sarebbe durato decenni, il primo romanzo di Anna Felder apparve nell’originale italiano soltanto due anni più tardi, nel 1972, con il titolo a lungo meditato di Tra dove piove e non piove (si legge oggi in una nuova edizione Dadò curata da Roberta Deambrosi).
Da subito l’autrice dichiarava implicitamente la sua cifra stilistica, la sua passione per gli spazi intermedi dell’esistenza, gli attimi apparentemente banali e invece profondissimi che stanno a metà, nel grigio, in quella serie ininterrotta di piccoli eventi quotidiani che finisce per comporre, sulla pagina, una inevitabile autobiografia: non tanto per le ampie zone di sovrapposizione tra la vita e il romanzo ‒ come la protagonista, anche lei, venuta da sud, insegnava italiano ad Aarau ed era al suo primo incontro-scontro con la cultura tedesca ‒ quanto per l’andamento ragionativo della lingua, per la gestione sapiente dei punti di vista, per il crescere della persona assieme al dispiegarsi della narrazione. Se una cosa fu subito chiara, è che nella prosa di Anna Felder il plot, il «come va a finire», è del tutto secondario rispetto allo scavo linguistico e al pacato incedere della scrittura. Qualcosa che, con le debite tare, si potrebbe far risalire fino alla grande scuola di Marcel Proust.
Il secondo titolo è di poco successivo e pare nascere da una costola del primo: la casa-treno di Aarau che sta al centro di Tra dove piove e non piove, e su cui pende una minaccia di sfratto, si trasfigura e diventa (a Lugano?) il cuore problematico della Disdetta, apparso da Einaudi nel 1974 per interessamento di Italo Calvino. La Svizzera italiana non sarà mai sufficientemente grata a quegli illuminati curatori di collana che, tra gli anni Sessanta e Settanta (a Milano, per la Mondadori, lo stesso ruolo svolse Vittorio Sereni), fecero di tutto per agganciare i nostri autori al carro maestro della letteratura italiana, anche da un punto di vista editoriale: Giorgio e Giovanni Orelli, Felice Filippini e Angelo Casè, tra gli altri, poterono giovarsi di questi «favori» meritati. Nel caso della Felder, non desta sorpresa che un romanzo brillante e surreale come La disdetta, narrato dal punto di vista di un gatto che fa il gatto, ma conosce le sinfonie di Brahms, giudica gli uomini da pari a pari, li adora e li irride, abbia toccato le corde di Calvino. Lo stravolgimento del punto di vista era ancora, dopotutto, una dichiarazione di letterarietà, un rimettere le briglie saldamente nelle mani dell’autrice.
Da allora la produzione narrativa di Anna Felder è cresciuta con costanza, senza eccedere, anzi con grande garbo, più in direzione di una prosa breve, frammentaria, aneddotica, che non di quella del romanzo vero e proprio. L’incastro narrativo ha ceduto il passo, sempre più, al cesello di una scrittura che frettolosamente si potrebbe definire minore, per genere e ambizione, e che è invece maggiore in tutte le sue parti. Si prendano, se un nome va fatto, le Adelaidi pubblicate nel 2007 dalle Edizioni Sottoscala di Bellinzona: un piccolo libro di grande complessità stilistica, quasi allegorico nel suo insistito ragionare per simboli sulle dinamiche di relazione, sul limite, la malattia, l’essere uomo e l’essere donna, sulla complessità del vivere.
La nuova laureata del Gran Premio svizzero di letteratura, che da anni si divide equamente tra il nord e il sud delle Alpi, tra l’italiano e il tedesco, ha depositato le sue carte presso l’Archivio svizzero di letteratura di Berna sin dal 2008. Anche quello un segnale inequivocabile di una forte consapevolezza della propria identità e dei propri mezzi; non una soluzione obbligata, ma una scelta che, come è avvenuto per altri autori italofoni della Svizzera (Giovanni Orelli e Alberto Nessi in primis), può avere un suo peso nel ridisegnare gli equilibri di una letteratura quadrilingue la cui esistenza, non senza ragioni, viene ciclicamente messa in discussione. Anche da questa prospettiva l’esempio di Anna Felder, tra dove piove e non piove, può essere di quelli da seguire.