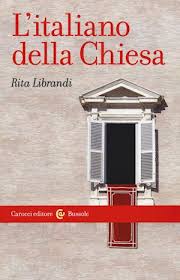«Far tutto il bene che si può, senza dare impicci a nessuno, cercando di mantenere viva la lingua italiana e le tradizioni della nostra gente. Io insisto molto sull’istruzione. Nel mio lungo viaggio all’America del Nord non feci che ripetere ai nostri connazionali queste parole: la lingua italiana: è questo il segreto per essere forti e uniti. Fino a che l’uomo parla la sua lingua, non perde la fede».
Ci sono diverse strade per arrivare al tema dei rapporti tra chiesa cattolica e lingua italiana; perché le intersezioni sono state innumeri e perché a ben vedere le spie di questa molto fruttuosa storia comune sono distribuite a tutti i livelli, dal sistema linguistico alla storia della lingua, alla sociolinguistica più attuale. Si avvisa subito che questo L’italiano della Chiesa, di Rita Librandi, è un profilo storico e come tale affronta poco le realtà dell’attuale ribalta planetaria che la chiesa garantisce alla lingua italiana; un dato che pure meriterebbe ben più di un accenno, più di qualche riga e tre o quattro rinvii bibliografici. Il fatto che il papa parli all’estero quasi sempre italiano, i dispacci della sala stampa, la stessa Radio vaticana, i discorsi e le udienze del mercoledì; insomma, molte modalità comunicative portano in giro l’italiano forse ben più che i classici canali del made in Italy, di musica, pizza, moda, calcio ecc. Una dimensione enorme, che è stata per secoli (ed è ancora in parte) appannaggio del latino ma che garantisce oggi alla nostra lingua rendite sociali e geografiche di grandi numeri e grande clamore.
Non così il libro della Librandi, che assume la prospettiva della storia della lingua e racconta il succedersi delle posizioni che l’italiano ha guadagnato con e grazie alla religione cattolica, dalle origini fino a ridosso di questi gloriosi giorni. Nella sostanza, la diffusione del messaggio religioso in tutte le sue modalità (scolastiche, liturgiche, dottrinali ecc.) e l’influsso della religione sulla struttura linguistica. Gli esempi e le declinazioni nei secoli dei secoli di cammino comune sono ovviamente tantissimi. A partire dall’inizio, perché una delle tesi sostenute in questo libro riguarda il fatto che sarebbe stata anche una certa politica linguistica della chiesa cristiana a frammentare e ridimensionare il latino e a dissolvere lo stesso Impero romano, vista la scelta precoce dei volgari nella comunicazione ai fedeli e il prestito di legioni di parole al sistema lessicale e sintattico del latino (attenzione a quest’ultimo termine: si sa che fin che si incide sulle parole si incide forse poco; quando però si raggiunge la carne viva di madama sintassi, allora per il sistema linguistico originario si mette male).
Comunque è in una certa ricerca della comunicazione agevolata con i fedeli, in tutte le sue forme, che la Chiesa ha sempre promosso la praticità dell’Umgangssprache, abitudini comunicative vicino all’uso orale, un codice dal volto umano e sorprendentemente adatto a tutte le contingenze politiche e a tutte le epoche. Come nel caso dei contesti di emigrazione, le scuole delle missioni all’estero, gli scalabriniani, i salesiani; una vera e propria pianificazione consapevole e attenta a conservare agli emigrati la lingua d’origine, ma anche a evitare loro l’isolazionismo linguistico della terra di approdo. Nella volontà, quasi politica, di permettere loro in un modo o nell’altro, con un codice o con quell’altro, di frequentare proficuamente il tempio.
Insomma, chi voglia occuparsi del successo e della fortuna dell’italiano nei suoi territori e nel mondo non può dimenticarsi di temi di questo genere, che a dire il vero non sono battutissimi nella linguistica italiana. La ricerca di nuove risorse per guadagnare alla nostra lingua i numeri e i valori di scambio dei giorni migliori non può che passare anche da qui.