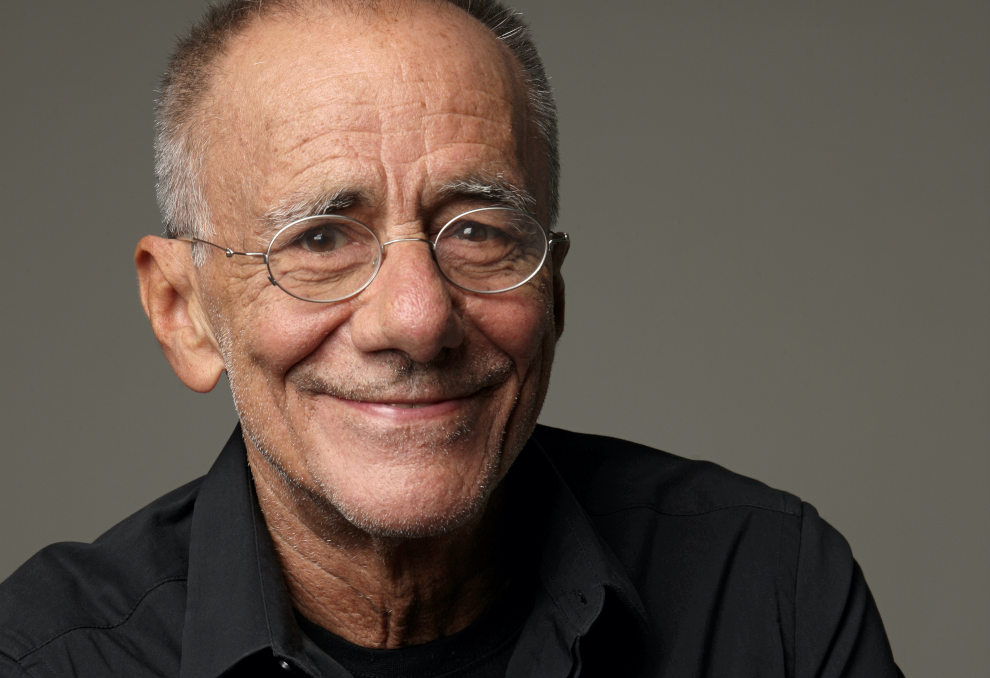Ci sono stati momenti nella storia della musica italiana che tributavano grande successo ai cantautori. Lei e i suoi colleghi eravate molto ascoltati ma soprattutto i vostri lavori erano sottoposti a un esame critico fortemente ideologico. I tempi di E spararono al cantautore, per intenderci. Oggi una cosa simile è impensabile. Come ricorda quell’epoca? Con nostalgia o sollievo?
Ogni corrente artistica corrisponde a una particolare situazione sociale ed esistenziale. Gli anni Sessanta-Settanta sono stati di pionierismo e rinascita: la canzone d’autore indagava il presente a 360° e viveva di proteste e speranze dove la sostanza tematica era forte e le forme letterariamente alte. Oggi la comunicazione musicale salta a piè pari la melodia e spara a mitraglia «parole-faro» con finalità distruttive tramite sconcerto e rabbia. Ho nostalgia, e tanta, della completezza semantica e dell’emotività intelligente di De André, Guccini, Dalla; ma non tutto nelle nuove leve è circostanziale e stereotipato. C’è del buono.
Certo si trattava di un momento molto particolare, in cui pareva che le persone fossero molto attente al significato dei testi, al loro impatto sulla vita di ogni giorno. Secondo lei, Luci a San Siro la capiscono, oggi, i ragazzi?
Sì e no. I ragazzi cestinano tutto ciò che ai loro occhi pare sentimentalismo e retorica. Vanno al sodo, ma si lasciano fregare dalla prima parziale impressione, scartano ciò che non capiscono subito, non operano il salto fra il particolare e l’universale. Le loro emozioni vengono da frammenti sconnessi di messaggio (forti, a volte), diffidano della parola «amore», tranne in casi particolari.La mia canzone nella domanda fa eccezione. C’è chi la considera un piagnisteo retorico, ma c’è pure (la maggioranza) chi entra in quello spazio e ne sente l’autenticità.
La sua carriera è stata molto particolare, e si è mossa su due piani, quello musicale e quello dell’insegnamento, tra palco e cattedra. Come riusciva a conciliare i due ruoli? Ci sono stati momenti di contatto tra le due esperienze, magari di conflitto, oppure di sinergia? Ai suoi allievi faceva ascoltare le sue canzoni?
No, ai miei studenti non facevo ascoltare canzoni, lo faccio ora che tengo un corso sulla musica d’autore all’Università di Pavia. Insegnare da una parte e cantare dall’altra non portano però alla schizofrenia, perché pur in forma differente c’è un denominatore comune e cioè l’uomo, quello dell’Umanesimo.In aula sono «servo di scena», non parlo di me, ma della meravigliosa fatica che hanno fatto la parola e l’arte per arrivare fino a noi e darci difese e speranze. Sul palco io questa fatica la vivo invece in prima persona e canto come è nata in me perché possa continuare negli altri.
In quegli anni pareva esistere una fortissima distinzione tra musica «pop» e musica impegnata (penso ad esempio nella sua stessa esperienza di cantautore e di autore per i Nuovi Angeli – bellissime canzoni, tra l’altro). Oggi sembra che una cosa del genere non esista più, si è tutto uniformato. È un bene o un male?
Sì, sono distinzioni inutili. Si è capito, e io ho capito, che la differenza tra bella e brutta canzone sta nel «vero», nella sincerità della testimonianza. Questo «vero» poi può essere letterariamente alto o più mediato, poco cambia. Insomma il contesto può essere «complesso» o «semplice», ma mai, per carità, «facile». Il «semplice» è sintesi, chiarezza, evidenza emotiva (poesia greca, trovatori). Il «facile» è inganno più o meno subdolo, gioco su facili slogan, è un approfittarsi delle debolezze sentimentali.
Recentemente Francesco De Gregori ha pubblicato un album in cui rende omaggio a Bob Dylan, un tributo che svela una sua passione (nemmeno troppo sorprendente) musicale e poetica. Facciamo finta che lei a Lugano voglia proporre un omaggio del genere: a chi sarebbe dedicato?
Certamente a Leonard Cohen, poeta immenso e musicista raffinato. In Cohen convivono complessità e semplicità in maniera così immediata che il «difficile» diventa miracolosamente e meravigliosamente intellegibile: ci senti dentro chiarissimo lo sforzo e l’orgoglio di essere uomo, la tempesta dei dubbi e la serenità dell’incoerenza. Non per niente De André lo adorava.