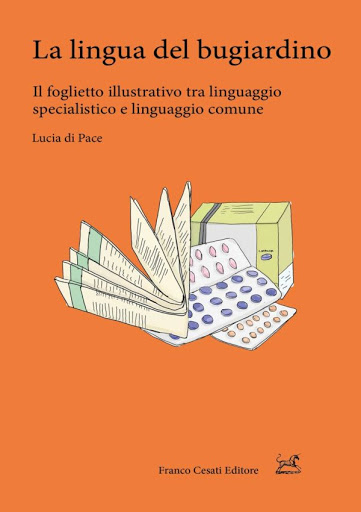«Se m’ingegnassi a scrivere un saggio sulla nostra lingua fra passato e presente, avrei difficoltà a intitolarlo La grande bellezza dell’italiano o L’italiano è meraviglioso. Mi accorgo che per gran parte della mia vita umana e professionale ho coltivato o inseguito la sregolatezza e il caos, l’oscurità e la bruttezza, la differenza e il dolore, la contaminazione e l’eterodossia, le sporcature e le anomalie, le anfrattosità e i percorsi accidentati».
Uno dei problemi che accompagnano da sempre il desiderio di svelare la storia, nei secoli, dell’italiano parlato risiede nel fatto che la nostra lingua è stata poco parlata e molto scritta (c’erano i dialetti) e che quel poco che si riesce a intuirne lo si deriva molto indirettamente da testi di scritto popolare. Un registro episodico, quest’ultimo, marginale, che porta certo l’odore di quella varietà ma che è sempre come un po’ vestito della festa e quindi quasi mai naturale e spontaneo.
Questo inusuale e profondo saggio di Massimo Arcangeli, Sciacquati la bocca. Parole, gesti e segni dalla pancia degli italiani, la prende un po’ alla larga: prima di tutto nel senso che non ne fa una questione solo linguistica e accoglie la dimensione pragmatica, cioè la lingua più il contesto, con i gesti, i milieux storici e sociali, i confronti con le altre lingue e tutto quello che trasforma il codice linguistico in comunicazione.
Questo libro ha poi un metodo piuttosto infrequente, riassumibile più o meno così: «non abbiamo la possibilità di cogliere queste manifestazioni di costume sociolinguistico direttamente dalla bocca dei parlanti e allora che facciamo? Andiamo nella tana del lupo, nello scritto dei classici e vediamo lì se riusciamo a cavarne qualcosa». Goldoni, Leonardo, Dante, i latini, il cinema, politici, autori meno conosciuti, braccati proprio nell’uso di espressioni che nei secoli sarebbero diventate parolacce e cattive abitudini linguistiche. Per datarle, identificarne le origini, valutare che cosa sono diventate dal lì a qui.
Prendiamo i gesti dell’ombrello e del dito medio alzato, che sono un po’ rappresentativi del carattere di novità nel materiale di Arcangeli; hanno una loro diacronia, in italiano: il primo è usato da Alberto Sordi nei Vitelloni e poi quasi scompare, evolvendo nel secondo, che è però scovato in carmi latini dedicati al dio Priapo, in Marziale («Riderai molto di chi ti avrà dato dell’omosessuale, o Sestillo, e gli sbatterai davanti il dito medio»), la Commedia dantesca, esempi classici francesi e spagnoli, americani («Negli Stati Uniti il dito medio alzato sarebbe stato introdotto nell’Ottocento da immigrati italiani»).
Dai gesti alle parole il passo è banalmente breve; c’è a pagina 44 un elenco sistematico e scientifico di occorrenze nel cinema americano di parolacce che richiamano parti intime, di vari ambiti e gradi di volgarità. Dai gestacci, al sessismo, ai riferimenti obliqui alle identità di genere e di provenienza geografica, al linguaggio politico, il testo procede per scarti e sorprese con generose inserzioni delle preziose fonti, e serve un catalogo ragionato e approfondito del malvezzo comunicativo e linguistico.
Questo libro non si legge con comodità; perché la sincera e tormentata ricerca dell’autenticità dichiarata da Arcangeli fin dalle prime righe riguarda la sostanza della ricerca e il suo contenuto, ma anche un caratteristico tessuto testuale semilavorato, che richiama la voce degli originali, propone spesso le impressioni e i ragionamenti quasi come se il linguista diventasse una specie di narratore e, non da ultimo, arricchisce il tutto con un talora destabilizzante apparato iconografico. È un libro sorprendente e nuovo. Al lettore soddisfatto si concederà qualche riserva sull’immagine di copertina, irriferita qui e certamente non all’altezza.