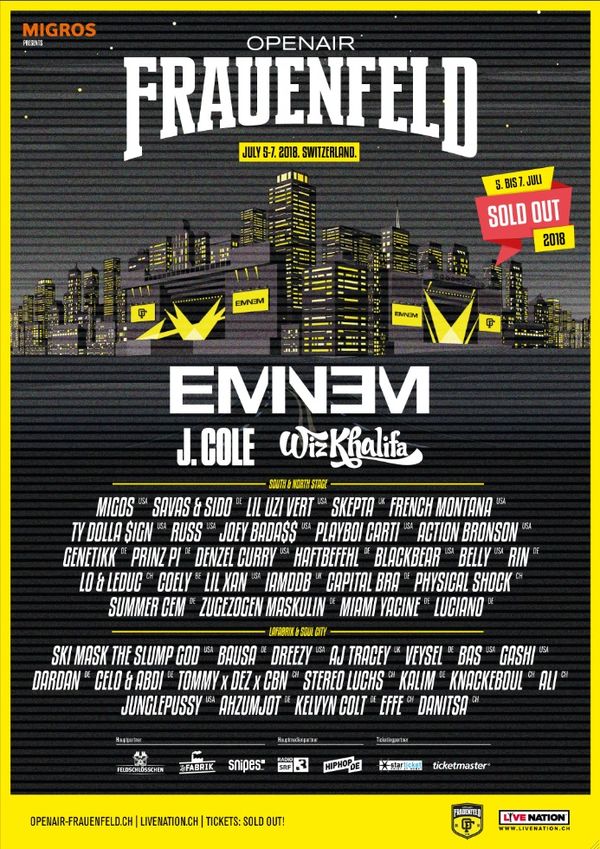Il percorso del giovane regista Karim Sayad è decisamente atipico: Master in relazioni internazionali a Ginevra per poi ritrovarsi, quasi per caso, a Cinéforum, attorniato da grandi personalità del cinema svizzero, ma anche da giovani registi alla ricerca di salvifici finanziamenti. La sua passione per il cinema lo accompagna da anni. ma sarà l’esperienza a Cinéforum a dargli il coraggio di passare all’azione. «Perché non io?», è la domanda che spinge Karim Sayad alla ricerca della sua personale verità, quella che il cinema algerino tende troppo spesso a dimenticare.
La casa di produzione ginevrina Close Up Films ha creduto in lui, nel suo sguardo unico e misterioso, producendo il suo primo documentario, Babor Casanova (2015), selezionato in numerosi festival internazionali tra i quali quello di Locarno.
Il suo primo lungometraggio Des moutons et des hommes (recentemente selezionato da Swiss Films per la Mostra Internazionale di cinema di Sao Paolo), sempre prodotto da Close Up Films, conferma il suo talento e la sua «verve» incisiva e controcorrente. Il film parla di gente comune (allevatori di montoni che cercano la gloria attraverso i combattimenti clandestini), di delusioni e frustrazioni ma anche di piccole e grandi vittorie. Karim Sayad ridà umanità a quanti l’hanno persa ormai da un pezzo, ascoltandoli e osservandoli senza giudicare. Esteticamente poetico, il film trasforma il reale in qualcosa di grandioso, come a volerci dire che spesso la bellezza si nasconde dove meno ce l’aspettiamo.
In un’intervista al «Courrier International» ha detto: «Il cinema è il miglior mezzo per esprimere il mio rapporto con l’Algeria: un’attrazione passionale e una repulsione razionale». Cosa intende?
In realtà questa frase è di mio padre, parla del suo rapporto con l’Algeria, e mi rappresenta molto. Abbiamo tutti delle identità complesse, ma ai binazionali si domanda spesso di scegliere. A me chiedono: sei più svizzero o algerino? Attraverso il cinema posso mostrare che sono entrambe le cose, senza bisogno di fare una scelta; metto in avanti la complessità e la ricchezza della mia doppia identità.
Dove nasce il tuo interesse per i personaggi «ai margini»?
Ho voluto rappresentare queste persone perché mio padre è algerino e quasi tutta la sua famiglia vive in Algeria. Viene da un ceto sociale piuttosto modesto. Da piccolo andavo spesso in vacanza dalla famiglia di mio padre, e durante le estati guardavo dei film che all’epoca trovavo geniali perché mostravano un paese che non conoscevo, di classe media, dove le ragazze e ragazzi si frequentavano, bevevano alcol e si divertivano.
Da un certo punto di vista ringrazio questi film, però non capivo perché le persone del ceto sociale dei miei famigliari non fossero mai rappresentate. Trovavo uno squilibrio inaccettabile tra il ruolo di queste persone nella società algerina e la loro non-rappresentazione al cinema. Mi sono detto che forse c’era spazio per la «mia» visione delle cose, per dare un volto e umanità a questa gente. I personaggi dei miei film sono spesso mal visti dalla società algerina, messi da parte: io volevo prenderli per mano dandogli corpo e voce. Non scuso i loro errori, ma cerco piuttosto di ascoltarli e di capire il loro punto di vista. Queste persone mi toccano profondamente. Forse il fatto che viva (geograficamente) al di fuori della società algerina mi aiuta ad avere uno sguardo «diverso».
Nel tuo lungometraggio le immagini sono maestose e il lavoro sulla fotografia elegante e poetico.
Voglio ringraziare e sottolineare il lavoro di Patrick Tresch, il direttore della fotografia con il quale lavoro dai tempi di Babor Casanova. Patrick ha contribuito notevolmente all’estetica del film, nutrendolo con il suo tocco, la sua sensibilità, il suo sguardo. Fra gli artisti che ammiro ho un grande rispetto per il lavoro di Pasolini. Adoro Accattone e sono un fanatico del Neorealismo italiano. Pasolini rende maestose le persone «normali» e le immagini che ottiene flirtano magnificamente con la finzione, pur mantenendo un forte legame con l’immediatezza del reale.
Trovo questo divario tra brutalità del quotidiano e bellezza estetica molto interessante. Nei miei film ricerco quest’opposizione. In Algeria le differenti classi sociali non si mischiano e non si conoscono. Malgrado ciò, durante le riprese si è creata una sorta di microsocietà: la troupe era formata da persone di ceti sociali diversi che si frequentavano forse per la prima volta.
Quale rapporto si è instaurato con i protagonisti del tuo film? Come fai ad ottenere quest’atmosfera di immediatezza e poesia?
C’è un lato istintivo nella scelta dei personaggi. Per Des moutons et des hommes abbiamo organizzato un mese di casting. Volevo trovare un allevatore di montoni che mi permettesse di girare dall’inizio tutte le scene di combattimento. Si sono presentati dei personaggi con questo profilo ma non mi sentivo in sintonia con loro. I personaggi principali del film, Habib e Samir, mi hanno colpito sin dall’inizio: mi sentivo istintivamente legato a loro e volevo costruire il film attorno a questo legame. Io mi lascio guidare molto dal momento presente, dall’intuito. Arrivo sul set sapendo cosa mi piacerebbe ottenere ma rimango aperto agli imprevisti, in attesa che qualcosa catturi la mia attenzione.
Girare un documentario in Algeria e per di più nei quartieri che abbiamo scelto non è facile. La gente associa il cinema ai blockbuster e guarda con diffidenza al cinema d’autore o ai documentari. Il concetto di «attore» è un po’ vago e il rapporto con la cinepresa non è sempre facile. Malgrado ciò, con il passare del tempo la gente si è abituata a noi e i personaggi principali hanno saputo lasciarsi andare mostrandoci il loro lato naturalmente teatrale. A poco a poco si è creata una sorta di disciplina e i personaggi hanno giocato il gioco... è stato bello e toccante. Il loro modo di agire è diventato organico e intuitivo, e le scene più belle si ottengono appunto grazie a questo clima di rispetto e fiducia.