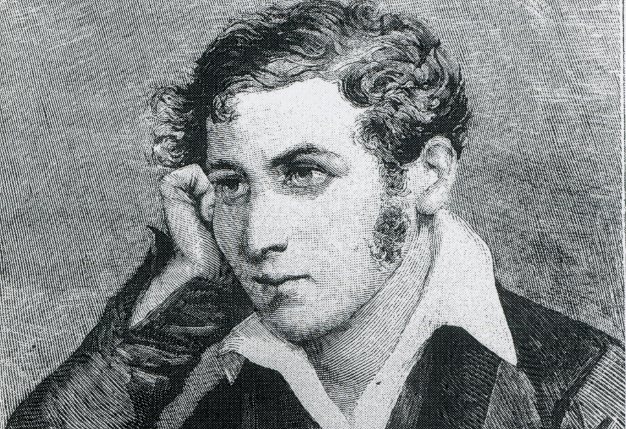Tra il serio e il faceto, negli ultimi tempi mi è capitato più volte di ricordare che Carlo Cattaneo è morto nel mio ufficio. Non che non sia vero, ma il fatto è sintomatico dell’abitudine tutta moderna di schiacciare il passato sulla contemporaneità, di leggere la storia senza prospettiva, facendone quasi una forma di gossip più o meno erudito. Ora che l’Archivio storico della Città di Lugano si appresta a lasciare Casa Cattaneo per la sua nuova sede, e a 150 anni esatti dalla scomparsa del suo più celebre inquilino (5 febbraio 1869), sarà bene tornare a rimettere le cose nel loro giusto ordine e dare a Carlo quel che è di Carlo, cioè un posto di riguardo nelle vicende che hanno segnato la storia della Svizzera italiana, ben oltre il suo ventennio di permanenza in riva al Ceresio.
Basterebbe citare l’annoso dibattito sulle trasversali ferroviarie alpine, che lo vide da subito propugnatore convinto del San Gottardo, contro l’ipotesi piemontese e genovese che voleva invece una via da Locarno al Lucomagno, per poi giungere a San Gallo, al lago di Costanza e infine in Baviera, senza toccare nodi cruciali quali Milano e Basilea.
Capace di una visione d’ampio respiro non limitata al corto raggio della contingenza, Cattaneo vedeva un’Europa unita grazie ai binari del progresso, in cui i popoli potessero collaborare tra loro senza perdere le loro caratteristiche e la loro autonomia. Federalista convinto (anzi «cantonalista», come amava ripetere) si occupò poco di politica, ma nella sua esperienza-lampo quale membro del Consiglio di guerra delle Cinque giornate intravide presto la necessità di condividere con la cittadinanza le decisioni e i verbali delle riunioni (fu prontamente osteggiato) e sempre promosse la diffusione e lo scambio delle più recenti conquiste scientifiche, due atteggiamenti che ne farebbero oggi un paladino di internet e uno strenuo difensore dell’open source. Aveva ereditato da Romagnosi il desiderio di una filosofia pragmatica, intrisa di diritto e di scienza, che fosse innanzitutto al servizio dell’evoluzione della società.
Non si tratta di attribuirgli chissà quali misteriose capacità profetiche ‒ un destino che tocca spesso i grandi, da Leonardo in giù, senza nulla aggiungere alla loro caratura intellettuale ‒ semmai di tornare a leggere i suoi scritti con la consapevolezza del suo essere stato, a tutti gli effetti, un classico, cioè un «contemporaneo del futuro», un autore dal cui confronto con il nostro presente possano sgorgare insegnamenti e consigli, anche soltanto in forma di intelligenti provocazioni. In un’epoca che ancora non riesce a estirpare il tarlo dell’antisemitismo (ma vale per tutte le forme di razzismo) le sue Interdizioni israelitiche non smettono di portare in superficie le contraddizioni e le difficoltà di una convivenza che solo sulla carta continuiamo a definire «civile».
Dopo la grande abbuffata delle celebrazioni per il bicentenario dalla nascita (2001), festeggiato a Milano e Lugano con mostre e pubblicazioni, di Cattaneo erano tornati ad occuparsi gli specialisti, i curatori degli opera omnia e dei volumi dell’epistolario, promossi dal benemerito Comitato italo-svizzero presieduto da Franco Masoni.
Un nuovo anniversario offre quindi l’occasione per tornare a togliere un po’ di polvere dagli scaffali, salvo il fatto che, libri alla mano, in molte pagine di Cattaneo c’è ben poco da spolverare, tanto il suo pensiero è rimasto limpido e attuale: «I popoli ‒ così scriveva in una delle prefazioni al Politecnico (1839-44) – debbono farsi continuo specchio fra loro, perché li interessi della civiltà sono solidarj e communi. [...] Il dover nostro è di conferire le poche forze nostre a questa impresa commune dell’umanità; il dover nostro è d’accrescere nella patria che abitiamo, colla lingua che parliamo, e colle felici abitudini naturali della nostra stirpe il dominio delle intelligenze». E ancora: «Noi dobbiamo partecipare a questa guerra tra il progresso e l’inerzia, tra il pensiero e l’ignoranza, tra la gentilezza e la barbarie, tra l’emancipazione e la servitù.
Dunque ogni idea vera e buona, da qualunque paese, da qualunque lingua ci arrivi, sia nostra, e immantinente, e come se fosse germinata sul nostro terreno». Parole sante, in cui echeggiano già i toni e gli slanci utopici (ma quanto abbiamo bisogno di quegli slanci!) che sarebbero ritornati nella Prolusione a un corso di filosofia con cui si inaugurava, nel novembre del 1852, il neonato liceo di Lugano.
Colpisce, in Cattaneo, l’insolita convivenza tra una visione del mondo abbracciata alla scienza (compresa la storia, da lui intesa secondo la lezione di Vico) e la capacità di conferire calore a quella visione per mezzo di un’intelligenza viva e di un linguaggio duttile e affascinante. Mentre biasimava il bello stile di molti scienziati e filosofi italiani della sua epoca, rei di non mettere molta sostanza nei loro discorsi estetizzanti, fondava di fatto una lingua della saggistica che avrebbe fatto scuola.
Qui sta forse il nodo principale dell’interpretazione moderna del pensiero di Cattaneo: come si fondano in lui passione e scienza, razionalismo e utopia, cioè quel «di più» che non ne permette l’assimilazione tout court al rigido positivismo di fine secolo e che, senza dimenticare le feroci diatribe antimetafisiche con Gioberti e Rosmini, lo porta fin sulla soglia di questioni non del tutto spiegabili all’interno del suo stesso sistema di pensiero.