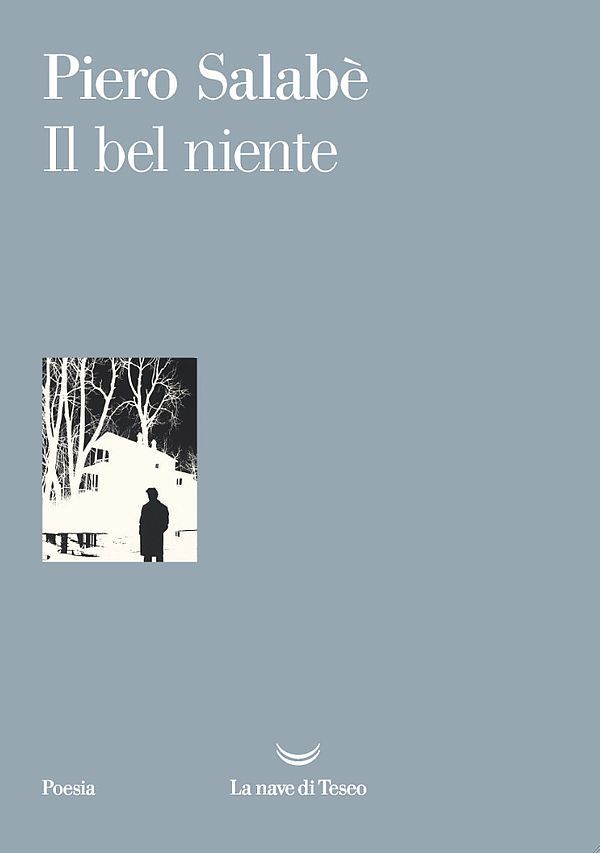Piero Salabè, germanista e ispanista, traduttore e già collaboratore tra gli altri del settimanale «Die Zeit» esce col suo primo libro di poesia dal titolo Il bel niente, prefato da Claudio Magris e già alla prima lettura, un’inquietudine profonda dilaga tra le pagine; difatti il verso spezzato e spaziato di Salabè, con le sue parole aguzze, scocca frecce acuminate che incrinano quella patina di luoghi comuni che l’uomo da sempre poggia su tanta parte della sua esistenza.
Ecco quindi una fitta serie di poesie proprio sulla questione amorosa e più precipuamente su quel momento che la fa scoccare: il bacio. Ma qui il poeta apre un mondo, che non pertiene solo alla questione relazionale tout court ma a quella molto più ampia del senso, se senso può averne, dell’esistenza: «bucano il tempo / i baci / respirano attraverso / la cucitura // sapore d’eterno / in terra nemica / nel tempo piccolo / quello grande / scompare //...».
È ricca la significazione metaforica che si dispiega in molte poesie e ci accorgiamo come alla prima lettura, l’apertura di significato sia appena iniziata e solo dopo un secondo passaggio, ecco parlare i doppi fondi, le istanze plurime, che ogni parola ha in sé e nella relazione con l’altra. E proprio il bacio, che potremmo pensare appartenere al tempo della luce e comunque a uno stato di grazia, si trasforma per converso, col suo pertugio d’accesso, la bocca, nell’antro ammaliatore della sibilla dal quale si è irrimediabilmente attratti.
E lo sfiorarsi del labbro appunto, non è il bel toccarsi d’anime novelle ma solo gioia dei sensi; è come giocare in due sull’uscio comune di un bel giardino sconfinato, nel quale mai però si arriverà e tanto profonda è l’alterità degli amanti che mai l’uno riuscirà a sentire la consonanza degli armonici dell’altro. Ci si illude e il bacio è la porta di una magnifica illusione, subito però fermata dalla fredda e dura cogitazione priva di retorica di Salabè, che non lascia scampo prima che a sé stesso, al lettore: «…// fuori gli errori schierati / in attesa- / le vite pronte a crollare, / i prevedibili destini, / l’odio sicuro // finché si baciano / di falso o vero amore / nulla ha presa //…».
Tutti possiamo coltivare, constata il poeta, solo il margine dell’altro e la presa metaforica si innesca ancora una volta su qualcosa non di astratto ma di fisico, il dito, sentito come propaggine estrema e finestra della storia di ogni identità; ecco in quella regione dell’altro sembriamo sostare e cercare con ostinazione, lo spazio di una minima comunione: «…// soggiorno felice nel / tuo margine, nella tua / unghia // il tuo resto è così lontano / luminoso / arcano //…».
E certo, l’altro tema molto cercato ma in stretto rapporto con questo della distanza tra i viventi, è quello del rapporto tra parola e poesia, che qui si carica di nuovi significati, quando lo scrittore proprio riprendendo le regioni della pelle, dà alla parola l’immagine come di una cuticola che a grattarla non si arriva alla poesia, che invece risiede in uno stato del succedere continuo, dove l’uomo vorrebbe arrivare con gli strumenti però perituri e spuntati della linguistica. Bacio e lingua, ribadisce Salabè, sono illusioni dell’uomo, costruzioni che con lui finiranno e comunque le parole che dicono, molte volte allontanano davvero dalla verità quasi sviandoci con le loro belle etichette di significato: «non la parola / fine // è la fine // e men che mai / la vera fine, il muto / scordare // ma lì nel letto bianco / da fare e rifare // nel fiore in fiore //…». Anche se di loro si ribadisce, non si può fare a meno; sono il nostro supporto, la nostra costruzione mentale, le stampelle senza le quali non avremmo camminato neppure quel poco.
E allora ecco lo sforzo impossibile, che si rafforza nel libro: ricucirsi in poche vere parole e allontanarsi almeno dalle tante inutili, che passato il genio di Montale, citato in verso, si rivestono di facile inutile parlato. E forse con l’inconoscibile vita ricoperta di veli, va a braccetto anche la poesia scritta in inglese The Unknown Poet (Il poeta sconosciuto), con l’archeologia del suo spirito sepolta tra le carte riposte nei cassetti, custodi di un sogno svolto in versi ma solo sogno appunto, come tutti i vaneggiamenti antropocentrici dell’uomo. Quella di Salabè, in questo libro che Magris acutamente definisce in bandella traversato da «…metafore di una originalità sorgiva…» è una riflessione a tutto tondo sull’uomo, sul suo cammino in solitaria e senza sponde, che i più rifiutano di pensare perché troppo abissale per potervi costruire la pur breve progettualità umana.
E l’ultima breve poesia, con i suoi molteplici rimandi, prende atto proprio della voragine ontologica in cui l’uomo si trova da sempre e per paradosso forse incita a vivere profondamente l’unico spazio che gli è dato, quasi sciolto dalla costruzione temporale, l’attimo: «le parole / sono poco / più del nulla // ma anche il nulla / ricorda / è cosa fasulla».