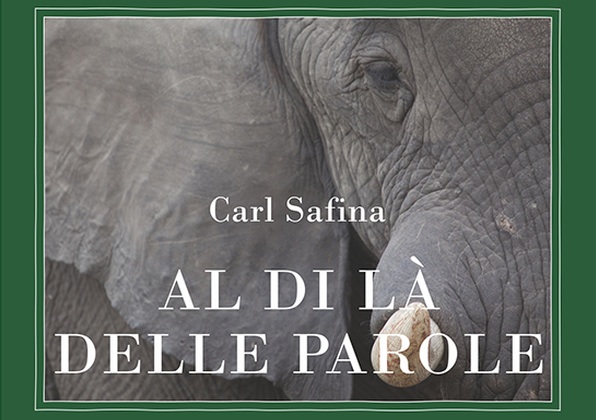«Se fossero qui gli EB, sarebbe stata una cosa immensa, piena di concitazione e di barriti, con moltissimi strofinamenti e toccamenti… Noi li chiamiamo la famiglia italiana, perché sono enormemente espansivi. I JA, una piccola famiglia, hanno i loro motivi per contenersi».
Con questo indimenticabile Al di là delle parole, del biologo e pubblicista americano Carl Safina, la casa editrice Adelphi inaugura una collana inusuale, almeno per l’Adelphi stessa, che si chiama «Animalia». Un libro che a prima vista spaventa, nella mole e nel vestito editoriale: con la bibliografia e gli indici fa circa settecento pagine e l’intento è enorme, perché si tratta di esplorare come tutto ciò che condividiamo con gli animali a livello di patrimonio genetico-evolutivo possa per sue strade ancora misteriose nascondere una dimensione cognitiva. In altri termini, si sappia che gli animali sono fatti come noi, e in particolare lo sono in parti cruciali del corpo e queste parti producono sostanze che sono come le nostre in contesti «biochimici» simili. «Sigmund Freud osservò che i neuroni di un gambero sono fondamentalmente identici a quelli che si trovano negli esseri umani», mentre Oliver Sacks precisò che ciò che distingue i nostri neuroni dai loro è il numero e l’organizzazione. Fatto il numero e fatta l’organizzazione, chissà che, in un modo a noi ancora inaccessibile, tutto questo apparato non possa produrre sentimenti, stati d’animo, linguaggio.
Quindi, figuriamoci gli elefanti! Perché agli elefanti africani è dedicata tutta l’ampia apertura di questo libro, che poi ci porterà con stile saggistico veramente stellare al cospetto dei lupi del parco di Yellowstone e di alcuni cetacei del Pacifico nord-occidentale nella loro comunicazione con l’uomo. Bisogna certo avere gran pazienza e abbondanza di tempo e di denari per cogliere parentele famigliari, comportamenti, differenze, abitudini di diversi branchi; per capire per esempio che gli elefanti sanno riconoscere «chi è parente di chi», che sanno godersi la vita appagati da situazioni estetiche e climatiche favorevoli, che piangono e sono tristi quando un esemplare muore e invano gli altri tentano di sollevarlo o lo coprono con rametti, che imparano a correre scuotendo il capo di qua e di là per avvisare gli altri che ci sono in giro delle api moleste. Però, raccolti tutti questi dati, raccontarli diventa uno spasso per chi scrive e anche per chi legge.
Qui ci sono elefanti, ma poi anche, detto, lupi e cetacei. Cercopitechi, uccellini di vario tipo, delfini. Senza dimenticare gli scimpanzé di uno dei grandi parchi della Tanzania: due furono osservati «arrampicarsi separatamente in cima a una collina al tramonto per poi accorgersi l’uno dell’altro, salutarsi, prendersi per mano e sedersi insieme a guardare calare il sole. Uno studioso scrisse di uno scimpanzé, libero in natura, che osservò per un quarto d’ora un tramonto particolarmente spettacolare». Certo di regola rimaniamo nell’ambito delle esigenze primarie: nutrisi, sopravvivere alle minacce, riprodursi, tutta l’eventuale comunicazione animale ruota attorno a queste tre semplici necessità. Ma Safina (e bisognerà credergli talmente la racconta bene) ci dice che alcuni delfini in cattività delle Hawaii conoscono la differenza tra «prendi l’anello da John e dallo a Susan» e «prendi l’anello a Susan e dallo a John» mostrando di potere accedere ad alcune primarie regole della regina del sistema linguistico, la signora sintassi.
Il procedere testuale di taluna saggistica anglosassone non rigorosamente e stucchevolmente scientifica ma sostenuta di verità ci colpisce sempre nel suo carattere straordinario. Un testo quasi narrativo, una serie interminabile di esempi tutti protetti da rinvii scientifici tanto rigorosi quanto discreti; quasi nascosti al lettore ma lì, se si vuole, pronti a essere presi e ascoltati. Per dirla alla Roland Barthes, esagerando un po’, «questo testo mi commuove perché, semplicemente, è così che vorrei scrivere». Settecento pagine. Volate.
Bibliografia
Carl Safina, Al di là delle parole, Milano, Adelphi, 2018.