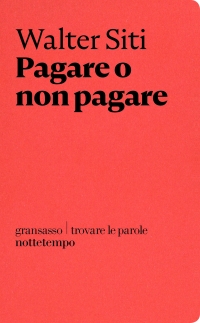Per una cifra modica mensile, Netflix offre agli abbonati più film e più serie e più documentari di quanti lo spettatore non professionista (leggi: non pagato per farlo, né obbligato alla corvée per aggiornamento professionale) riuscirà a vederne in una vita. Per una modica cifra mensile (o anche gratis, se non vi urta la pubblicità), Spotify mette a disposizione tutta la musica che c’è – più di quanta ne possiate ascoltare, anche mentre sbrigate altre faccende. Stando così le cose, e con l’offerta di notizie che troviamo su internet, non ti sembra che il prezzo di un quotidiano – da comprare tutti i giorni, perdipiù – risulti fuori mercato?
L’osservazione viene da un amico, stavamo chiacchierando di giornalismo (lettore seriale di libri e giornali, ma estraneo al mestiere). Il punto di vista aiuta a non dare le cose per scontate. Per esempio, a non valutare le offerte per quel che costano – e il giornalismo ben fatto costa assai – ma mettendosi dalla parte di chi deve spendere i suoi soldi e cerca di spenderli al meglio.
A questo punto scatta in automatico l’obiezione: nei giornali c’è il valore aggiunto, ci sono le fonti verificate, c’è da mettere in conto l’occhio dell’esperto. Sicuro, ma per far fronte alla confusione da troppa offerta sia Netflix che Spotify hanno già provveduto, uno con le raccomandazioni (dopo attenta profilazione degli abbonati) e l’altro con le playlist (dopo altrettanto attenta profilazione di chi usa il servizio, gratis o a pagamento). Resta la differenza di prezzo. Ma al contrario di quel che abbiamo sperimentato finora, per la generazione cresciuta con internet il prezzo di un servizio non è garanzia di qualità. Per dire: se un’automobile usata costa poco o niente, sospettiamo l’imbroglio. Su internet no, salvo poi scandalizzarsi se Facebook vende i nostri dati. O se li lascia sfuggire, in modo che altri possano farne commercio.
Capita a proposito un piccolo libro scritto da Walter Siti, appena uscito da Nottetempo. Si intitola Pagare o non pagare – così, senza il punto di domanda. Inizia con un po’ di autobiografia del professore universitario (sua la curatela dei Meridiani Mondadori dedicati all’opera completa di Pier Paolo Pasolini) diventato scrittore nel 1994 con Scuola di nudo. Un «body building roman», nella definizione dell’autore medesimo, che continuerà a parlare di soldi – e di corpi, e dei soldi che servono per comprarli – anche nei romanzi successivi.
L’autobiografia del giovane professore (Walter Siti è nato nel 1947) registra il piacere di pagare, una sorta di scalata sociale per chi proveniva da una famiglia di operai. Aveva potuto studiare, era stato ammesso alla Scuola Normale di Pisa, era salito in cattedra prima dei 40 anni – in pieno «edonismo reaganiano», ovvero gli anni Ottanta che tante nostalgie suscitano, vedere per credere l’ultimo film diretto da Steven Spielberg Ready Player One. Invece di farsi accreditare lo stipendio sul conto corrente, il neo-professore preferiva il mazzetto di banconote contate dall’impiegato allo sportello dell’università. Per poi fieramente comprarsi qualcosa che aveva adocchiato nei giorni precedenti.
Ora la mazzetta di banconote desterebbe subito sospetti. Come accade negli Stati Uniti quando si paga in contanti invece di esibire il denaro di plastica. Anche i truffatori si sono organizzati di conseguenza, come dimostrano le molte email che finiscono d’ufficio nello spam. Alcune chiedono dati bancari o codici segreti, pena la chiusura del conto (magari su una banca che mai abbiamo frequentato). Altri ripropongono su internet classici imbrogli, per esempio la grossa somma di denaro senza eredi da sbloccare. Siccome continuano ad arrivare, supponiamo che qualcuno ancora abbocca all’amico oppure all’amica che sostengono di essere rimasti senza soldi e documenti, e invocano un aiuto subito (intanto hanno disimparato l’uso delle maiuscole e dell’italiano, sarà lo choc del furto).
Siamo entrati nell’economia dello scambio e del low cost – da airbnb alle linee aeree agli sconti sui libri di Amazon (per non parlare della comodità di riceverli rapidamente, e del kindle benedetto). Ma esistono i costi nascosti, come segnala il documentario di Andrea Morgan The True Cost. E qui comincia la schizofrenia: lo sappiamo, ma facciamo finta di niente. Non serve un’intelligenza superiore per capire che se paghiamo un volo quanto una cena al ristorante il personale non sarà certo strapagato. Vale lo stesso per Facebook: «Quando qualcosa è gratis, il prodotto sei tu».