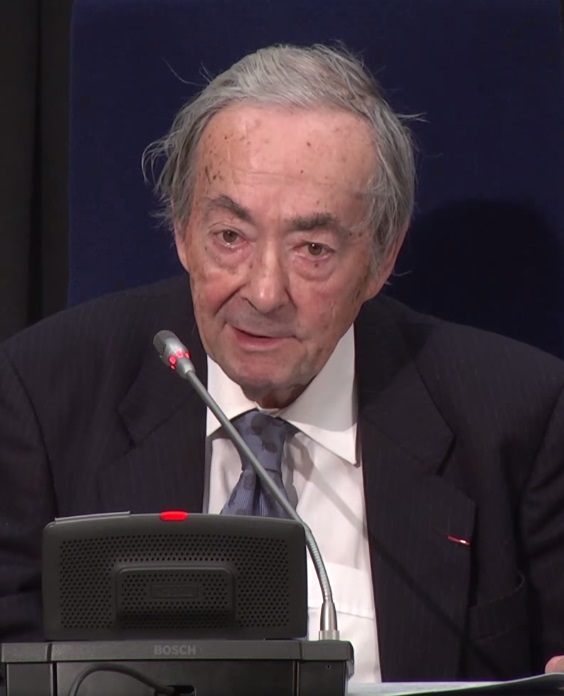La parabola intellettuale ed esistenziale di George Steiner (1929-2020) potrebbe essere riassunta in una singola parola apparentemente inutile, inespressiva, innocua, la preposizione «tra». La sua è stata infatti una vita di attraversamenti, di lingue e di nazioni, dall’Austria da cui proveniva la sua famiglia alla Francia in cui è cresciuto, fino all’esilio forzato negli Stati Uniti a causa del nazismo e alle numerose tappe della sua brillante carriera universitaria (Princeton, Harvard, Oxford, Cambridge, Ginevra).
Ebreo laico quasi perfettamente trilingue, lettore vorace e precoce, era innanzitutto un grande appassionato di letteratura (di musica, di arte), di cui sentiva dolorosamente tutte le implicazioni etiche, assieme ai limiti di una prassi accademica che aveva finito per soffocare l’effervescenza della creatività, la sua facoltà di parlare direttamente all’uomo, senza filtri né spiegazioni ulteriori. «Contro la cultura del commento», lo slogan che lo ha reso celebre, è insieme il suo principale lascito e una contraddizione in termini, data dal suo essere stato, a tutti gli effetti, uno dei massimi «commentatori» novecenteschi della tradizione occidentale.
«Noi veniamo dopo. Sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach e Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz». Lungo una linea di pensiero per certi versi affine a quella di Max Picard, nei suoi saggi degli anni Sessanta su Linguaggio e silenzio Steiner affrontò di petto temi cruciali come il rapporto tra la cultura e il male, la sopravvivenza della poesia dopo la barbarie (Adorno) e la possibilità per la letteratura di continuare a raccontare la realtà. Il basso continuo delle sue ricerche fu proprio questo dialogo continuo e ininterrotto tra il testo e il mondo, consapevole che non era più possibile, nel Novecento, leggere Eschilo o Shakespeare senza fare memoria dell’Olocausto, ma anche che le teorizzazioni estreme dello strutturalismo e l’algido disincanto del decostruzionismo («le acrobazie retoriche di certe tecniche semiotiche» scriveva pensando a Derrida) avevano prodotto danni seri alla nostra concezione della letteratura, che non può né deve prescindere dalle questioni morali.
Proprio su questi temi è incentrato il libro che, più di altri, mi sentirei di consigliare all’indomani della sua scomparsa: Vere presenze (1989), un appassionato elogio della «città primaria» della letteratura di contro alla «città secondaria» dei gravami accademici, della teoria-parassita che uccide il testo e lo allontana dal cuore dei lettori. Lo stile affascinante della sua prosa, le metafore ardite e i riferimenti cólti (a tratti approssimativi, figli della sua stessa erudizione) ne fanno un unicum del genere saggistico, il cui messaggio di fondo era già stato anticipato nel primo libro a sua firma (Tolstoj e Dostoevskij, 1960) e nella ferma convinzione che «la maggior parte della grande arte esige la fede». A distanza di trent’anni, con una consapevolezza accresciuta da innumerevoli letture, poteva ancora affermare che senza una prospettiva metafisica l’esercizio stesso della creazione artistica si svuoterebbe di senso, irrimediabilmente.
I frutti del genio umano si impongono come «vere presenze», svettano sopra la banalità del linguaggio quotidiano (feroce fu la sua critica del giornalismo), a patto di considerarli però qualcosa di semidivino, un incontro «eucaristico» che contiene in se stesso tutto il significato di cui necessita. L’edizione italiana del libro, approntata da Garzanti nel 1991, seguiva di pochi mesi la scomparsa di Gianfranco Contini, alla cui lezione Steiner ammetteva di aver guardato con rispetto e riconoscenza. Ne sentiva affine il bisogno di intendere la filologia come interpretazione e approssimazione, un discorso aperto, dialogico e pedagogico, quasi un atto d’amore. A disagio con le categorie della critica letteraria, che pure esercitò per decenni sui più autorevoli giornali (per trent’anni sul «New Yorker»), avrebbe voluto essere ricordato soltanto con «lettore». Un lettore plurilingue che aveva riconosciuto nell’esercizio della traduzione uno dei massimi esiti dell’interpretazione.
Non lost bensì found in translation è il motto che, da cantore della civiltà europea, meglio gli si attaglierebbe.