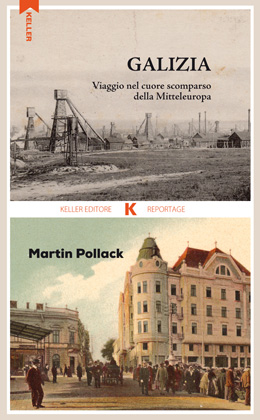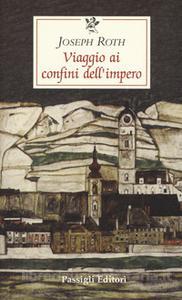Bastava salire a Cracovia sulla ferrovia Carl Ludwig per raggiungere la stazione di Pidvoločys’k alla frontiera russa, evitando magari di fermarsi a Przemyśl per mangiare una cotoletta di vitello ripiena, come fece il poeta e giornalista Karl Emil Franzos. Dentro ci trovò – ricorda in uno dei suoi racconti – un chiodo arrugginito, una molla d’acciaio e un ciuffo di capelli. Perché stupirsi? «Le ho forse detto – ribattè l’imperturbabile ristoratore – che deve magiare quelle vecchie ferraglie?». Meglio allora ripiegare sui treni della linea ungaro-galiziana diretti verso Budapest o in direzione opposta, a est, sulla ferrovia del Dnestr che seguiva le pendici dei Carpazi, e magari nella città di Kolomyja prendere l’espresso per il ducato di Bucovina.
Nei decenni fra l’Otto e il Novecento si può attraversare un intero paese anche senza muovere un passo: basta immergersi nello splendido libro di Martin Pollack, Galizia. Viaggio nel cuore scomparso della Mitteleuropa, pubblicato da Keller editore nell’ottima versione di Fabio Cremonesi. Un’opera, come ha ricordato Claudio Magris, che ha la precisione da orario ferroviario e il respiro vagabondo della grande prosa di Joseph Roth, di cui Passigli propone ora Viaggio ai confini dell’impero, una scelta di gustosi articoli scritti negli anni Venti per il quotidiano tedesco «Frankfurter Zeitung» e curati egregiamente da Vittoria Schweizer.
Proprio grazie a Roth, a Bruno Schulz, a Manes Sperber e a molti altri scrittori rievocati da Pollack possiamo rivivere l’atmosfera policroma e poliglotta, l’isolamento trasognato di quell’estrema provincia orientale dell’impero asburgico, che nella Grande Guerra si trasformò in un terribile campo di battaglia, e un paio di decenni dopo conobbe il genocidio nazista e le follie dello stalinismo. Là, diceva Roth, solo le cose essenziali come aria, anima e Dio, non mutano.
Cercare la Galizia sulla carta geografica è impresa inutile: è scomparsa da tempo, frantumata e suddivisa dopo due guerre mondiali fra i paesi confinanti. Per questo il viaggio proposto dall’affascinante baedeker di Pollack è una sorta di iniziazione all’immaginario, quasi un itinerario onirico in attesa di un miracolo che solo l’autore taumaturgo è in grado di evocare. Dal suo magico alambicco fuoriescono figure di un mondo travolto dalle tragedie del secolo scorso: artigiani e venditori ambulanti ebrei negli shtetl, contadini ruteni, piccoli agricoltori polacchi, zingari, romeni, e poi sui Carpazi Boscosi, la popolazione dei boyko, allevatori di bovini, e più ad oriente quella degli huzuli, abitanti di una terra odorosa di menta dove i pastori suonavano la trembita, il flauto di abete rosso lungo fino a tre metri. Grande era ovunque la presenza degli ebrei che parlavano jiddish, ortodossi e seguaci del chassidismo e discepoli dell’haskalah, l’illuminismo ebraico. Erano, per lo più calzolai, sarti, tessitori di tallit, lo scialle di preghiera, ma talvolta anche ricchi proprietari nella zona di Boryslav e di Drohobyč, città natale di Schulz, detta la Pensilvania della Galizia per i giacimenti di petrolio e di ozocerite scoperti verso la fine dell’Ottocento. In quel paesaggio infernale, dove l’aria era irrespirabile, lavoravano uomini, ragazze, bambini e gli operai erano trattati alla stregua di schiavi. Del resto quei paesi sperduti e soffocati dalla miseria erano non di rado riserve copiose per i trafficanti di ragazze avviate alla prostituzione anche nella lontana America.
Mentre sui Carpazi s’aggiravano banditi – spesso giovani sfuggiti al servizio militare – al punto che nel piccolo centro di Khyriv – si racconta – di notte gli abitanti chiudevano il municipio in cantina per proteggerlo dai ladri. Il libro abbonda di simili fantasiose storielle, a cui, per altro, ci aveva già abituato lo stesso Roth convinto che la sua Galizia (era nativo di Brody) favorisse lo sviluppo alla stranezza. E di quel paese Pollack ha colto con gusto aspetti surreali e personaggi bizzarri. A cominciare dalla figura dell’avido ebreo Selman, che per sfuggire a una condanna abbracciò la fede cristiana e da morto si trasformò in vampiro.
E che dire di Anna Csillag, di cui parla Bruno Schulz, autore dello splendido libro di racconti autobiografici Le botteghe color cannella, alla quale venne rivelato per grazia divina un miracoloso farmaco che ridava vitalità ai suoi capelli. Non è da meno lo stesso Roth che nel reportage su un famoso invalido polacco di Leopoli che si votò al suicidio dopo aver parlato a un’assemblea di storpi, ciechi, paralitici e scrofolosi, inscena una sorta di fantasmagoria dell’orrore. Quella miseria umana che accompagna il corteo funebre sembra uscire da un grottesco dipinto di George Grosz e avviarsi disperatamente verso il grande, annichilente Nulla.
Eppure dal sortilegio di quella provincia l’ebreo Schulz, un tempo studente all’Accademia di belle arti di Vienna, non riuscì mai a liberarsi; anzì la rievocò con struggente intensità come immersa in una dimensione di sogno. E lo stesso Roth rivela dietro il suo ironico distacco, una devozione e un legame illimitati per quella patria ormai sepolta dalle rovine della storia, di cui riesce ancora a cogliere colori, profumi, voci, insomma, l’atmosfera di un’intera epoca.
È una delle molte prospettive che Pollack recupera con grande fedeltà storica nel suo viaggio, attento anche ai luoghi della bellezza, soffermandosi in località di villeggiatura come Stryj e visitando il suo pittoresco mercato, per poi scendere a Cernici, città dalle mille immagini che sembrano ruotare nel mantello magico di Faust producendo sensazioni infinite. Forse siamo già in una vallata della Foresta Nera, ma fra le abitazioni del centro si respira l’aria di provincia austriaca, e poco più in là, ecco un angolo di campagna russa, mentre di fronte alla residenza episcopale vien da pensare all’antica Bisanzio. Di lì provengono poeti come Rose Ausländer e il grande Paul Celan, il maggior lirico di lingua tedesca del dopoguerra.
Non è possibile poi sottrarsi all’incanto architettonico della capitale Leopoli con le sue chiese polacche, rutene e armene accanto alle sinagoghe e agli oratori chassidici. In quel centro con funzionari imperialregi e caffè viennesi, dove nel 1900 più della metà degli abitanti era polacca, persino i suoni – diceva il poeta Jozéf Wittlin – avevano un profumo e i nomi un odore esotico.
Martin Pollack ha delineato con profondo affetto i mille volti di quella provincia attraversata da contrasti e contraddizioni profonde, simbolo tuttavia di una creativa convivenza multietnica. Seguendo le suggestioni dei suoi scrittori è penetrato nell’anima di un paese che noi oggi riscopriamo attraverso un originale itinerario in cui sogno e realtà, fantasia e storia si alleano contro i silenzi del tempo.