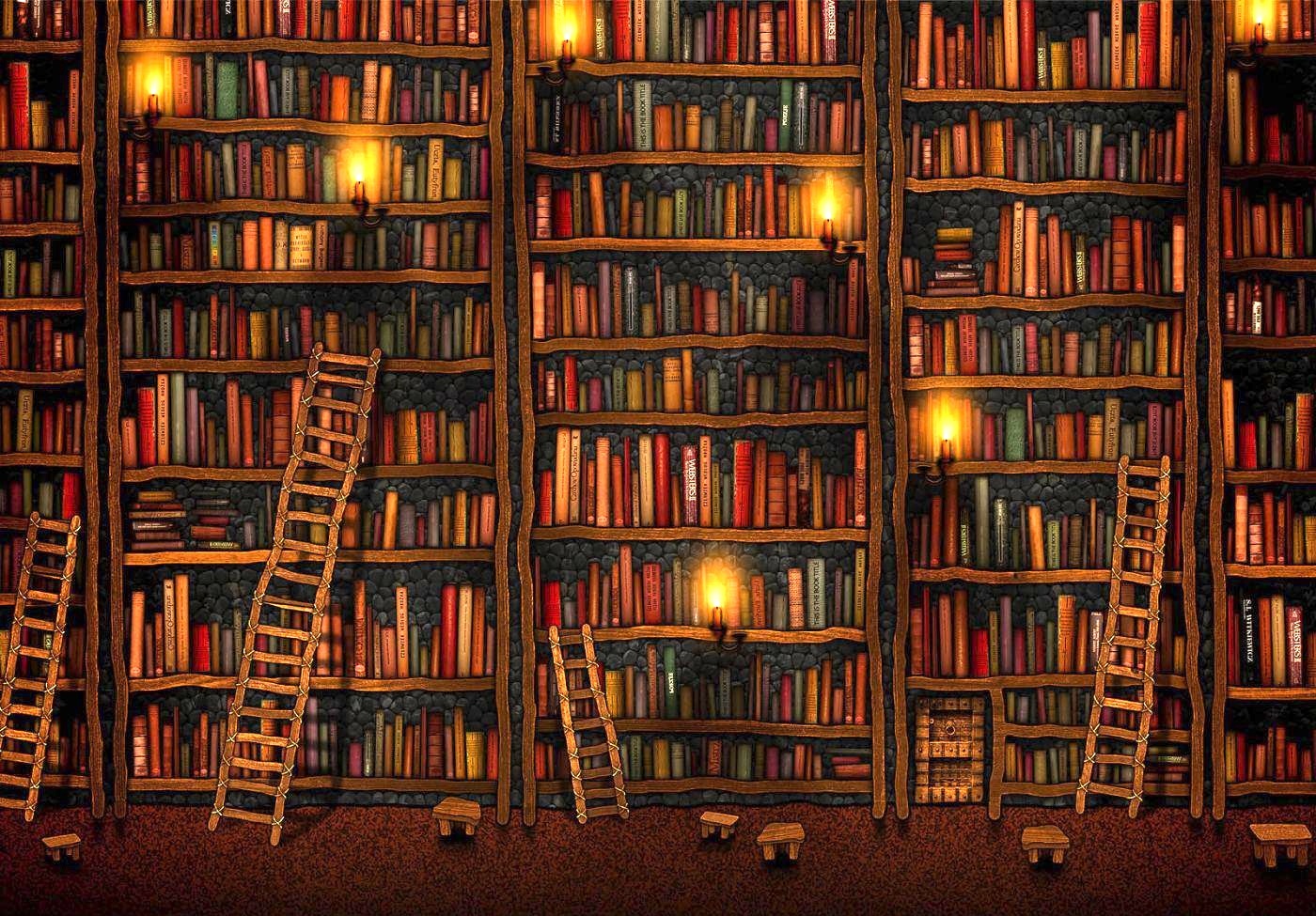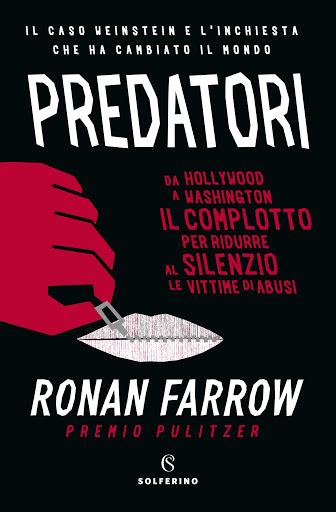Dalla fine del XVII secolo il destino del mondo si gioca in una vasta regione orientale. Dal Turkestan occidentale (le cinque repubbliche dell’ex Asia centrale sovietica) al Medio Oriente (Asia occidentale) un trend storico secolare è stato interrotto dagli USA. Vediamo come.
Tutto comincia, racconta Franco Cardini, quando l’Impero romano-germanico firma con gli Ottomani la pace di Karlowitz (1699). Nello stesso momento, la Russia comincia la sua marcia verso il Mar Nero, entrando in urto con il Sultano, e non con l’imperatore asburgico, che con la pace di Karlowitz ha rovesciato la tendenza dei secoli precedenti (gli ottomani, dalla caduta di Costantinopoli, 1453, puntavano su Vienna). Ed eccoci al 2011, quando le rivolte arabe raggiungono la Siria, che diventa il campo di battaglia tra gli imperi. La Gran Bretagna è stata rimpiazzata nella grande regione orientale dagli Stati Uniti, che guida una coalizione che include Francia, Regno Unito, Turchia, Israele e sunniti.
Dall’altra parte c’è Mosca, che assiste il governo regolare siriano, membro dell’ONU, ma bombardato un po’ da tutti senza mandato ONU. Schierandosi con Damasco, La Russia prosegue la secolare rivalità con l’ex impero ottomano. E alleandosi con gli Stati sciiti (Siria, Iran, Iraq) prosegue la sua amicizia con la Persia, considerata da sempre la naturale avversaria della Turchia.
Ereditando il ruolo di Londra, inizialmente anche Washington prosegue un’antica traiettoria storica. Per raggiungere i propri fini, la Gran Bretagna non aveva forse sobillato il sultano del Negev, capo politico della setta radicale sunnita wahhabita? Allo stesso modo, l’ISIS, apparso in Siria nel 2014, è stato sconfitto solo «quando non serviva più». Serviva agli Emirati sunniti e wahhabiti del Golfo, alleati degli USA e di Israele, per «portar avanti la loro offensiva antisciita e antiiraniana». Una vera e propria «archeologia del terrorismo», che spiega un filone storico inaugurato da Londra nel XVIII secolo.
Quindi finora le cose sono andate come sempre: la Russia, in marcia vero i mari caldi dal XVII secolo, è «naturalmente» ostile alla Turchia e amica dell’Iran (e quindi degli Stati sciiti: Iraq e Siria); Turchia, anglo-sassoni e Israele sono (dai tempi di Kemal Atatürk) grandi amici; sunniti e sciiti si odiano; l’estremismo religioso (ieri i wahhabiti, oggi l’ISIS) viene manipolato per ragioni politiche.
Poi succede qualcosa di straordinario, che scardina questo trend secolare. Secondo Franco Cardini, «si ha l’impressione che, magari contro tutte le regole della geopolitica, i guai combinati dalla diplomazia statunitense dall’11 settembre in poi siano riusciti a compier miracoli: dall’avvicinamento della Russia alla Cina a quello della Cina all’India, a quello tra Iraq e Iran, a quelli – storicamente paradossali – fra Turchia e Russia e fra Turchia e Iran, fino a svolte per la verità ancora difficili da valutare nella politica tradizionalmente filoamericana di paesi come il Qatar e il Pakistan».
In questo quadro manca un attore: quell’impero romano-germanico che avrebbe potuto reincarnarsi nell’Unione Europea, che resta purtroppo, scrive Franco Cardini, «disunita e non autorevole».