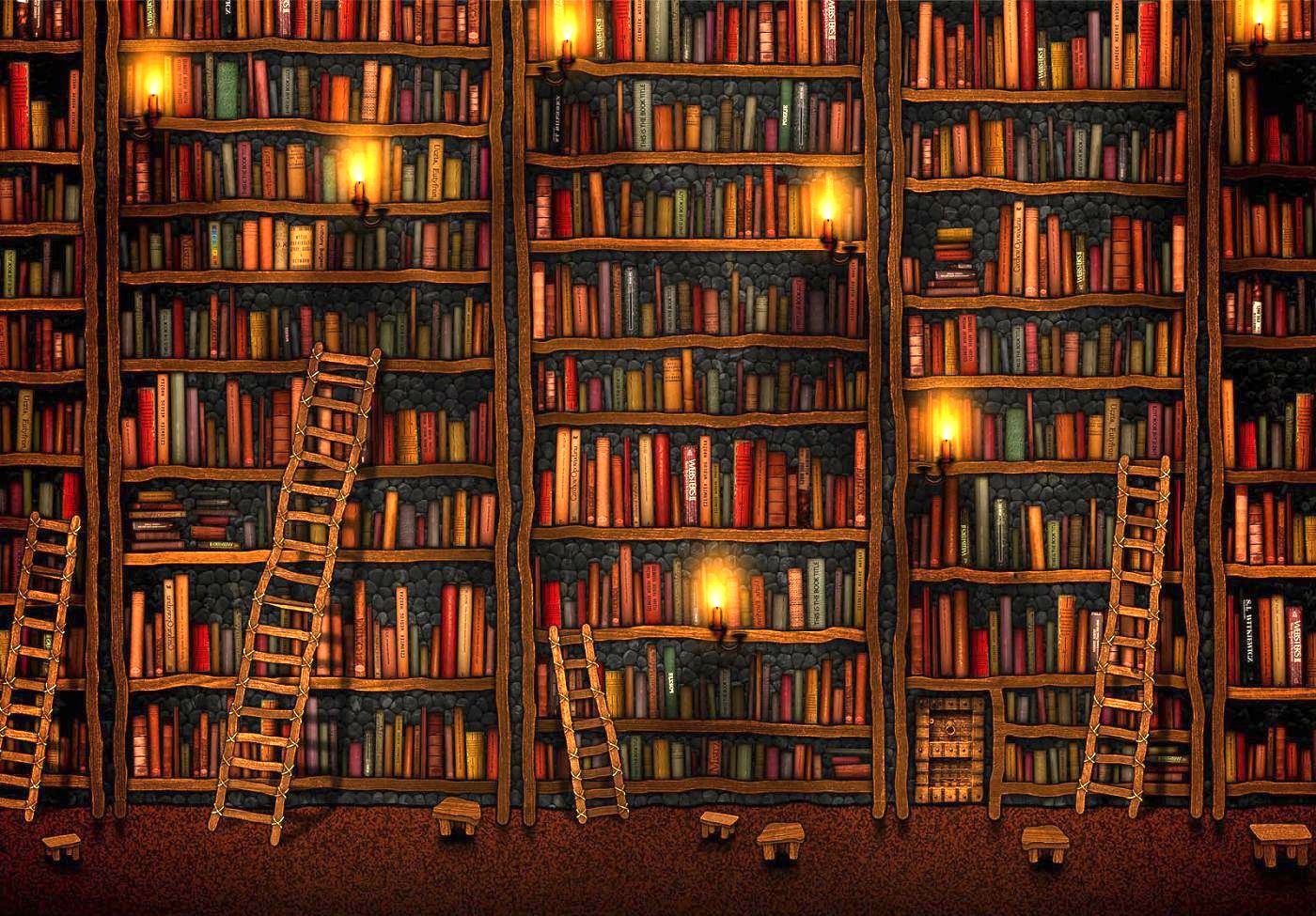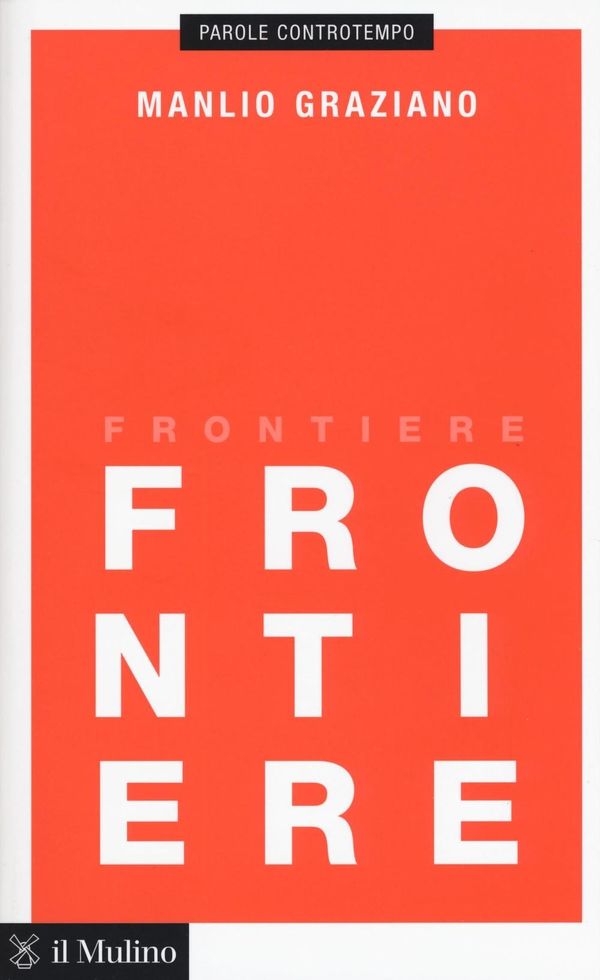Il muro col Messico è stato un punto centrale della campagna elettorale di Donald Trump, mentre la Brexit ha portato all’elaborazione di piani per un «Grande muro di Calais».
A cosa stiamo assistendo? A un prepotente ritorno della sovranità nazionale e del protezionismo, o all’illusione che la liberalizzazione dei mercati e la formazione di organismi sovranazionali per la sicurezza collettiva siano giunti al termine? L’Unione Europea non ha forse garantito la pace ad un continente sconvolto dalle guerre nazionali fin dal XVII secolo?
È proprio dal XVII secolo che bisogna partire, più precisamente dal congresso di Vestfalia del 1648, quando, scrive Manlio Graziani, «vengono gettate le basi concettuali e giuridiche della sovranità nazionale. Fu l’inizio del processo che porterà all’emergere dello Stato-nazione».
Punto fondamentale di Vestfalia è la fissazione «di un nuovo ordine politico-territoriale nel principio del cuius regio eius religio, che riconosceva al principe il diritto di imporre la propria religione ai sudditi, cioè il diritto di esercitare la propria autorità (politica, fiscale, giudiziaria e militare) sovrana ed esclusiva all’interno di una zona geografica data, senza interferenze da parte di altri Stati».
È la fine del Medioevo, caratterizzato dall’assenza di confini precisi, quando il vassallo era sottoposto a più autorità, i cui territori a volte si sovrapponevano; per esempio, il conte Zollern doveva fedeltà al re di Svezia, all’imperatore germanico e al papa.
Con Vestfalia, però, siamo alla formazione di Stati che non sono ideologici. Credo che la fase della formazione degli Stati-nazione ideologici arrivi con la rivoluzione francese del 1789, che non si accontenta più di esercitare la sovranità, ma pretende anche di assimilare tutte le minoranze etniche a beneficio della compatezza nazionale. Così sembra pensarla anche Graziani, che scrive: «in piena tempesta rivoluzionaria l’abbé Grégoire, deputato del terzo stato, presentò alla Convenzione un “rapporto sulla necessità e i mezzi per annientare i dialetti e universalizzare l’uso della lingua francese”».
Per Grégoire, l’omogeneizzazione linguistica era un mezzo per «fondere tutti i cittadini nella massa nazionale» e «creare un popolo».
Commenta Graziani: «Ancora un secolo più tardi, uno degli scopi della scuola primaria obbligatoria, laica e gratuita della Terza Repubblica fu d’imporre l’uso del francese a livello nazionale. Nel 1902, un decreto ministeriale proibì “l’uso abusivo del bretone”, con misure repressive che dureranno parecchi decenni e porteranno alla scomparsa virtuale di quella lingua».
Dal genocidio culturale si passa a quello biologico, che comincia con la Prima guerra mondiale nei Balcani, quando serbi e greci si spartiscono i macedoni, il cui eventuale rifiuto di farsi assimilare comporta «l’uccisione o l’espulsione».
Dice ancora Graziani: «Quanto accaduto alla Macedonia nel 1915, lo abbiamo visto in Polonia nel 1939, in Crimea nel 1944, nei Sudeti nel 1945, in India nel 1947, in Palestina nel 1948», eccetera.
Cosa succederà adesso? Ecco la condivisibile risposta dell’autore: «L’isolazionismo e l’autosufficienza non sono oggi più possibili perché ogni tipo di produzione è legato da mille fili al mercato mondiale, e spezzarne uno significa spezzarli tutti e rendere irrealizzabile ogni tipo di produzione».