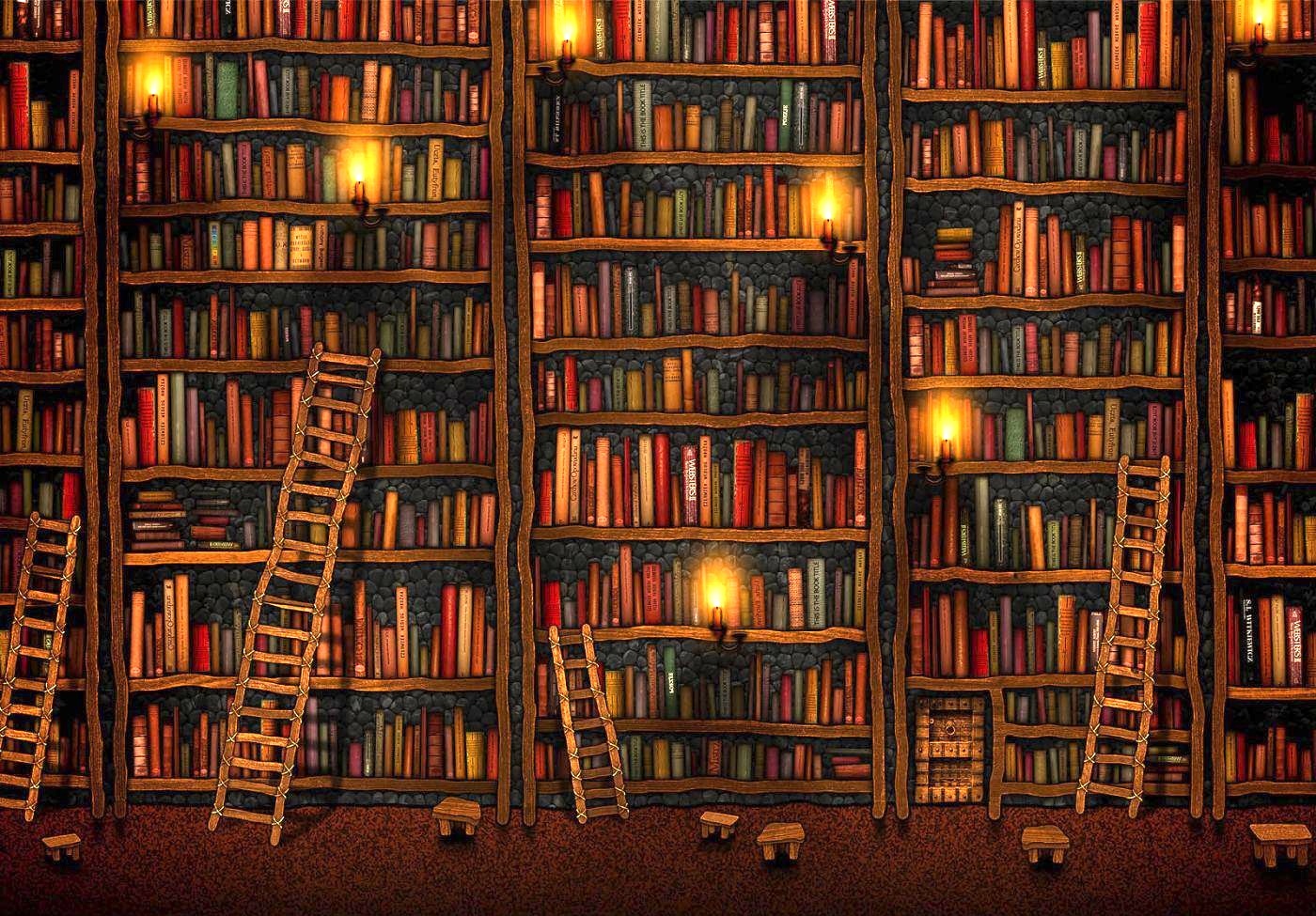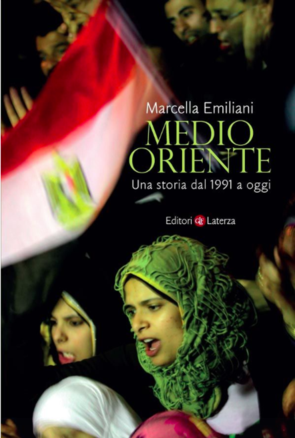Il 1991, la fine della Guerra fredda, è lo spartiacque tra due momenti storici precisi della storia del Medio Oriente, così come tra i due volumi di Marcella Emiliani.
All’indomani della Grande guerra, la rivoluzione turca e laicista di Kemal Atatürk abolisce il Sultanato e lo separa dal Califfato (finora un’unica autorità politico-religiosa), abolendo il velo, il fez e sancendo la vittoria della sovranità popolare su quella religiosa.
Il kemalismo, laico, nazionalista e modernizzatore diventa il modello statale di riferimento dei riformatori autoritari come Nasser, gli Scià dell’Iran e il partito panarabista Ba’th in Siria e Iraq (ma con gli Assad e Saddam Hussein il panarabismo finisce sotto il controllo di minoranze clanico-clientelari).
Un altro tipo di Stato che sorge dopo il 1918 è di natura diametralmente opposta: l’Arabia Saudita odierna è una monarchia assoluta, figlia del wahhabismo, forma radicale del sunnismo.
Una terza presenza è il sionismo laico e illuminista di Theodor Herzl, un ebreo assimilato che, nell’ottica ottocentesca, immagina la nascita di uno Stato nazionale ebraico. Comincia così, dal 1882, quella serie di migrazioni ebraiche che porteranno alla nascita di Israele (1948) e all’infinito conflitto etnico con gli autoctoni.
Questo conflitto è strettamente intrecciato con la Guerra fredda, soprattutto a partire dalla crisi di Suez del 1956, quando l’Egitto di Nasser, invaso da Israele, Francia e Gran Bretagna, ottiene l’appoggio dell’Urss.
Il modello laico, nazionalista e modernizzatore è sconfitto sui campi di battaglia della guerra arabo-israeliana del 1967 e dall’avvento nel 1979 della repubblica islamica in Iran (in guerra con l’Iraq del Ba’th, 1980-88). Il testimone della lotta contro Israele passa allora al fondamentalismo religioso (in Libano nel 1982 con Hezbollah, nato sotto l’influenza della rivoluzione iraniana e in seguito alle circostanze dell’invasione israeliana; nei Territori palestinesi nel 1987 con Hamas, sorto poco dopo la rivolta di quell’anno, e in competizione con il laico OLP di Arafat, di ispirazione nasseriana).
Il 1991 segna la fine della Guerra fredda (e l’inizio del secondo volume della professoressa Emiliani), con il crollo Urss, e il disegno di instaurare una pax americana mondiale, fondata su democrazia e libero mercato. Tutti i conflitti si sarebbero spenti, perfino in un’area problematica come il Medio Oriente, nella quale George Bush senior intervenne con l’operazione Desert Storm (prima guerra del Golfo, 1991).
Ma il disegno statunitense è predestinato al fallimento, a causa della persistente corruzione dei regimi locali (rivelatisi dopo il 1991 gattopardeschi e intenzionati a non rinunciare a un’oncia del proprio potere), che, tra clientelismo e corruzione, soffocano le economie dei propri paesi. La frustrazione e disillusione delle popolazioni è intercettata dall’Islam radicale, sviluppatosi anche come conseguenza dei regimi corrotti e autoritari. L’idea di uno Stato islamico precede il 1991, le moschee sembrano essere l’unico spazio dove dissentire dai governi in carica (inclusi paesi come l’Arabia Saudita dove la fonte di legittimazione è l’Islam). Fallite tutte le ricette, incluso il modello occidentale proposto dopo il 1991, si diffonde la percezione per cui il Medio Oriente debba trovare una propria via, rifacendosi alle proprie tradizioni, incluso l’Islam.
Due Stati islamici (monarchie teocratiche) già esistono: l’Arabia Saudita del wahhabismo e l’Iran dello sciismo. Entrambi i Paesi non sono in grado di esportare il proprio modello ma appoggiano organizzazioni islamiste radicali come Hezbollah (Libano) e i talebani (Afghanistan) che non hanno tuttavia seguito il modello di chi li ha sostenuti. Questo meccanismo provoca una destabilizzazione mondiale.
Altro nodo fondamentale è l’eterno conflitto arabo-israeliano, che si cerca di interrompere attraverso gli Accordi di Oslo del 13 settembre 1993, unico serio tentativo (tragicamente fallito) di dirimere la questione.
La situazione peggiora quando, l’11 settembre 2001, al-Qaeda, alleata con i talebani, distrugge le torri gemelle di New York, e la susseguente battaglia lanciata da George Bush junior sembra proporre «lo scontro delle civiltà» descritto da Samuel P. Huntington, con l’invasione dell’Afghanistan (operazione Enduring Freedom, 2001) e dell’Iraq (operazione Iraqi Freedom, 2003, seconda guerra del Golfo).
Nel 2011, mentre il fallimento delle due guerre lampo a basso costo statunitensi è chiaro, interviene un fatto nuovo: la «primavera araba», un’ondata di proteste che travolgono Tunisia, Egitto, Marocco, Giordania, monarchie del Golfo, Libia, Siria e Yemen. Il risultato sono anche «fratture regionali e tribali» (Libia), l’attuale conflitto in Siria e la richiesta palestinese (bocciata dagli Usa) all’Assemblea generale dell’Onu di ammettere tra gli Stati membri la Palestina, con i confini del 1967.
Tutto questo può dare un’idea della validità dei libri di Marcella Emiliani (da anni collaboratrice di «Azione»), strumenti imprescindibili per capire la storia e il presente del Medio Oriente.