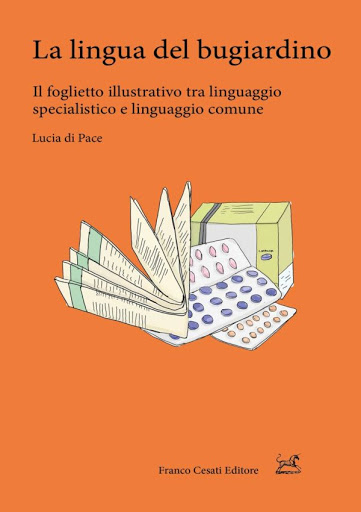Sembra che l’italiano sia l’unica lingua, nel contesto circostante, che ha una parola più rilassata e colloquiale per definire il foglietto illustrativo farmacologico. Che poi questa parola sia bugiardino, con quell’ingloriosa etimologia apparente, è un fatto critico, che si presta a interpretazioni che dal piano linguistico potrebbero rinviare a una ben più urgente realtà sociale. In altre parole, se è vero, come afferma Lucia di Pace in questo suo bel La lingua del bugiardino, che «nelle altre principali lingue europee non sono attestati termini alternativi a quelli corrispondenti a foglio illustrativo» e che «il “bugiardino” è solo italiano», allora questo fatto in apparenza solo linguistico potrebbe secondo alcuni dire molto sulla serietà con cui il milieu sociale tratta o considera un ambito cruciale per la nostra vita come quello della prescrizione dei medicinali.
Il linguaggio della medicina è terreno linguistico affollato; perché vi si incontrano le esigenze primarie del cittadino-paziente e quelle del codice di una scienza che non è come tutte le altre, perché consiste in un sapere che deve essere trasmesso e spiegato con un processo di divulgazione non scontato. Un medico non può accontentarsi di parlare per i colleghi e per il mondo della ricerca, e deve tenere viva una voce con il paziente, che è il più delle volte il suo interlocutore esemplare. Un po’ quello che accade per la lingua del diritto, che, nella sua dimensione quotidiana, «entra prepotentemente nella lingua di tutti i giorni»; una lingua che deve essere precisa e tecnica e insieme coinvolgere il profano.
Così è per il foglietto illustrativo, che vive la stessa tensione tra esigenza di precisione e completezza di qua e intento comunicativo e misura nelle informazioni fornite di là. In alcuni casi in gioco non ci sarebbe solo la garanzia di un passaggio «cognitivo» dell’informazione ma anche la discesa fino a un piano quasi affettivo, che renda più famigliare l’ente che prescrive il farmaco, sia esso il medico o l’azienda produttrice (sarà bene dire che di «piano affettivo» parla proprio qualche studio sul tema dell’Agenzia italiana del farmaco).
Il libro di Lucia di Pace ha molte pagine di descrizione degli sforzi anche legislativi che l’Italia e l’Europa hanno compiuto per stabilire norme che rendano leggibile e «onestamente rigoroso» il foglietto illustrativo, in nome di alcuni principi e suggerimenti primari e di buon senso. A partire dalle esigenze tipografiche (il corpo del testo, la sua strutturazione, addirittura le dimensioni del foglio), all’uso di formattazioni come il grassetto e il corsivo, alle questioni linguistiche riguardanti la frase e il lessico, all’opportunità di ponderare i tecnicismi di fronte ai toni più colloquiali. Un problema non da poco, cui si dedicano qui pagine su pagine, riguarda il destinatario del foglietto, che non è sempre univoco e puntualmente identificabile: esso si rivolge via via al medico, al farmacista, al paziente, tanto da disegnare ogni tanto un vero e proprio «equivoco del destinatario».
E, enfin, il significato etimologico di bugiardino, parola come visto solo italiana. Luca Serianni, che anni fa scrisse un bel libro sul linguaggio della medicina, sostiene con saggezza che «la motivazione dell’espressione bugiardino risiede non tanto nel fatto che il foglietto illustrativo menta, facendo illudere l’acquirente/paziente, quanto piuttosto nel suo essere poco chiaro e comprensibile». E per chiudere, nel capitolo sugli effetti indesiderati dell’assunzione di farmaci colpisce l’autrice (e noi) quanto poco rilievo riceva la circostanza di grado massimo, la morte, la cui evocazione non si guadagna mai una sottolineatura, un grassetto, un corpo più grande. E anzi spesso è affidata all’effetto obliquo di aggettivi che qualificano l’esito dell’abuso di farmaci: fatale, letale, mortale.