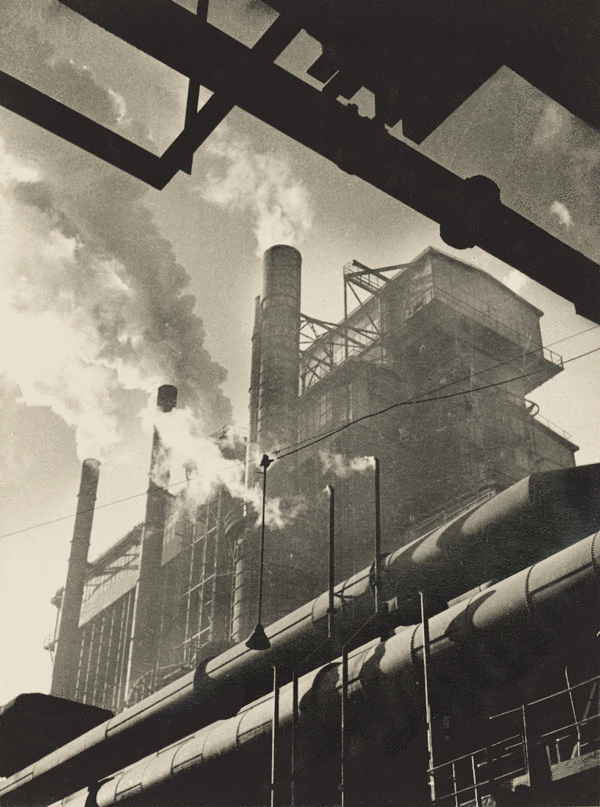Se, come è stato detto alla sua comparsa, la fotografia è l’occhio della modernità, le fabbriche – tema dell’attuale e quindicesima mostra alla Fondazione Rolla di Bruzella – non possono essere che il sancta-sanctorum di una certa epoca e idea dell’immagine, quella documentaria. Si tratta di edifici in cui si celebra la tecnica e in cui si delineano i contorni del futuro – di cui la fotografia vuole essere il linguaggio. Prendendo a prestito le parole che l’economista Christian Marazzi spende nello scritto che accompagna il catalogo, nell’Ottocento e Novecento la fabbrica è senza dubbio il luogo al centro di un processo capace di generare «valori sociali, politici, religiosi».
Da qui la loro onnipresenza nell’era della tendenza artistica denominata la «nuova oggettività» tedesca, i cui risultati maggiori si situano tra il 1920 e il 1940, quando l’industria nazionale era protagonista di una prepotente ascesa economica. A due dei massimi campioni di questo gruppo è dedicato giustamente molto spazio: il primo è il notissimo Albert Renger-Patzsch, mentre la seconda è colei alla quale la Fondazione ha contribuito alla riscoperta, Ruth Hallensleben. Altri autori tedeschi del periodo partecipano alla collettiva in Valle di Muggio: Werner Mantz, fotografo di Colonia al tempo di August Sander ma che dovette fuggire in Olanda a seguito delle leggi antiebraiche – qui con un’iconica immagine delle centrali elettriche presso il Limburgo – e Fritz Henle, fotogiornalista della rivista «Life» e chiamato il «mago della Rolleiflex», il quale nel secondo dopoguerra si naturalizzerà americano.
Assai legati alla Fondazione e alle sue esposizioni ritroviamo i due contemporanei Christof Klute e Vincenzo Castella: in entrambe le prove dei quali gli interni si presentano come quasi metafisici, accomunati dalla volontà di contenere la massima quantità di luce possibile. Per le prove che riguardano gli esterni, invece, con la consueta indagine attenta alla declinazione delle forme del modernismo architettonico, il locarnese Giuseppe Chietera trova alcuni esempi significativi anche in territorio ticinese.
Nella lista degli autori troviamo alcune nuove entrate, come il livornese Enrico Minasso, ma vi emerge il nome di un importante autore svizzero: il bernese Kurt Blum. Maestro – ben riconoscibile confrontando i risultati – di quel Balthasar Burkhard esposto recentemente al LAC, è presente con un’immagine tratta dal libro del 1959, L’immagine di una fabbrica. C’è spazio anche per l’approccio estetizzante con Tom Baril, uno degli stampatori di Robert Mapplethorpe, che presenta due lavori dall’assoluta pulizia formale, presentando volumi puri.
Concludono l’esposizione le generazioni più recenti che sembrano mettere in discussione la centralità della fabbrica nella società e nella cultura attuale, evitando di far trasparire un certo mito della stessa nella proposta: come il tedesco Oliver Boberg, già presente nelle importanti collezioni del MoMa di New York e al Guggenheim. Boberg riprende nei minimi dettagli quello che sembra essere un complesso industriale di oggi, isolato ed anonimo, ma che in realtà si rivela essere un modellino ritratto secondo attente modalità che lo fanno sembrare reale – una modalità di produzione dell’immagine simile a quella di un altro importante autore degli ultimi decenni, Thomas Demand.
Al tempo stesso, sodale con il suo coetaneo, Fabio Tasca decostruisce idealmente proprio la fabbrica Rolla a Stabio in un trittico la cui sequenza non corrisponde alla reale struttura dell’edificio, richiamando il fatto che non sempre la fotografia riproduce fedelmente la realtà.