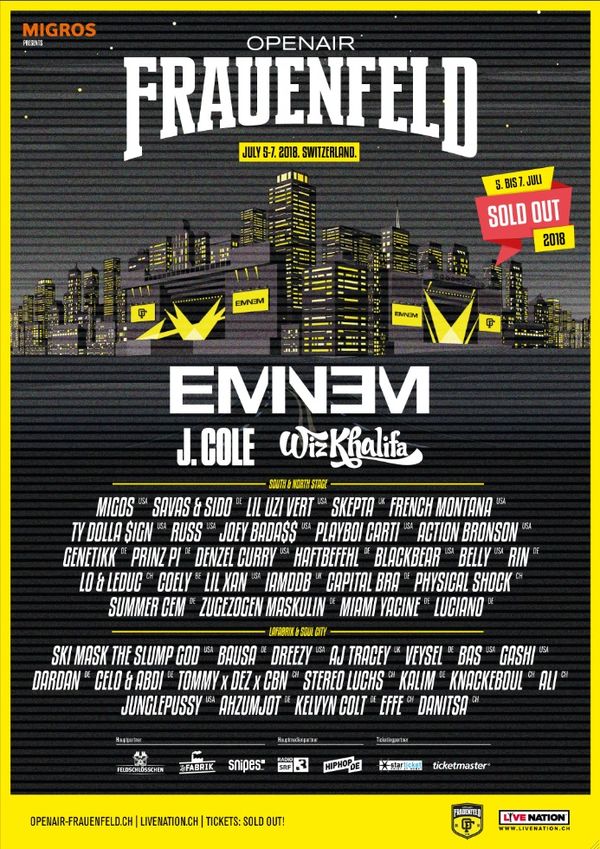Antica famiglia inglese, antenati scozzesi da parte di madre, educazione militaresca, scuole prestigiose e un collegio cattolico dove scopre il cinema italiano (con Fratello Sole e sorella Luna di Franco Zeffirelli) e la vocazione cinematografica; è questo il prologo dell’adolescenza turbolenta e della carriera folgorante e tempestosa, stile «montagne russe», di Rupert Everett, che abbiamo intervistato a Roma dove, nelle vesti dell’Inquisitore, sta girando il serial Il Nome della Rosa.
Barba lunga e i folti capelli brizzolati cortissimi, per esigenze cinematografiche, Rupert Everett deve questo ennesimo felice ritorno al suo talento di attore e a un personaggio inseguito a lungo: Oscar Wilde, quello dell’esilio e della morte, dal 1897 al 1900, al centro del film The Happy Prince. La pellicola, applaudita al Sundance e al Festival di Berlino, amata dalla critica e dal pubblico in sala, è stato anche il suo esordio come sceneggiatore e regista: «Oscar Wilde è stato una costante della mia vita: da bambino, la sua favola del Principe Felice, era la preferita di mia madre», ci ha raccontato Everett, «ma ho imparato a conoscerlo interpretando le sue commedie piene di humour e d’intelligenza; ora, al traguardo dei miei sessant’anni e, credo, alla fine della mia carriera, volevo dire la mia in quanto uomo di spettacolo gay, da sempre alle prese con l’industria dello show business. E la storia di Oscar Wilde mi ha ispirato, perché è emblematica e affascinante».
Il film The Happy Prince, è il sentimento di una somiglianza, un brillante, toccante e cinico omaggio a Oscar Wilde che placa i fantasmi personali del regista, anche se, ha affermato Everett: «a indurmi a lottare per questo film è stata la voglia di tornare al cinema con un personaggio magnifico, che sapevo avrei reso al meglio». Infatti ci ha messo dieci anni per scriverlo, sceneggiarlo, e trovare il budget per realizzarlo, e si è arreso a curarne la regia, pur di non farsi scippare il ruolo del protagonista.
Alto e atletico, il bel viso aristocratico invecchiato con fascino, e quell’espressione riottosa e malinconica dello sguardo che gli valse un alter ego come Dylan Dog, «l’indagatore dell’incubo» dei fumetti, icona di successo degli anni ‘90, Rupert Everett nel nostro incontro, ha giocato a nascondino con se stesso e la figura di Oscar Wilde: «L’ho amato perché, come il principe della favola, mentre gli portavano via tutte le scaglie d’oro e le cose preziose, mentre cadeva in pezzi, Wilde, in quegli anni, è stato anche felice, e fedele a se stesso sino alla fine, e lo vedo non come una vittima, piuttosto come una sorta di Cristo, per metà dio e per metà umano».
Il film inizia in una modesta pensione di Parigi, ma Oscar Wilde disteso sul letto non vede ciò che lo circonda, la mente sospesa tra il sogno e il delirio: i ricordi di quando era un autore di successo, adorato dalla buona società londinese si alternano con quelli degli incontri con l’amato Bosie, il superficiale Lord Alfred Douglas; con quelli dolorosi del processo, con il marchese di Queensberry, padre del suo amante, che, grazie al tradimento di Bosie, può umiliarlo e trascinarlo in prigione. Nelle immagini, gli applausi si mescolano agli sputi e agli insulti del popolino che lo vede in catene; lo tortura il pensiero di sua moglie Constance e dei suoi figli, che, a causa dello scandalo vivono nascosti; lo perseguita la certezza del talento perduto, quella sua celebrata vena poetica che sembra essersi disciolta nell’assenzio; fatta a brandelli dalla sifilide.
«Ho voluto girare tutta la storia intorno al letto di Wilde, seguendo le divagazioni del suo cervello», ci ha spiegato Everett, «che negli ultimi sprazzi di vita vaga tra i luoghi della sua esistenza portando gli spettatori con sé, come se fossero cari amici al pari di Reggie Turner, o Robbie Ross che al suo capezzale affettuosamente lo vegliano con conversazioni sentimentali, piene di humour, di pathos e di recriminazioni. Sono situazioni che conosco, dell’epoca in cui l’Aids non dava scampo, vissute al capezzale dei troppi amici perduti. I terribili anni ’80 della mia gioventù, in cui non si aveva modo di sapere il proprio destino. La sifilide fu altrettanto devastante in epoca vittoriana».
E poi c’è il capitolo del successo, afferrato e perduto, penoso per Wilde, come lo è stato varie volte per Rupert Everett: «Quando Wilde era una star e Londra era ai suoi piedi, lo vediamo orgoglioso, vanesio, egocentrico; non gl’importava di nient’altro. So per esperienza quanto sia disorientante quando tutto finisce, accorgersi che il riflettore che era acceso su di te, si è spento. Nel film quest’uomo imponente, quasi elefantiaco, si è trasformato in un beone trasandato e puzzolente, che porta con sé solo tracce della gloria passata», ha continuato Everett accalorandosi, «e, in una bettola, cerca di raccontare al tizio seduto accanto a lui un episodio della sua gloria passata: quando in America, acclamato da un gruppo di minatori, aveva accettato di farsi calare in miniera, in un secchio, per pranzare con loro in galleria. Sembrano vanterie di un alcolizzato e invece era accaduto davvero, durante il trionfale viaggio di Oscar Wilde in America. Devi avere i nervi saldi nello show business, ora come allora». Everett ha mostrato di averli, passando dal cinema, al teatro, alla letteratura, dando prova di un talento brillante e multiforme, grazie al quale, nei momenti difficili, si è più volte ripreso la scena: a Londra e a New York, anche con libri come: Bucce di Banana del 2007, raccolta di episodi di vita vissuta e riflessioni sui suoi amici illustri; o Anni svaniti del 2013, quasi un’autobiografia di eventi curiosi e avventure esistenziali.
E adesso, dopo la riuscita di The Happy Prince, si gode a Roma l’ennesima rinascita «Poi taglierò questa barba, per realizzare un film sulla Seconda Guerra Mondiale». Ci ha detto un entusiasta Rupert Everett salutandoci sorridente e impettito, svelando quella tempra militaresca, quella caparbietà guerriera ancestrale che gli ha salvato più volte la vita.