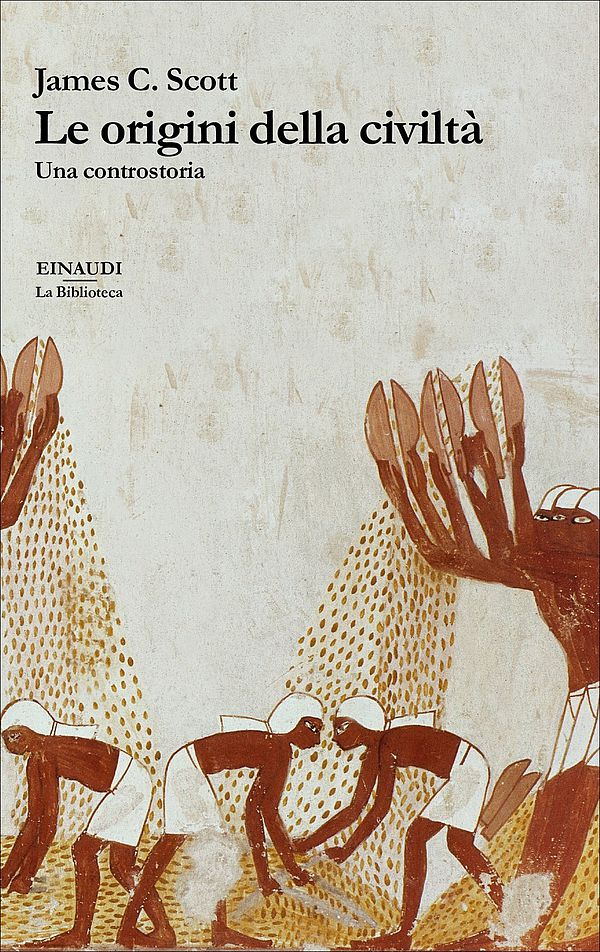Quando c’imbattiamo nel termine «civiltà» tendiamo a pensare a società organizzate in una forma che si avvicina quanto più possibile a quello che sappiamo essere uno Stato. Inoltre, ci viene in mente anche l’idea di «progresso», inteso come graduale passaggio da uno stato primitivo ad uno civilizzato. «Selvaggi» e «barbari» stanno di là dei confini dello Stato, oltre le mura della città, e il racconto della storia antica narra del progressivo incivilimento dell’umanità.
Se studiosi come Jared Diamond hanno cominciato ad indagare sulle ragioni per cui le civiltà scompaiono – rilevando quanto importanti siano fattori come le condizioni geografico-ambientali, i mutamenti climatici, lo sfruttamento eccessivo delle risorse da parte dell’uomo e l’eccessiva espansione demografica –, c’è anche chi comincia a chiedersi se, davvero, essere «barbari» sia meglio di essere «civili». È il caso del politologo e antropologo James C. Scott, che scrive: «perché rammaricarsi della “caduta” quando la situazione che descrive è il più delle volte la disgregazione di uno Stato complicato, fragile e generalmente oppressivo in frammenti più piccoli e decentralizzati?».
Le parole di Scott si leggono nel suo ultimo saggio pubblicato da Einaudi con il titolo: Le origini della civiltà. Una controstoria. Giovandosi degli esiti più aggiornati dell’archeologia, la «controstoria» di Scott documenta come, per la maggior parte della nostra recente esistenza sul pianeta, lo Stato è stata una forma eccezionale, episodica e caduca di organizzazione sociale. Sebbene egli riservi un più dettagliato esame al periodo compreso tra il VII e il II millennio a.C. (quando nacquero i primi Stati nella regione mesopotamica del basso corso del Tigri e dell’Eufrate), Scott prende in esame un ampio periodo storico che comincia dal 12’000 a.C., età alla quale risalgono le prime prove archeologiche sporadiche di stanzialità, fino al 2600 a.C., quando fu inventata la scrittura. Obiettivo della sua ricerca è stato quello di analizzare il motivo per cui – per un lungo periodo – l’uomo evitò la sedentarietà e l’agricoltura, sfruttando i vantaggi della sussistenza mobile.
Un argomento cui presta particolare attenzione è quello delle epidemie, delle malattie cioè che si diffondono là dove cresce la densità della popolazione. Una stima accurata calcola che la popolazione mondiale intorno al 10’000 a.C. ammontasse a circa 4 milioni di persone. Da circa un migliaio d’anni era iniziato il Neolitico e in alcune zone del Vicino Oriente già erano state domesticate alcune specie di piante, la cui coltivazione più estesa ed intensa incoraggiò l’abbandono della raccolta di piante selvatiche. Nello stesso periodo, furono domesticati la pecora, il maiale e il bue. Cinquemila anni dopo – età della quale abbiamo prove archeologiche evidenti di villaggi agricoli che dipendono da coltivazioni e bestiame – la popolazione mondiale era cresciuta di un solo milione. Viceversa, dopo altri cinquemila anni, la popolazione aumentò venti volte: «la transizione del Neolitico, lunga cinquemila anni, fu quindi una sorta di collo di bottiglia demografico.» È Scott a scrivere: «credo che le malattie epidemiche siano il silenzio più assordante nelle testimonianze archeologiche del Neolitico».
Quanto poco salutare – contrariamente al luogo comune – fu la domesticazione di piante e animali e lo stile di vita agropastorale rispetto allo stile dei cacciatori-raccoglitori lo si vede, per esempio, nell’insorgenza dell’anemia da carenza di ferro causate dalle prime diete a base di cerali: è documentata da inconfondibili segni nelle ossa. La vita sedentaria degli agricoltori lasciava inoltre altre tracce: «le donne di villaggi cerealicoli erano caratterizzate da dita dei piedi ricurve e ginocchia deformate in seguito a lunghe ore passate in ginocchio dondolando avanti e indietro nell’atto di macinare il grano». Nel Neolitico, uomini e donne che cominciarono a dedicarsi ad una vita stanziale, lontana dai gruppi di cacciatori-raccoglitori, si «auto-domesticarono», diventando più piccoli e più deboli. Mentre la narrazione sull’origine della civiltà sembra incoraggiare la convinzione che la nostra specie percorse una linea di progresso ininterrotto, le prove genetiche documentano che lo stile agropastorale fu pernicioso per la salute.
Come accadde, allora, che sorsero i primissimi Stati nelle valli del Tigri e dell’Eufrate intorno al 3100 a.C.? I primi Stati nacquero là dove si erano già formati aggregati urbani alla foce dell’Eufrate. Secondo James C. Scott, la teoria secondo la quale le prime comunità furono basate sull’agricoltura irrigua è sbagliata. Per lo studioso è vero invece che le prime e più ampie comunità stanziali fiorirono in prossimità delle terre umide, nella piana alluvionale meridionale della Mesopotamia. Descritto il sorgere dei primi Stati in corrispondenza di queste comunità sviluppatesi nelle ricche piane alluvionali, illustrato lo sviluppo di stratificazioni sociali che liberarono dal lavoro le élite ed i corpi guerrieri istituiti per la loro difesa, sottolineato il ruolo imprescindibile della schiavitù e della corvée per produrre il surplus necessario per il sostentamento di chi non doveva né lavorare, né adoperarsi per cercare cibo, ed esaminata la funzione dei cereali e in particolare del grano per rendere possibile il prelievo fiscale in virtù del quale le élite potevano conservare il potere – James C. Scott tratteggia anche la vita di coloro che stavano di là delle mura che cingevano le prime città-stato; una vita ancora nomade, libera, di uomini e donne che non erano costretti a produrre quanto imposto dalle autorità statali.
Lo Stato antico fu un’istituzione molto fragile. Quando uno Stato antico «cadeva», scomparivano le élite di alto livello, l’attività costruttiva su scala monumentale, l’uso della scrittura ad uso amministrativo e religioso; il commercio su larga scala si riduceva, così come la produzione artigianale per le classi dominanti. Se la tradizionale narrazione scolastica incoraggia a pensare che si trattava di un arretramento rispetto ad una cultura più civilizzata, Scott sostiene che non significava «necessariamente il declino della popolazione di quel territorio», e che in molti casi si trattava anzi di un miglioramento. La «controstoria» di James C. Scott è dunque una rivalutazione dei «tempi bui» succeduti al crollo di città-stato o di civiltà, e una valutazione positiva di tutta l’umanità che viveva, barbaricamente, ai margini della civiltà, libera da una subordinazione coatta ad una autorità.