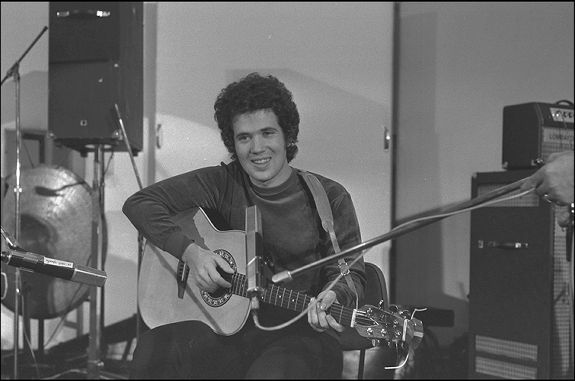«Siamo alle prese con una lingua che non amo, perché la devo cantare e non è semplice. L’italiano è del tutto inadatto a essere cantato. La nostra è una lingua senza tronche; il sogno di molti di noi sarebbe cantare in altre lingue e non è un caso che certe volte funzioni meglio il dialetto, che viene dalla strada, è più asciutto e comunicativo». Ha ragione Claudio Baglioni quando esprime tutto il disagio di chi, nell’intento di scrivere belle canzoni dal punto di vista musicale tenendo conto anche del valore testuale fa molta più fatica di un suo collega inglese o francese.
Questo L’italiano della canzone di Luca Zuliani, che insegna nell’Università di Padova ed è un esperto di metrica e musica nella poesia italiana, è subito prodigo di esempi d’autore; da Baglioni a De André, dal raffinato Guccini al più spiccio Ligabue («usare l’italiano in musica non è una sfida: è proprio una sfiga»), tutti sono d’accordo su un fatto: soprattutto, ma non solo, per la carenza in italiano di parole che portano l’accento sull’ultima sillaba, è difficile scrivere canzoni accettabili nella nostra lingua senza fare capo a qualche rimedio.
Prima di tutto, un passo indietro: ma non era, insomma, l’italiano una lingua musicale? Non è la nostra lingua riconosciuta da tutti come il codice del bel canto che ha esportato il melodramma in tutto il mondo con armonia e riconoscimento di eccellenza? Le cose non sono pacifiche, perché il testo in italiano parlato ha sì armonia e ritmo, ma per sue caratteristiche strutturali deve adattarsi alla musica selezionando parole musicabili e strutture sintattiche un po’ di compromesso; che lo rendono meno efficace e ogni tanto innaturale o ridicolo. Francesco De Gregori dice: «se leggi La donna cannone senza pensare alla musica, è una boiata pazzesca, non sta in piedi. Tutti quegli accenti tronchi, nemmeno un bambino scrive così».
Già: tutti quegli accenti sull’ultima sillaba («giuro che lo farò», «d’oro e d’argento diventerà»). È uno dei problemi affrontati da Zuliani, perché – come dice Fabrizio De Andrè – «scrivere canzoni in italiano è difficile perché le esigenze della metrica ti rendono necessaria una gran quantità di parole tronche», e le parole tronche italiane finiscono di regola in vocale e le vocali sono solo cinque.
Quindi: o si passa al dialetto come tanti, per nostalgia popolana o anche per risolvere questi problemi, o si comincia a ‘truccare’ il testo. Con i troncamenti (amor e fior); inventando accenti sull’ultima sillaba (come fa la gioiosa Arisa); spostando in fondo monosillabi e enjambando alla grande i versi come fa Lucio Battisti («Guardavo il mondo che/girava intorno a me»); finendo il verso con esclamazioni di una sillaba come fa Vasco Rossi («che se ne frega di tutto, sì»); abbondando di parole inglesi in fine verso come infine fa Celentano (la prima ottava di Il tuo bacio è come un rock ha sei versi che finiscono con monosillabi inglesi, uno fa solo «oh oh oh oh», uno finisce con «così»).
I testi delle canzoni italiane tirati di qua e di là con artifici non sempre accettabili per «far tornare il verso costi quel che costi» risultano indecorosi se privati di accompagnamento musicale, fanno ridere e ogni tanto quasi non vogliono dire nulla (che cosa significa «un mare nero un mare nero un mare ne»?); non sarà un caso che i booklets allegati ai dischi sempre meno portano la struttura in versi optando per il testo lineare.
Convitato di pietra di questo ritmato testo di Luca Zuliani è il rap, cui sono dedicate tre sole paginette prima delle Conclusioni. A fronte di tutte queste complicazioni, il rap è canzone senza musica o canzone «a tasso blando» di musica. Sembra un ossimoro impossibile, è un modo come gli altri per aggirare l’ormai conclamato problema dell’incantabilità della lingua.
Bibliografia
Luca Zuliani, L’italiano della canzone, Roma, Carocci editore, 2018.