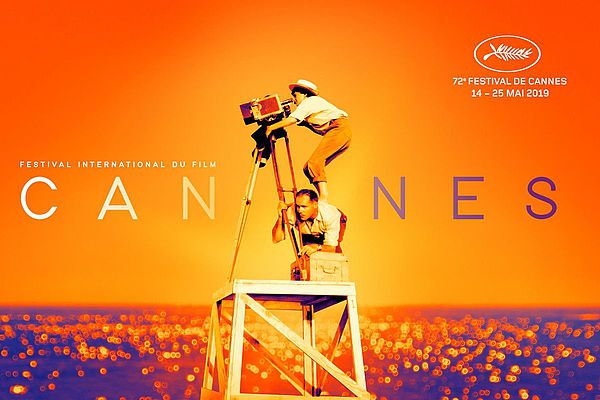Nelle pagine autobiografiche di Johann Wolfgang Goethe confluiscono non solo le esperienze e le riflessioni di un soggetto, ma l’intero mondo che lo circonda. Individuo e coscienza storica sono indissolubili, giacché si tratta «di rappresentare l’essere umano all’interno del suo tempo, com’egli riesca, a partire da esso, a farsi un’idea del mondo». Leggiamo queste parole nella premessa al suo splendido libro Dalla mia vita. Poesia e verità proposto dall’editore Einaudi nell’ottima versione di Enrico Ganni che ha curato anche l’ampio apparato di note e la scelta delle illustrazioni di pittori francofortesi dell’epoca a cui dedica un breve, interessante saggio.
Come suggerisce il titolo, il modo di pensare al passato e di ricostruire fatti e sensazioni non è solo legato alla memoria, ma anche al decorso del tempo, agli umori e al gioco dell’immaginazione, e dunque alla facoltà poetica. Certo Goethe percepì sempre di più, col passare degli anni, la sua storicità come testimoniano le opere autobiografiche, dal Viaggio in Italia alle Conversazioni con Johann-Peter Eckermann che lasciano imperituro ricordo di colui che fra gli artisti dell’epoca era già un dio in terra. Ma in Poesia e verità, elaborato a partire dal 1809 e concluso provvisoriamente nel 1831, lo scrittore guarda alle proprie origini ricostruendo in modo affettuoso e disinvolto gli anni dell’infanzia e della giovinezza, fino alla partenza per Weimar, a ventisei anni, nel novembre del 1775.
Fra gustosi aneddoti e sentenziose riflessioni spunta l’immagine di un biografo gigione e attore, specie quando l’autocontrollo viene meno e si sprigiona un’inesauribile energia giovanile. Il suo itinerario culturale si snoda fra letteratura, musica e teatro, arti figurative e scienze naturali, filosofia e religione, retorica e poesia, antichi e moderni. Scorre via un’epoca di eventi traumatici nelle sue pagine, ma al tempo stesso si spalanca una galleria di personaggi e figure illuminate: da Lessing a Klopstock, da Winckelmann a Kleist e Lavater, Lenz e Herder, per non parlare di Kant e dei filosofi antichi. È in quest’atmosfera che cresce il giovane Goethe, curioso e ricettivo, con una memoria prodigiosa e fin da ragazzo ineguagliabile nella retorica e nelle composizioni. Leggeva Ovidio e gli scrittori francesi, amava Shakespeare e il teatro in genere, conosceva lingue moderne, tra cui l’italiano, ed era un mago nel latino; studiava l’ebraico per poter leggere la Bibbia in originale, prendeva lezioni di musica, disegno, calligrafia. S’interessava alla pittura, e all’occorrenza sapeva pattinare, danzare e tirare di scherma.
Questo viaggio attraverso il mistero del genio nella vicenda quotidiana resta ancora oggi una lettura coinvolgente perché aperta alla curiosità verso il mondo, quello privato e familiare dello scrittore, ma soprattutto quello immenso della cultura e della storia del tempo. Goethe è una fonte inesauribile, inquieto e aperto alle esperienze più curiose, anche nella sua città, a Francoforte, dove scopre l’angustia e la sporcizia del ghetto ebraico, s’aggira nel mondo degli artigiani, si smarrisce nelle grandi sale del municipio, partecipa a cerimonie dal sapore antico come l’Udienza dei pifferai o, più grandicello, non disdegna di frequentare bettole con amici talvolta casuali e di godersi un giro sui barconi del fiume Meno.
Sulla pagina anche le esperienze più banali diventano racconto sanguigno e la memoria parla di un eterno presente in cui il giovane scandaglia la realtà in continua incalzante tensione. Studia in molte città il futuro avvocato: da Lipsia a Strasburgo, e altre frequenta per interesse artistico, come Dresda, attratto dalla pinacoteca con la Madonna Sistina di Raffaello, o Mannheim con la sua affascinante raccolta di antichità. E poi Wetzlar, dove fa nuove amicizie letterarie, e Darmstadt, in cui legge alcuni suoi lavori a un gruppo di persone assai colte, fra cui consiglieri segreti, ministri e professori.
Molte pagine di questo libro sono un proprio e vero resoconto della letteratura coeva, in cui si misurano simpatie e avversioni del suo autore – come nel caso dello Sturm und Drang –, il quale sogna per sé un futuro radioso con «l’affascinante forma della corona d’alloro intrecciata per ornare la testa del poeta». Stravede per Herder il giovane Goethe e mal sopporta la «partigiana disonestà» di Voltaire. Ci fa conoscere un Kleist che passeggiando va a caccia di immagini e un Lessing alla ricerca di qualche benefattore per soddisfare la sua vita di piaceri. Insomma, anche i grandi emergono attraverso il filtro della quotidianità e paiono più veri e umani. Allo stesso modo l’autore ci introduce fra i membri della sua famiglia e gli amori giovanili. A cominciare dal padre Johann Kaspar, dottore in legge e consigliere imperiale, figura centrale di quegli anni. Fu lui, natura ipocondriaca e dall’indole didascalica, il suo primo maestro; lui lo indirizza, non senza resistenze da parte di un figlio dalle «variegate eccentricità», alla giurisprudenza e lo stimola, a più riprese, ad andare in Italia, vista la quale – asseriva – «tutto il resto era scialbo». La madre con i suoi interessi religiosi resta un po’ sullo sfondo, mentre in primo piano risalta la sorella Cornelia con cui lo scrittore ebbe un profondo rapporto. Con lei condivide non pochi momenti di confusione e smarrimento e lo stupore al risveglio di istinti sensuali ammantati di bisogni spirituali. Era una donna non bella, ma di grande fascino umano e intellettuale, sempre accanto al fratello nei momenti di crisi sentimentale.
Sono molte le ragazze che turbano il giovane studente in quegli anni vivaci e turbolenti: da Gretchen a Friederike, da Charlotte Buff a Lili Schönemann, e le ritroveremo qua e là fra le sue poesie, perché l’amore, a cui questo libro riserva pagine deliziose, scopre la sua più alta espressione nel gesto poetico. Anche quando finisce in tragedia come nelle pagine del Werther scritto in quattro settimane e diventato da su-bito un libro cult oggetto di imitazioni e parodie. C’era l’intera cultura dell’epoca in quelle pagine spesso enfatiche ed esaltate: dal sentimento della natura e dell’amicizia all’interiorità pietistica e a una nuova idea di soggetto giovanile e borghese insofferente di vincoli e divieti. Il successo fu straordinario, come racconta Goethe che qui ricostruisce le condizioni psicologiche e umane in cui fu scritto il libro, ricordando la fonte della sua ispirazione: il reale suicidio per amore nel 1772 del giovane filosofo Jerusalem da lui conosciuto a Wetzlar. Quel libro fece del suo autore un idolo letterario mettendo in crisi un’idea di felicità garantita da virtù o ragione. Lui stesso conclude quella fase della propria vita racchiusa così felicemente in Poesia e verità separandosi dal suo grande amore Lili, che scopre di aver ormai perduta. Lo attende un futuro glorioso alla corte del duca Karl August di Weimar. E a chi cerca di trattenerlo ricorda le parole del protagonista del suo dramma Egmont: «I solari cavalli del tempo trascinano via con sé il lieve carro del nostro destino, e a noi non resta che tenere salde le briglie con di-gnitoso ardimento».