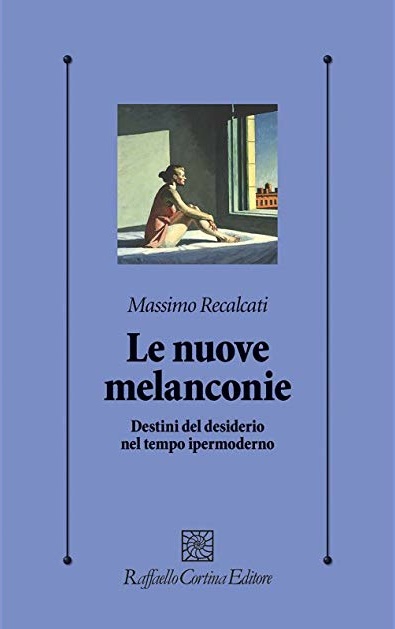Negli ultimi decenni, molti sono stati i cambiamenti che hanno ridefinito i nostri punti di riferimento culturali. La caduta del muro di Berlino e il conseguente tramonto del duello ideologico fra comunismo e capitalismo; la globalizzazione e la deregolamentazione dell’economia; l’avvento della società dell’informazione e della comunicazione, di Internet e delle nuove tecnologie che, bene o male, oggi ci portiamo tutti in tasca. Sull’onda di questo (presunto) boom tecnologico, abbiamo assistito anche al considerevole sviluppo dell’intelligenza artificiale, di biotecnologie di punta e, recentemente, all’entrata in scena di algoritmi capaci di anticipare e dirigere i nostri slanci consumistici.
Questa metamorfosi della sensibilità ha dato modo a una schiera di nuovi chiromanti del digitale di annunciare un futuro al di là di ogni previsione. D’altra parte, diverse voci autorevoli hanno sviluppato un discorso critico, basato non tanto sul progresso tecnologico, quanto piuttosto sulla consapevolezza dell’erosione di valori come la solidarietà, lo stato sociale, il lavoro, la privacy, e l’introspezione. In nome di una visione etica del genere umano, pensatori del calibro di Zygmunt Bauman (società liquida), Ulrich Beck (società del rischio) e Gilles Lipovetsky (ipermodernità), hanno svolto un sapiente lavoro di analisi, di critica, e di monitoraggio coscienzioso dei tempi attuali.
Sulla scia di questi illustri pensatori si inserisce, nel nostro contesto, anche lo psicanalista e filosofo italiano Massimo Recalcati. Un autore che negli anni ha prodotto saggi che, all’incrocio fra il collettivo e l’individuale, si interrogano sull’intreccio fra le tendenze socio-culturali figlie degli sconvolgimenti della globalizzazione, e i sintomi psicopatologici di cui gli individui contemporanei si fanno portatori.
Con Le nuove melanconie, l’ultimo suo saggio uscito di recente, Recalcati coglie l’occasione per aggiornare il suo sguardo, e per completare una riflessione che, se facciamo astrazione per i suoi lavori più divulgativi, ha preso avvio dall’analisi delle configurazioni anoressico-bulimiche descritte nella Clinica del vuoto (2002), ha attraversato le turbolenze esistenziali della ricerca spasmodica del piacere consumistico ne L’uomo senza inconscio (2010) per approdare, ora, ai disagi palesati dalle nuove forme della melanconia con, appunto, Le nuove melanconie (2019).
Sull’arco di circa vent’anni, quelli che intercorrono fra il primo e il terzo saggio, Recalcati sostiene che si sia passati dall’esperienza di un vuoto angosciante prodotto dall’imperativo di un piacere narcisistico costantemente rilanciato perché, in fondo, mai veramente soddisfatto, a un atteggiamento radicalmente opposto: un ripiegamento su sé stessi, un rifiuto di prendere parte alla vita attiva (si veda, su tutti, l’esempio degli hikikomori), un divorzio fra il sé e l’Altro; e, a livello politico, un atteggiamento reazionario che trova nel muro (in questo caso, l’esempio di Trump è il più lampante) il suo segno più eloquente.
Qual è quindi il nesso fra questo ripiegamento reazionario e la più comune definizione del termine melanconia? Come sosteneva Freud, da cui Recalcati riprende l’analisi, la melanconia risiede in un’incapacità cronica di elaborare il lutto simbolico nei confronti della perdita di un importante oggetto affettivo. Secondo Recalcati, il soggetto melanconico contemporaneo tende a trincerarsi in sé stesso; costruendo una barriera, un muro che lo separa dal mondo esterno. Ecco perché questo muro, trasformato in oggetto pulsionale, in àncora patologica, diventa l’emblema della nuova condizione del soggetto e della collettività che, avversi all’eterogeneità della vita e al commercio simbolico con l’Altro, sono inesorabilmente condannati allo scacco della pulsione di morte.
Dagli slanci reiterati di un turboconsumatore (il termine è di Lipovetsky) assuefatto alla continua ricerca di stimoli in un mondo di piaceri estemporanei, si è dunque passati alla cristallizzazione del segno opposto: chiusura, isolamento, rifiuto e, in ultima analisi, pulsione di morte. Esisterebbe, quindi, un’alternanza fra la spinta consumistica del libero mercato e il ritiro autistico e mortifero insito nel rifiuto di aprirsi alla vita e all’Altro.
Chi segue Recalcati da qualche anno, avrà certo notato l’impasto di innovazione e continuità che fa da sfondo al suo percorso autoriale. A chi invece è abituato soprattutto all’immagine mediatica dello psicanalista, ma volesse comunque avventurarsi nella lettura del suo ultimo saggio, diciamo di munirsi di pazienza, consci che il testo è impegnativo dal punto di vista teorico e concettuale. Ma, in un caso come nell’altro, c’è sempre l’allettante prospettiva di una ricompensa per aver intravisto, lungo pagine fitte che riconducono Freud e Lacan alle problematiche dei giorni nostri, un barlume di saggezza. Perché, come direbbero i poeti, il barlume rimane, oggi come ieri, l’unica forma di saggezza veramente possibile.