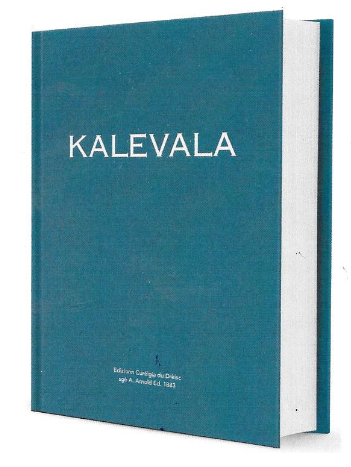Chi ama sentir raccontare le imprese grandiose e folli, come quella di chi ha voluto un giorno costruire un teatro dell’opera in mezzo alla giungla, allora non resterà indifferente a questa: Walter Arnold, leventinese d’origine, ha trascorso gli ultimi 14 anni a tradurre il Kalevala nella «parlata di Airolo e dintorni». Ventimila ore di lavoro per 22’795 versi (rii puétic secondo le parole dell’autore) che ora si trovano racchiusi in una bella edizione della casa di pubblicazioni Curéigia du Drèisc.
Il 2 dicembre scorso, nella splendida sala col camino dell’Hotel Des Alpes, si è svolta la presentazione del volume di quasi 700 pagine, davanti a un pubblico prevalentemente locale, venuto per capire chi era questo avventuriero traduttore, cosa lo aveva spinto a scavare nelle radici linguistiche e se era «sufficientemente airolese» per permettersi un’azione del genere. Diciamo subito che Walter Arnold, figlio di una leventinese di Osco, ha passato il test: è vero, non ha vissuto molto a lungo ad Airolo («Andavo a scuola a Lugano, ma la vita l’ho imparata qui, d’estate dai nonni, fino ai 17 anni»), però la sua conoscenza della lingua locale è infinitamente precisa e vasta. Molto più di tanti airolesi di oggi, che ascoltando e leggendo Walter Arnold (o altri emigranti che conservano la parlata di una volta) riscoprono parole che non ricordavano più.
Per tradurre il grandioso poema finnico ha dovuto imparare il finlandese antico e cercare le traduzioni ad Airolo, in Valle Bedretto, nei paesi arroccati sulle montagne dell’Alta Leventina. Per esempio per sapere i nomi dei differenti pezzi della slitta, confrontava parole di Nante, di Villa, di Quinto, di Ronco sopra Bedretto e sceglieva, a seconda della metrica, della musica, del suono che gli serviva di più. E quando proprio la parola giusta non c’era da nessuna parte, allora inventava, magari andando a pescare in altre lingue.
Walter Arnold ha trascorso la maggior parte della sua vita in Finlandia; ha lasciato il Ticino per finire il liceo negli Stati Uniti, dove ha studiato filosofia, scultura, storia, storia del Cinema. Quando ha preso la nave per tornare in Svizzera (una cinquantina di anni fa) ha conosciuto un gruppo di americani che seguivano un corso di finlandese. «Mi sono aggregato e al momento di sbarcare in Europa ho deciso che avrei tentato un soggiorno in Finlandia. Mi sono iscritto all’università e ho studiato filosofia e psicologia. Sono diventato insegnante di psicoterapia e ultimamente ho lavorato anche come istruttore di tennis; prima sono anche stato danzatore di danza moderna. Ora vivo lì con i miei figli; con loro parlo un dialetto diciamo “della ferrovia”, perché la lingua non è solo cultura, ma anche funzionalità», racconta. «Quando sei lontano, le “cose di casa” diventano più preziose. Mi mancava la mia lingua, volevo usarla e onorarla. Dopo 45 anni trascorsi in Finlandia, mi è venuto naturale occuparmi della storia di quel paese e poi il Kalevala è una raccolta di leggende sulla creazione dell’identità finnica e vi si trovano i nostri stessi paesaggi, gli strumenti di lavoro, le gradazioni della neve, i fiori, i mirtilli e boschi simili; ci sono i laghetti con i pesci e le paludi di montagna, le donne dal carattere forte come da noi e alcuni arnesi da lavoro identici; la stüva riscaldata con la pigna, la caccia e molto altro».
E poi il mondo è paese e le leggende si ritrovano con elementi simili dall’Egitto alla Papuasia all’Europa, come ha fatto notare il poeta di Lurengo Alberto Jelmini durante la presentazione. Perché ci sono storie che durano qualche anno e altre che si raccontano per secoli e queste sono quelle che toccano la profonda essenza universale dell’umanità.
Ad Airolo Arnold ha letto alcuni brani in traduzione e ha fatto ascoltare una registrazione della lettura in lingua originale del Kalevala: sia l’una sia l’altra sembrano musica e infatti sono versi che un tempo venivano cantati. «Il dialetto per me è una lingua senza esercito e senza flotta, ma molto più potente».