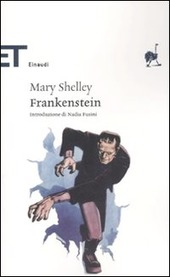Edgar Allan Poe teorizza nella Lettera rubata che il modo migliore per nascondere qualcosa è lasciarla sotto gli occhi di tutti. Verissimo. Siamo così impegnati a riscoprire scrittrici e artiste minori, relegate nell’ombra dal predominio maschile, che quando una donna – giovanissima e geniale – plasma il nostro immaginario, tendiamo a dimenticarla.
Mary Shelley non aveva compiuto 20 anni quando scrisse Frankenstein, o il moderno Prometeo, pubblicato due secoli fa (l’antico Prometeo aveva rubato il fuoco agli dei per regalarlo agli umani). Le celebrazioni danno più spazio alla creatura senza nome (Frankenstein è lo scienziato che vuole imitare Dio dando la vita) che a lei. Si parla della scrittrice più che altro per via del padre, il filosofo britannico William Godwin. E della madre, la suffragetta Mary Wollstonecraft, che rivendicava i diritti delle donne in un saggio del 1792. E del marito, il poeta Percy Bysshe Shelley, annegato al largo di La Spezia (ribattezzato Golfo dei Poeti). E infine dell’amante Lord Byron – anche lui poeta, da molti considerato il modello per la creatura: è difficile che una fanciulla abbia fabbricato l’incubo più spaventoso e affascinante della modernità.
Nell’intricata genealogia entra Ada Byron Lovelace, che quando i computer ancora non esistevano aveva le idee piuttosto chiare sulla futura diavoleria. Era figlia di Lord Byron, perché si tenesse lontana dalla poesia considerata la rovina della famiglia, le fecero studiare la matematica. La sua storia è in una bellissima graphic novel di Sydney Padua intitolata The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage: The (Mostly) True Story of the First Computer (Pantheon Graphic Novels, mai tradotta in italiano). È in libreria invece (edizioni Castoro) Mary e il mostro, scritto in versi e disegnato da Lita Judge. La tesi: la scrittrice palpitava per la creatura, non per le disgrazie del creatore (come si potrebbe pensare di chi scrivendo dà vita ai suoi personaggi; sicuramente con meno danni, ma con ugual delirio di onnipotenza).
Mary Shelley ha inventato uno dei personaggi centrali della modernità. Non solo dell’orrore: le rivisitazioni e le varianti sono innumerevoli, per non parlare delle interpretazioni. Jill Lepore sul «New Yorker» ricorda che la creatura somiglia a uno schiavo. Come il vero schiavo – poi politico abolizionista – Frederich Douglass racconterà nelle sue memorie, comincia la propria educazione di straforo. L’uno ascoltando il vicino di casa cieco, l’altro le lezioni impartite ai ragazzini bianchi.
Lo ha fatto sfornando un figlio dopo l’altro, qualcuno morto pochi giorni dopo la nascita e quindi ancora senza nome – sul diario li chiamava «baby». La stessa accusa che la creatura rivolgerà al suo creatore: «Non mi hai neppure dato un nome». Privandolo di un riconoscimento e avviandolo a un destino di infelicità. In un’altra disputa, chiede a Victor Frankenstein «rendimi felice». Le altre scrittrici dell’ottocento erano piuttosto del genere solitario, basta pensare alle sorelle Bronte o a Jane Austen. La tradizione continua fino a Emily Dickinson, sempre chiusa nella sua stanzetta di Amherst con addosso abiti candidi. Verrà interrotta da Virginia Woolf – nata Stephen, Woolf era il marito Leonard. Da allora le rivendicazioni femminili avranno per tema «una stanza tutta per sé».
Sulla prima edizione del romanzo non c’era il nome di Mary Shelley (temeva le avrebbero tolto la custodia dei figli). La gestazione durò diciotto mesi. Era cominciata nel 1816, a villa Diodati sul lago di Ginevra. Il tempo era brutto, la compagnia decise un singolare gioco di società: scrivere un racconto dell’orrore. Quella notte nacque anche «Il vampiro», nel racconto di John Polidori, medico di Lord Byron (Ken Russell l’ha ricostruita nel suo film Gothic). Se vi chiedete perché a metà giugno il tempo era orribile, sappiate che il 1816 è «l’anno senza estate». Le ceneri eruttate dal vulcano Tambora, in Indonesia, velarono i sole portando oltre ai temporali la carestia.
Il cinema ha fatto la sua parte. Dal Frankenstein che James Whale girò nel 1931, la creatura ha il volto (sotto il trucco squadrato) e i morsetti al collo di Boris Karloff. Ha perso la sua favella, la sua cultura, i suoi interrogativi filosofici. Ha guadagnato innumerevoli parodie, segno che davvero ha toccato il nostro immaginario. Dal mitico Frankenstein Junior di Mel Brooks al meno conosciuto Frankenweenie di Tim Burton: il cane di casa Sparky, finito sotto una macchina, viene risuscitato con un fulmine. Davvero un bel colpo, signora Shelley.