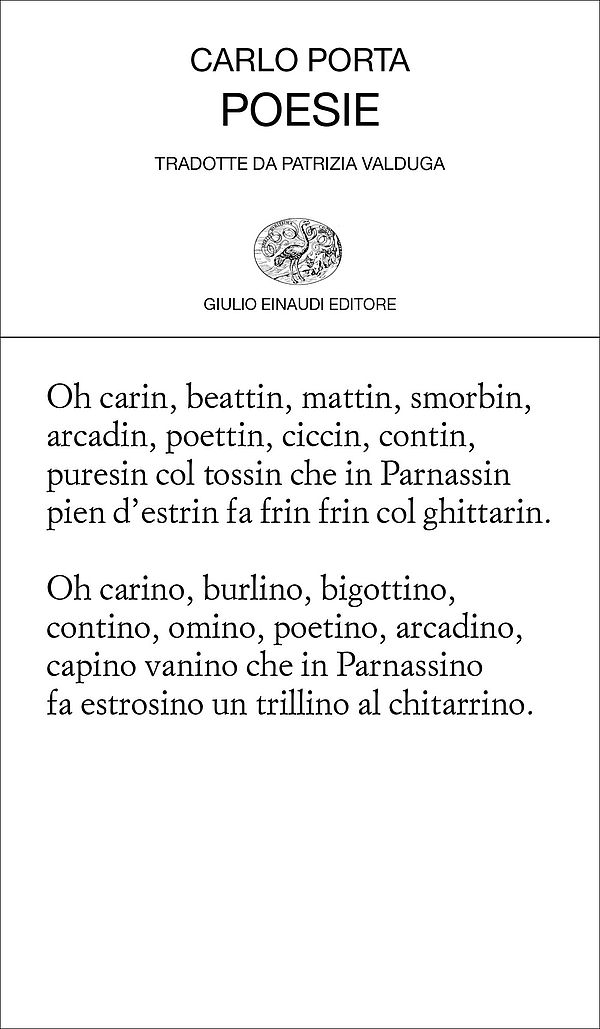Per un singolare errore di prospettiva, dato dalla costante leggibilità della sua lingua poetica, la tradizione letteraria italiana si è spesso vantata di un fenomeno sconosciuto alla maggior parte delle lingue europee: gli inglesi di oggi non sono in grado di leggere Chaucer senza l’ausilio di traduzioni, i francesi non capiscono più la Chanson de Roland, mentre gli italofoni entrano quasi senza problemi, con qualche nota esplicativa, nell’universo linguistico di Petrarca, Ariosto, Tasso, per non dire degli autori dei secoli successivi. L’impressione di una lingua «viva», che evolve nel tempo pur restando sempre la stessa, una lingua che si parla come si scrive, è naturalmente un abbaglio, almeno fino al pieno Novecento.
«Dimmi come parli e ti dirò come scrivi» è un motto che non funziona nemmeno per l’italiano, se è vero che Manzoni non usò mai, nella quotidianità, la lingua dei Promessi sposi, preferendogli il francese e, soprattutto, il dialetto lombardo. Per capire come parlava Manzoni, e con lui come avrebbero parlato realmente Renzo, Lucia e gli altri personaggi del romanzo, sarebbe utile semmai sfogliare i testi di Carlo Porta, quelli sì veri documenti linguistici del primo Ottocento, nonostante la grande perizia tecnica e la vasta cultura letteraria del suo autore: «El sarà vera fors quell ch’el dis lu / che Milan l’è on paes che mett ingossa…».
Su questo funzionario meneghino dell’alta borghesia, nato nel 1775 e morto nel 1821, capace di produrre migliaia di endecasillabi distribuiti in ottave, terzine, sonetti, per una produzione quasi tutta postuma, disponiamo oggi di uno strumento di conoscenza al contempo innovativo e ambizioso. La nuova antologia curata da Patrizia Valduga, che traduce Porta rispettando le rime e le cadenze metriche, è infatti un pezzo imprescindibile nel kit del collezionista di cose portiane, da appoggiare sullo scaffale di fianco al Meridiano di Dante Isella e all’Oscar Mondadori di Massimo Migliorati e Pietro Gibellini. Con questa triade di titoli, la degustazione di questo raffinatissimo poeta altrimenti inaccessibile è garantita a priori.
Patrizia Valduga aveva dalla sua non solo le capacità tecniche necessarie all’impresa (è tra le maggiori voci della cosiddetta metrica tradizionale) ma anche una sensibilità accesa per tutto quanto riguardi corporeità ed erotismo, forse la principale chiave di lettura della sua stessa produzione in versi. Di più, si è accinta alla traduzione di Porta seguendo un consiglio implicito di Giovanni Raboni, di cui è stata compagna per molti anni, con l’obiettivo dichiarato di rispondere a un timore già espresso da Dossi nelle sue Note azzurre: «Vorrei evitare ai futuri milanesi la disgrazia di non poter più comprendere e gustare Carlo Porta».
Attorno ai due poli del «comprendere» e del «gustare», forse meno il primo del secondo, ha ruotato il suo lavoro di selezione, in cui non mancano capolavori come i Desgrazzi de Giovannin Bongee, l’interminabile Lament del marchionn di gamb avert o La Ninetta del Verzee, voltati dall’autrice in un italiano di oggi fuso dentro il calco metrico dell’originale: «Poi pensandoci su / riprende… conviene che li perdoni: / si sa, dal più al meno, la servitù / è tutto un canagliume di imbroglioni» («Infin pensandegh sù / el repia… Conven che ghe perdona: / se sa che dal pù al men la servitù / già l’è tutta canaja bozzarona»).
Inevitabilmente, nei passaggi da una lingua all’altra, qualcosa resta per strada e qualcosa a volte è di troppo (minime zeppe che garantiscono il rispetto dell’endecasillabo) ma sarebbe stato difficile fare di meglio. Ottimo ad esempio l’attacco di Sissignor, sur Marches: «Lei è marchese, sì, signor Marchese, / marchese, marchesotto, marchesone; / io sono il signor Carlo milanese, / e basta, senza briciola di Don», in cui era forse impossibile salvare il gioco paronomastico dell’ultimo verso («senza nanch on strasc d’on Don»). Meno convincente, qui e là, il ricorso a parole scurrili, anche per quell’atmosfera ironica e attutita del dialetto, in cui una «cojonada» non equivale del tutto a una «cazzata», fosse pure per una mera questione di suoni.
Nel complesso si tratta comunque di un’operazione magistrale, da ascriversi pienamente sia alla fortuna critica di Porta che alla produzione letteraria della Valduga: qualcosa di simile al Musicante di Saint-Merry di Sereni o all’Hölderlin di Gianfranco Contini, non per nulla due titoli della medesima collana bianca di Einaudi.