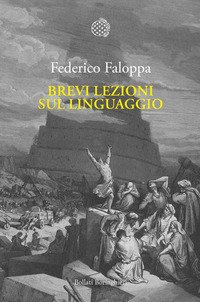«Koshik era un elefante capace di riprodurre – a detta di alcuni testimoni – non solo alcune parole in coreano inserendo la proboscide in bocca e modulando vari suoni nel tratto vocale, ma anche di imitare il timbro e la frequenza della voce del suo allenatore, come documentato da Angela Stoeger-Horwath dell’Università di Vienna».
Per un linguista, studiare il linguaggio degli animali ha fondamentalmente due scopi: il primo è divertirsi, perché le storie dell’elefante che parla coreano o del pappagallo Alex che poteva dire una dozzina di parole inglesi e poteva riconoscere oggetti e colori sono decisamente storie divertenti, oltre che interessanti; come è interessante la nota propensione di certi uccelli che crescono lontano dai genitori a emettere canti diversi da quelli di famiglia, generalmente coincidenti con quelli dei loro fratelli di adozione, tanto da identificare in questi sistemi dei veri e propri dialetti aviari.
Ma indagare le forme di comunicazione di diverse specie animali ha anche un altro senso, ben più ambizioso sul piano scientifico: serve a dire quanto questi sistemi si posizionino per difetto nei confronti della facoltà di linguaggio dell’uomo, o quanta strada debbano ancora fare generazioni di elefanti, pappagalli e scimmie per arrivare a lambire anche solo un minimo della competenza linguistica del più tamberlo degli umani.
Di problemi di questo tipo, generando grande profitto e spasso nel lettore, si occupa l’ultimo libro di Federico Faloppa, Brevi lezioni sul linguaggio. Faloppa insegna nell’Università di Reading. Chi si interessi un po’ della materia lo conosce soprattutto per ben determinate specializzazioni nell’ambito della sociolinguistica. Dice giustamente Faloppa che «da alcuni anni la mia ricerca si concentra soprattutto su linguaggio e alterità, linguaggio e razzismo, migrazioni e linguaggi»; e infatti in quei campi i più attenti ricordano opere certamente di prim’ordine.
A fronte di quei temi, però (temi che peraltro, in Italia, risultano perfettamente in linea con la tradizione, perché chi si occupi di linguistica in Italia in questi anni si occupa prevalentemente di sociolinguistica), le Lezioni di quest’ultimo libro sono indicative di una tendenza che sembra stagliarsi sempre più nitidamente nell’ambito degli studi linguistici. I quali, pare di poter dire, si stanno allontanando un po’ dalle indagini sulle lingue per abbracciare sempre più volentieri lo studio della lingua, del linguaggio, inteso appunto come competenza e capacità generale del genere umano. Da qui, la comunicazione degli animali; le tematiche del rapporto tra fisiologia del cervello e produzione linguistica (con tutta la questione delle patologie del linguaggio); l’origine del linguaggio; gli incroci di grande fascino con paleontologia, etologia, anatomia e antropologia. Tutta materia molto à la page, della quale il libro di Faloppa abbonda decisamente.
Il rinvio è ad alcune parti vistose nella serie dei capitoli: tra i molti esempi che si potrebbero fare, certamente le quattro ipotesi sul perché a un certo punto il genere umano abbia cominciato, enorme tempo fa, a parlare; le afasie dei poliglotti, che possono essere parallele e riguardare tutte le lingue conosciute dal parlante prima, selettive e interessarne solo alcune, differenziali e incidere sui sistemi pregressi a livelli variabili, in antagonismo alternato cioè a seconda dei periodi; lo sciagurato linguaggio dei bambini che, nella storia, sono stati fatti crescere in isolamento; la capacità dei neonati di distinguere precocemente le consonanti, anche quelle che non appartengono alla lingua che impareranno. Sorprende poi, per prospettive e visione, l’ultimissima lezione, «All’inizio era il gesto?». Vale nel modo più assoluto il «prezzo del biglietto». Il passo della lettura, infine, è fuori discussione.