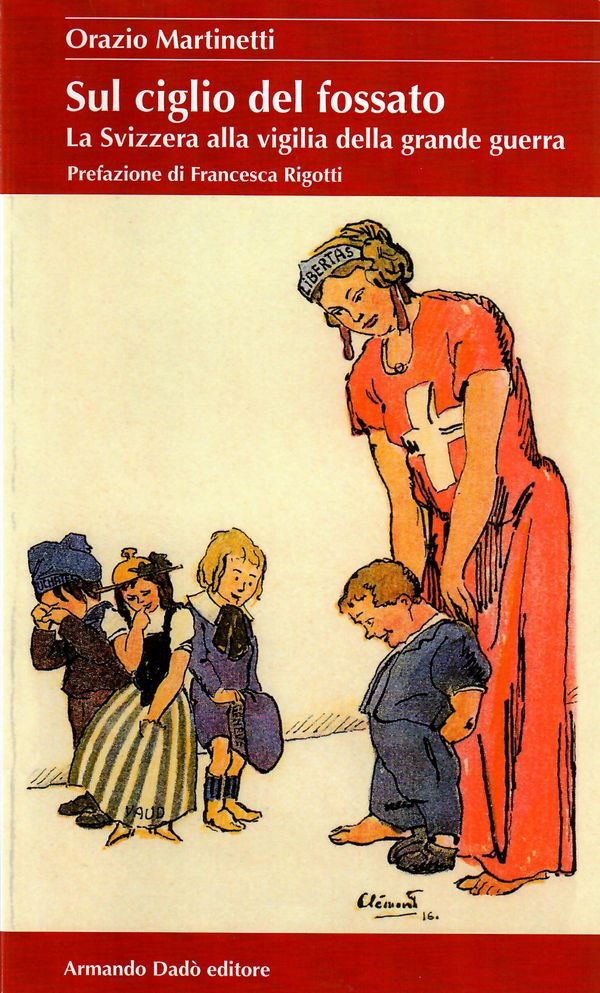Un’annotazione forse un po’ superficiale ma non per questo meno vera: gli studi di Orazio Martinetti ci piacerebbe averli avuti come libri di testo sui banchi del liceo. Agili, scritti con uno stile piano che non disdegna anche piccoli spunti di humor, ci mettono sotto gli occhi una ricca e originale documentazione per offrirci un punto di vista chiaro e largo sugli avvenimenti che caratterizzano la storia del nostro Cantone. Senza perdere in rigore scientifico si leggono con grande piacere e curiosità.
Nel caso di questo suo ultimo Sul ciglio del fossato. La Svizzera alla vigilia della grande guerra Martinetti ci offre una ricerca dal taglio estremamente personale sulle vicende di inizio 900, avvenimenti e pensieri così importanti e così fondanti per la storia sociale europea del secolo scorso. Particolare la sua prospettiva di osservazione: per parlare di questo momento, apparentemente circoscritto e relativamente breve, il ricercatore prende le mosse da più lontano, fino ad andare a ricostruire fili che convergono poi nel periodo da lui scelto. La sua analisi, in altre parole, mette in rilevo le grandi questioni che hanno occupato la storia europea e ne segue le articolazioni giù giù fino alla Svizzera e poi al Ticino. Mostrandoci come gli avvenimenti che hanno interessato le nostre regioni fossero mossi da dinamiche complesse e «globali» di cui, forse, non siamo stati abituati a vedere i collegamenti.
Per costruire il suo lavoro Martinetti compie una ricognizione ampia nel mondo culturale elvetico: grazie al suo libro scopriamo come le discussioni attorno all’identità ticinese, che hanno occupato tante pagine nei lavori degli storici di casa nostra, avevano corrispettivi importanti nell’opera di alcuni studiosi della Svizzera romanda e di quella tedesca. I quali si interrogavano sull’identità svizzera. Un grande puzzle si combina insomma, inglobando e ordinando le esperienze di Ernest Bovet e della sua rivista «Wissen und Leben»; di Gonzague de Reynold e della sua Nuova Società Elvetica; degli storici Jakob Schöllenberger, Christoph Luchsinger e altri. Martinetti ci riassume opere assolutamente interessanti e poco conosciute da noi, come il saggio Le peuple tessinois di Eduard Platzhoff-Lejeune, pubblicista che appare sui libri di storia ticinese prevalentemente quale giornalista della «Tessiner Zeitung» e per un breve periodo direttore del «Corriere del Ticino».
E per quanto riguarda le vicende del Ticino, la ricerca di Martinetti non trascura di inglobare gli avvenimenti e i movimenti sociali che hanno interessato la società italiana, e che hanno inevitabilmente influenzato idee e persone anche nel nostro cantone. Si tratta quindi di uno studio che, nonostante la sua mole contenuta, compone con spunti originali e documenti poco conosciuti un quadro ampio e ricco di suggerimenti. Secondo l’immagine stessa con cui Martinetti descrive il suo lavoro, l’osservazione ci presenta l’interazione reciproca di tre cerchi concentrici (l’Europa, la Svizzera, il Ticino) in cui i movimenti di idee e le decisioni politiche si riflettono da un piano all’altro creando dinamiche sociali e culturali di cui è importante essere coscienti, anche perché sembrano in qualche modo continuare ad influenzare, ancora oggi, la percezione del mondo in cui viviamo.